« Juges partout, démocratie nulle part! | Page d'accueil | Unverdienter Sieg »
samedi, 08 novembre 2014
Virgilio ed Enea: l’etica dell’origine che è destino

Roma, 15 ott – Il 15 ottobre del 70 a.C., esattamente 2083 anni fa, nasceva ad Andes, presso Mantova, Publio Virgilio Marone, più noto semplicemente come Virgilio. Per riassumere al meglio la sua attività letteraria, così recita l’epitaffio inciso sul suo sepolcro napoletano che, secondo alcune testimonianze, fu lo stesso grande poeta a dettare: «cantai pascoli, campi ed eroi». Il riferimento è alle sue opere più famose, cioè le Bucoliche, le Georgiche e l’Eneide. A ben rifletterci, Virgilio ci sta in realtà dicendo che, con i suoi versi, altro non ha cantato se non la civiltà romana nel suo complesso. L’uomo romano infatti, secondo la tradizione, è pastore, agricoltore e guerriero. È milizia e lavoro. È l’aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende.
Roma, Italia, Impero
Il momento storico in cui Virgilio vive ed opera è poi molto particolare. Nel cenacolo culturale del ricco e potente Mecenate, stretto consigliere dell’imperatore e generoso patrono di letterati per antonomasia, Virgilio si imbeve e contribuisce ad alimentare il grande entusiasmo per il ritorno a una nuova età dell’oro, inaugurata dalla celebrata figura di Augusto, il quale aveva posto fine alle terribili guerre civili. E il cosiddetto saeculum augustum coincide altresì con un fatto storico di portata epocale: l’identificazione giuridica e morale di Roma con l’Italia. A seguito della «guerra sociale» (91-88 a.C.) e del conferimento da parte di Cesare della cittadinanza anche agli abitanti della Gallia transpadana (49 a.C.), i popoli italici sono a tutti gli effetti cittadini romani. Si trattò in buona parte di un riconoscimento doveroso: fu infatti l’esercito romano-italico a conquistare nell’arco di due secoli l’impero mediterraneo di Roma. Cittadini romani e alleati italici (socii) avevano combattuto, erano morti e avevano trionfato insieme, ponendo le basi del dominio incontrastato dell’Urbe nel mondo allora conosciuto.
Di qui la formazione di una base sociale che Cesare e Ottaviano (poi Augusto) seppero mobilitare per la propria causa, offrendo alle aristocrazie municipali e ai soldati italici la possibilità di partecipare da protagonisti alla gestione del potere. Non è quindi un caso se i letterati cosiddetti «augustei» che cantarono la gloria di Roma siano tutti Italici che col destino dell’Urbe oramai si identificavano: dall’etrusco Mecenate al Virgilio mantovano, dal lucano Orazio al Tito Livio patavino (cioè padovano). L’Italia romana è dunque una realtà morale, prima ancora che territoriale e giuridica, che si è forgiata nel sacro fuoco di amore e guerra.
La potenza dell’epica che si fa mito
Se non si coglie questo dato, non è possibile comprendere a fondo la genesi e il significato dell’Eneide, l’indiscusso capolavoro virgiliano a cui il vate della romanità lavorò per ben 10 anni. La prospettiva filologica, storiografica, artistica, antropologica, archeologica, in effetti, è legittima e utile, ma al tempo stesso limitante. Si può certamente discutere del decisivo influsso omerico, dei topoi del genere epico, del carattere ideologico e filo-augusteo dell’opera. Così come si possono distinguere nell’Eneide le stratificazioni e le sovrapposizioni di diversi materiali mitologici: l’arrivo dei conquistatori indoeuropei nella penisola italica oppure la fusione della leggenda greca sulle origini di Roma (approdo di Enea nel Lazio) con quella indigena (fondazione romulea dell’Urbe). Si può addirittura vedere nello scontro tra Troiani e popoli autoctoni una metafora letteraria della guerra sociale o delle recenti e sanguinose guerre civili. Tutto ciò – si diceva – è legittimo e anzi utilissimo. Così facendo, tuttavia, resterebbe inaccessibile il cuore pulsante dell’operazione virgiliana.
Proprio perché, al di là di tutte le letture e le interpretazioni, bisogna ricordarsi che, assemblando materiali disparatissimi, Virgilio ha coscientemente voluto non replicare, ma fondare un mito. Un mito che non è affatto mera «favola» – come potrebbe suggerire un approccio aridamente e stancamente storicistico – ma piuttosto immagine originale (e originaria) di sé stessi. L’Eneide, infatti, è l’immagine, sublimata in esametri e canto, che il popolo romano aveva delle proprie origini e quindi del proprio avvenire. E Virgilio, con la sua impresa metapolitica e mitopoietica, ne è stato il sommo vate, ossia colui che, con impareggiabile maestria, ha saputo dar voce e immortalità all’orgoglio della Roma imperiale.
Origine, avvenire, rivoluzione
Un dato, in particolare, va evidenziato. L’epica greca arcaica aveva presto sviluppato un tipico genere letterario, quello dei nóstoi, che narrava dei «ritorni» degli eroi achei nelle loro patrie d’origine al termine della guerra di Troia. Il nóstos più famoso resta, ovviamente, l’Odissea, in cui Odìsseo/Ulisse, dopo un lungo e tribolato peregrinare, approda finalmente a Itaca, suo regno avito e dominio primigenio. Qui il re dovrà sfidare e sconfiggere i «proci», cioè i pretendenti alla mano della regina Penelope e, di conseguenza, al trono. Grazie alla vittoria Ulisse ristabilisce la sua sovranità regale, ripristina la condizione iniziale e legittima. Il suo ritorno è, a tutti gli effetti, restaurazione. Per Enea e i Teucri, invece, la situazione è ben diversa. L’origine, infatti, non sta dietro, ma innanzi a loro. Dalle fiamme distruttrici e dalle ceneri di Troia, dove tutto è morte che sembra annunciare la fine della gloriosa stirpe di Dardano, si dischiude all’improvviso la possibilità di un nuovo inizio, di una nuova origine. Un’origine che è destino, che è fondazione, che è rivoluzione.

In questo vuoto abissale di riferimenti, tutte le coordinate vengono meno. Tutto diviene incerto e indefinito, gli unici indizi si celano dietro agli enigmatici responsi dell’Apollo di Delo. Le sole certezze di Enea sono quindi il padre Anchise e il figlioletto Iulo/Ascanio, che egli è riuscito disperatamente a sottrarre alla morte in quella terribile notte che ha cambiato tutto. Anchise infatti, nell’olocausto di Troia, ha messo in salvo le sacre immagini dei Penati, ossia gli dèi protettori della patria annientata, e rappresenta il legame non del tutto reciso con la tradizione dei padri, i quali non a caso sveleranno in sogno ad Enea la giusta destinazione del suo viaggio, ossia l’Italia, antica patria di Dardano, «gran madre di messi, terra sacra a Saturno, gran genitrice d’eroi» (Georgiche, II 173-174). Il piccolo Iulo, invece, è la fondamentale garanzia della continuazione della stirpe, quella «progenie di eletta virtù che tutto intero dovrà con le armi dominare l’universo» (Eneide, VII 257-258). Memoria delle origini e volontà d’avvenire, dunque, sono le uniche cose che Enea ha voluto portare con sé prima di salpare verso il regno dell’ignoto. Eppure il sommo Giove – pregato da Venere, madre divina dell’eroe, e nonostante l’«ira tenace della crudele Giunone» – va oramai preparando il destino di Enea e della futura grandezza di Roma.
Il destino come decisione
Sul concetto-chiave di «fato» va fatta chiarezza. La critica moderna ha infatti spesso sopravvalutato eccessivamente il suo carattere vincolante, dipingendo talvolta Enea come un mero strumento passivo di una volontà che lo trascende e tirannicamente lo condiziona. Se è vero che il fato si traduce spesso in iussa, ovverosia in comandamenti e mandati degli dèi (i quali, non va dimenticato, allo stesso fato sono soggetti), esso tuttavia non rappresenta affatto una sorte inevitabile. L’eroe, al contrario, può sempre decidere di accettare o rifiutare i piani che Giove ha concepito. Enea, infatti, avrebbe ben potuto rimanere in Africa con Didone, la regina dei Cartaginesi che, con le nozze, gli aveva offerto regno e potenza. Esercitando la sua libertà storica, Enea avrebbe potuto cioè rinunciare al suo mandatum, alla sua missione, alla sua natura eroica. Eppure, esortato da Mercurio, Enea sceglie infine di tener fede all’originaria promessa d’avvenire, ossia alla speranza dell’erede Iulo «a cui spettano il regno d’Italia e la terra romana» (IV 275-276).

In altre parole, l’eroe rimane fedele al suo destino di lotta e vittoria. Esattamente in questo senso Enea è pius. Perché ha consapevolmente deciso di farsi carico dei fata, dei disegni degli dèi che gli promettono potenza e gloria imperitura. Questo fato, quindi, altro non è che «sacro vincolo destino», ossia destino liberamente accettato, bramato, voluto: «Ma il mio proprio valore, i santi oracoli degli dèi e gli avi consanguinei […] hanno conformato la mia volontà al destino» (VIII 131-133). In questo sta la natura tragica, e dunque sublime, della decisione di Enea, e cioè nella tensione costante e inesausta di necessità e libertà, di dovere e volontà. Una tensione che la modernità liberal-capitalistica non riesce più a tollerare, disconoscendo l’essenza intrinsecamente tragica dell’uomo e cadendo, pertanto, nella farsa. Enea invece, proprio perché è pius, decide infine, carico di destino, di riappropriarsi di sé stesso e, dunque, del suo glorioso avvenire. Un avvenire che, come gli svelerà la Sibilla cumana, egli dovrà conquistarsi con la sola forza delle armi e del proprio coraggio: «Guerre, orrende guerre e il Tebro distinguo schiumante di molto sangue. […] Tu non cedere ai mali, ma affrontali con audacia ben oltre i limiti della tua sorte» (VI 86-87; 95-96). Come sempre è l’eroe, armato di coraggio e volontà, che deve far forza alla Fortuna per affermare sé stesso, per divenir veramente sé stesso, per forgiare il suo destino.
La «pietà» di Enea
Anche sul concetto centrale di pietas è necessario soffermarsi brevemente. Essa, innanzitutto, non ha nulla a che vedere con la «pietà» cristiana che ha impregnato il nostro linguaggio, ossia la devozione e l’obbedienza del credente a Jahvè e, più comunemente, la misericordia verso il prossimo. La pietas romana, invece, è fedeltà e devozione alla propria cultura e al proprio sistema di valori, in particolare nel rapporto con la famiglia, la patria e gli dèi. I Romani sono il popolo più forte proprio perché hanno istituito la pax deorum, ossia più degli altri hanno tenuto fede alla tradizione dei loro padri e al volere delle loro divinità. Ed Enea, con la sua scelta decisiva di assolvere i fata degli dèi, è indicato da Virgilio come il fondatore di questa alleanza con le forze celesti, le quali, in cambio, donano a Roma potenza e dominio sulle genti.
Non a caso il «pio» Enea è anche e soprattutto il pater Enea, ossia il padre comune del suo popolo e, insieme, la massima autorità religiosa e sacerdotale. Perché la pietas si esprime anche nella corretta celebrazione dei riti, nei doverosi omaggi agli dèi in cui l’eroe vede rispecchiata la sua grandezza. Nessuna misericordia, dunque, ma giustizia inflessibile, volontà di potenza e fedeltà assoluta alla propria stirpe: questa è la pietas di cui i Romani andavano fieri. Per tale motivo alcuni gesti estremi di Enea come le brutali uccisioni di Turno, Lauso e Tarquito, che appaiono «spietati» alla sensibilità dell’Occidente egualitarista, non sono affatto «empi» per la cultura romana, e anzi esprimono la più radicale e coerente aderenza del pius Enea alla tradizione dei suoi padri, alla volontà dei suoi dèi, alla sua etica guerriera.
Il tempo del mito e degli eroi
Nel viaggio periglioso verso l’Italia e nella terribile guerra contro gli Ausoni si compie dunque il destino di Enea, dei Troiani superstiti e di quella Roma ancora da fondare. La successione lineare del tempo si sfalda: passato, presente e futuro si sincronizzano, in particolare nella discesa di Enea nel regno di Dite, dove il defunto padre Anchise gli mostra sia gli eroi della nobile stirpe di Teucro, sia coloro che, non ancora nati, renderanno grande Roma nei secoli avvenire. Anchise consegna quindi ad Enea, sul quale tutto il tempo cosmico converge, la missione universale della Roma che verrà: «Altri plasmeranno con maggiore eleganza spirante bronzo (ben lo concedo), trarranno dal marmo vivi volti, patrocineranno meglio le cause, seguiranno con il compasso i percorsi del cielo e prediranno il corso degli astri. Ma tu ricorda, o Romano, col tuo imperio di dominar le genti. Queste saranno le tue arti: imporre un ordine alla pace, risparmiare i sottomessi e sterminare i superbi» (VI 847-853).
Il fato dell’antica Troia e della nuova Roma è tutto nelle mani di Enea. Anzi, è nel suo scudo, forgiato in oro nella fucina di Vulcano. Su di esso si staglia e rifulge il glorioso futuro della progenie di Venere e Marte, ossia dei figli di amore e guerra: «Qui il Signore del fuoco, non ignaro dei vaticini e non inconsapevole del tempo avvenire, aveva effigiato le gesta italiche e i trionfi dei Romani, qui tutta la discendenza futura, dal sangue di Ascanio, e in ordine le guerre combattute. […] Qui Cesare Augusto che guida in battaglia gli Italici, coi padri e il popolo, i Penati e i grandi dèi. […] Simili spettacoli nello scudo di Vulcano, dono della madre, ammira Enea, e pur ignaro degli eventi si diletta della loro immagine, portando sul braccio la gloria e i destini della stirpe» (VIII 626-629; 678-679; 729-731). Una stirpe di fuoco e dello stesso sangue degli dèi.
Lotta, vittoria, rigenerazione
La guerra che oppone i Troiani e i loro alleati alla coalizione italica, capeggiata da Turno re dei Rutuli, è quanto mai brutale. I due popoli, dalla cui unione sorgerà la progenie della città eterna, devono prima combattersi per poi riconoscersi fratelli. Nessun patetico «contratto sociale», quindi, ma solo il suggello del sangue e delle armi può dar vita alla stirpe che dominerà il mondo. È il sangue dei caduti che feconda la patria e rigenera la storia: «Andate – soggiunse Enea – e onorate con i più alti tributi le anime generose che con il loro sangue ci hanno generato questa patria» (XI 24-25). L’apparente fine è in realtà un nuovo inizio: tutto deve crollare per poi risorgere più forte. I Troiani vittoriosi, infatti, rinunciano al loro nome e si fondono con i popoli d’Ausonia. Il seme della nuova stirpe e della futura gloria dell’Urbe è gettato, come la stessa Giunone dovrà annunciare: «Sia possente la discendenza romana per l’italico valore» (XII 827). Solo dal connubio di Roma e Italia – come si diceva all’inizio – può nascere quel popolo che «per pietas supererà le genti, supererà gli dèi» (XII 839). Solo dalla fusione di Roma e Italia può nascere l’Impero.
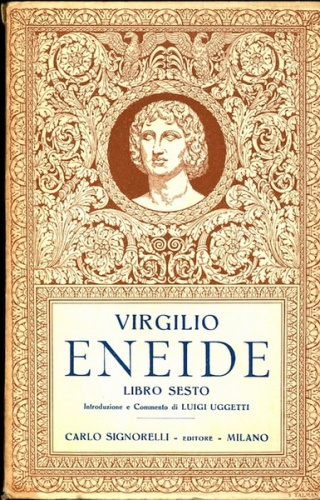
Per tale motivo risulta ancor più incredibile che gli italiani abbiano rimosso queste loro nobili origini, che rappresentano invece la più esaltante avventura storica dell’uomo europeo. Oggi, anzi, si guarda con grande sospetto e diffidenza verso ogni mito informatore e ogni volontà storificante del popolo italiano, continuamente umiliato da 70 anni di martellante propaganda antinazionale. Anche nel migliore dei casi, inoltre, si ricorre spesso a complessi fenomeni di transfert: si ricerca il proprio mito fondativo, cioè, nelle oscure caverne dei Nibelunghi, nei pionieri americani che colonizzano il «selvaggio ovest» oppure negli aridi deserti della Palestina. Non sembra esserci posto, quindi, per Enea e le meravigliose terre d’Italia, benedette da Saturno e baciate dal sole, le quali rendono tanto familiare lo sfondo quanto mai suggestivo della narrazione dell’Eneide.
Eppure, in accordo con la visione sferica del tempo (il tempo storico specificamente umano), solo il popolo con la memoria più lunga potrà avere il più grande futuro. Gli italiani, che piaccia o meno, avranno sempre la facoltà di attingere al loro glorioso passato per proiettarsi in un grandioso avvenire. Anche nelle epoche dell’oblio e della rimozione forzata può riemergere, in qualsiasi momento, la sua memoria latente e, insieme, la possibilità di una nuova origine, di un nuovo inizio. E Virgilio, con la sua epica sublime, ci ha lasciato la più alta espressione di questa formidabile volontà di destino.
Gli italiani, dunque, potranno sempre riappropriarsi della loro memoria più remota e quindi del loro più fulgido avvenire, ossia di quella «Terza Roma» che fu già profetizzata da Giuseppe Mazzini e da Alfredo Oriani. Sembra anzi come inscritta nel nostro sangue questa peculiarità di rigenerare continuamente noi stessi come popolo. Così infatti D’Annunzio salutava l’Italia: «o Semprerinascente, o fiore di tutte le stirpi, aroma di tutta la terra Italia! Italia, sacra alla nuova Aurora con l’aratro e la prora». Gli italiani, dopotutto, non hanno conosciuto altro che «rinascimenti», «rinascenze», «risorgimenti». Piaccia o meno ai profeti del nulla e della «fine della storia», dunque, il mito virgiliano di Enea, scardinando la meccanica temporale, continuerà a vivere in noi come un’eco remota che, risuonando nei millenni, ci ingiunge, ancora una volta, di rivendicarne la grandezza. Nella storia del popolo italiano sarà sempre possibile l’irruzione dell’origine come destino. Come marmo che vince la palude.
Valerio Benedetti
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : énée, virgile, littérature, littérature latine, lettres, lettres latines, latin, philologie classique, tradition, traditionalisme, rome, rome antique, rome impériale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



Les commentaires sont fermés.