Intervista con Niccolò Rapetti
Ex: https://ragionipolitiche.wordpress.com
La complessità e la irriducibilità a formule del pensiero politico di Carl Schmitt sono immediatamente evidenti guardando alla sua travagliata fortuna scientifica. Si tratta innanzitutto di un reazionario cattolico, un conservatore compromesso nel regime hitleriano; negli anni però la sua critica anti-imperialista e anti-liberale ha iniziato a piacere molto anche alla sinistra e pur nel suo evidente anti-americanismo il suo libro Il nomos della Terra è oggi lettura obbligata per gli ufficiali di marina americana. Professor Carlo Galli, mi viene spontanea una domanda: di chi è Carl Schmitt?
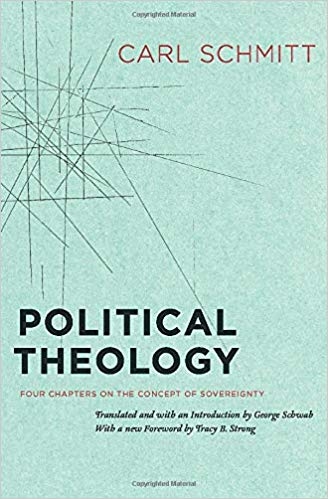 È un grande giurista del diritto pubblico e del diritto internazionale, che ha avuto il dono di un pensiero veramente radicale, e la sorte di vivere in un secolo di drammatici sconvolgimenti intellettuali, istituzionali e sociali. Ciò ne ha fatto anche un grande filosofo e un grande scienziato della politica; e lo ha esposto a grandi sfide e a grandi errori.
È un grande giurista del diritto pubblico e del diritto internazionale, che ha avuto il dono di un pensiero veramente radicale, e la sorte di vivere in un secolo di drammatici sconvolgimenti intellettuali, istituzionali e sociali. Ciò ne ha fatto anche un grande filosofo e un grande scienziato della politica; e lo ha esposto a grandi sfide e a grandi errori.
È innanzitutto necessario chiarire la posizione di Schmitt nella storia delle idee e del diritto: Carl Schmitt è «l’ultimo consapevole rappresentante dello jus publicum europaeum, l’ultimo capitano di una nave ormai usurpata». Che cos’è lo jus publicum europaeum? Come e quando inizia il suo declino, che Schmitt attraversò «come Benito Cereno visse il viaggio della nave pirata»?
Lo jpe è l’ordine del mondo eurocentrico della piena modernità; un ordine che è anche Stato-centrico, al quale Schmitt sa di appartenere anche se è ormai in rovina. Un ordine, per di più, che egli stesso decostruisce, mostrando che si fondava sul disordine, cioè non solo sull’equilibrio fra terra e mare ma anche sulla differenza di status fra terra europea e terre extra-europee colonizzate. Il declino di quell’ordine nasce quando si perde la consapevolezza della sua origine di crisi: quando l’uguaglianza formale fra Europa e non-Europa viene affermata nelle teorie (gli universalismi dell’economia, del diritto, delle teorie politiche democratiche e della morale) e nella pratica (l’imperialismo delle potenze anglosassoni, la loro – interessata – esportazione del capitalismo e della democrazia). Cioè per Schmitt dai primi anni del XX secolo.
Come si coniugano gli elementi «febbrilmente apocalittici» (teologia) e quelli «causticamente razionali» (diritto) nel pensiero politico di Carl Schmitt? In che posizione si trova il giurista Schmitt nei confronti di tecnica e teologia, diritto positivo e katechon?
Schmitt non è un apocalittico in senso proprio, nonostante sia così interpretato da Taubes. La teologia è, nel suo pensiero, un punto di vista, sottratto all’immanenza moderna, a partire dal quale comprendere diritto e politica, e le loro dinamiche. La teologia non ha la pretesa di essere una sostanza fondativa (Schmitt non è un fondamentalista) ma è anzi la consapevolezza dell’assenza di sostanza (di Dio), nell’età moderna. Questa assenza, che Schmitt reputa irrimediabile, è la spiegazione del fatto che la modernità è instabile, e che il suo modo d’essere è l’eccezione: questa richiede la decisione perché si possano formare ordini, e continua a vivere dentro gli ordini e le forme, che quindi non possono mai essere chiusi, razionali, neutralizzati. Da ciò deriva anche l’importanza del potere costituente, ovvero dell’atto sovrano che fonda un ordine a partire da una decisione reale sull’amico e sul nemico. E da ciò anche la tarda insistenza sulla terra (sulla concretezza spaziale) come possibile fondamento stabile degli ordini.
Considerando la distinzione politica fondamentale Freund-Feind, che opinione può avere Schmitt di tendenze fondamentali del suo e del nostro tempo, universalismo e pacifismo, che escludono per definizione l’idea di nemico?
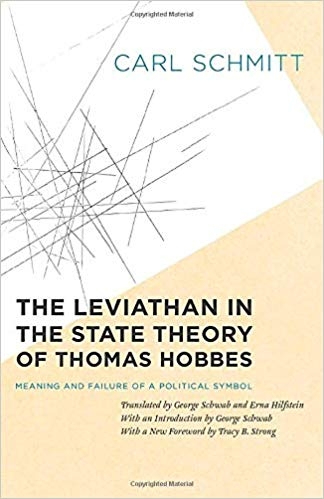 Schmitt pensa – e lo spiega in tutta la sua produzione internazionalistica, dal 1926 al 1978 – che ogni universalismo e ogni negazione della originarietà del nemico siano un modo indiretto per far passare una inimicizia potentissima moralisticamente travestita, per generare guerre discriminatorie. Per ogni universalismo chi vi si oppone è un nemico non concreto e reale ma dell’umanità: un mostro da eliminare. Perché ci sia pace ci deve essere la possibilità concreta del nemico, non la sua criminalizzazione, secondo Schmitt.
Schmitt pensa – e lo spiega in tutta la sua produzione internazionalistica, dal 1926 al 1978 – che ogni universalismo e ogni negazione della originarietà del nemico siano un modo indiretto per far passare una inimicizia potentissima moralisticamente travestita, per generare guerre discriminatorie. Per ogni universalismo chi vi si oppone è un nemico non concreto e reale ma dell’umanità: un mostro da eliminare. Perché ci sia pace ci deve essere la possibilità concreta del nemico, non la sua criminalizzazione, secondo Schmitt.
Dopo aver annunciato la morte dello Stato nel saggio Il Leviatano di Hobbes, Schmitt teorizzò un’alternativa al potere statale, adeguata alla nuova concezione globale del pianeta che conservando la natura plurale del politico, potesse compiere la grande impresa «degna di un Ercole moderno»: domare la tecnica scatenata. Stiamo parlando dei Grandi Spazi, la cui formulazione è contenuta nella conferenza L’ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale scritto nel 1939. Ce ne può parlare?
Il Grande Spazio, o Impero, è la risposta di Schmitt al Lebensraum nazista. Non ha caratteristiche biologiche, ma è in pratica la proposta di egemonia di una forma politica all’interno di uno spazio geografico-politico in cui continuano a esistere altre forme politiche non pienamente sovrane. Il GS è più che una sfera d’influenza, perché è gerarchicamente organizzato al proprio interno e perché è chiuso a influenze esterne; ed è diverso dallo Stato perché non è del tutto omogeneo giuridicamente: perché non è un «cristallo». I GS sono i soggetti di una concezione plurale delle relazioni internazionali; le due superpotenze del secondo dopoguerra, invece, per Schmitt erano due universalismi (capitalismo e comunismo) in lotta fra di loro e in instabile equilibrio.
Negli interrogatori dell’immediato dopoguerra Schmitt difese strenuamente la propria concezione del nuovo ordinamento spaziale chiarendone la differenza rispetto alla vera dottrina politica del Terzo Reich cioè lo spazio vitale razziale-biologico. È però indubbio che nel grande spazio come pensato da Schmitt si annidi un antisemitismo coerente con ciò che è condizione sine qua non della teoria: un rapporto forte e concreto tra etnia-popolo e terra civilizzata. Il nemico quindi, per Schmitt, non è l’ebreo in quanto Un-mensch (sotto-uomo, razza inferiore), ma l’«ebreo assimilato» che si pone come elemento sradicante della territorialità e della concretezza di una cultura. Dove sta allora la verità, che cosa direbbe sull’imputato e sull’imputazione: ideologia o scienza?
In Schmitt ideologia e scienza non sono distinguibili: ogni scienza è orientata, storica; è affermazione di un ordine concreto, oltre che ricostruzione genealogica degli ordini. L’antisemitismo, poi, è presente in tracce più o meno evidenti in buona parte della filosofia tedesca – da Hegel a Schopenhauer, da Marx a Heidegger –, in forme diverse e con significati diversi; nei grandi filosofi non è mai determinante – ovvero, non è il motivo che dà origine al filosofare –: l’ebreo è utilizzato come un esempio di non-appartenenza, di individualistico sradicamento, di coscienza infelice e al contempo aggressiva. Il capitalismo, il socialismo e la tecnologia sono spiegati anche (certo, non soltanto – soprattutto nel caso di Marx –) attraverso l’ebraismo, insomma. Questo atteggiamento – che è presente con forse maggiore virulenza anche nella destra francese – è ai nostri occhi gretto, insensato, pericolosissimo e tendenzialmente criminale. Schmitt, come persona, è stato antisemita in seguito al suo cattolicesimo (una delle fonti dell’antisemitismo in Europa; ma anche Lutero era violentemente antisemita), senza però che l’antisemitismo fosse particolarmente rilevante o importante nel suo pensiero; la sua adesione al nazismo, che a suo tempo ha sorpreso tutti, non è dovuta all’antisemitismo ma a un misto di disperazione (per la caduta di Weimar, che aveva cercato vanamente di salvare), di orgoglio (la pretesa di poter guidare il nazismo verso un pensiero «civilizzato» e verso la soluzione della crisi dello Stato) e di ambizione (la chiamata in cattedra a Berlino, la vicepresidenza della associazione dei giuristi tedeschi, il ruolo tecnico rilevantissimo nella stesura di alcune leggi costituzionali come quella dei «luogotenenti del Reich» – 1933 –, la nomina a consigliere di Stato prussiano). Data la struttura radicale del suo pensiero, cioè dato il nichilismo che dopo tutto vi alberga e che gli impedisce ogni valutazione di carattere morale, e dato anche il suo precedente larvato antisemitismo, Schmitt non ha avuto remore nell’adeguarsi all’antisemitismo nazista – ben diverso da ogni altro – che pure non gli apparteneva, e che ha prodotto effetti terribili e grotteschi nei testi da lui scritti dal 1933 al 1936 (anno della crisi del suo rapporto con il regime), con alcuni strascichi nel libro hobbesiano del 1938 e nei testi «segreti» del primo dopoguerra (in realtà scritti per essere pubblicati postumi). In generale, per lui l’ebraismo è un altro nome del liberalismo (il problema è che nella fase nazista è trattato come la causa del liberalismo). La responsabilità politica, morale e storica è tutta sua; gli studiosi devono sapere che la forza del suo pensiero sta altrove, e al tempo stesso devono sapere che quel pensiero è indifeso davanti a questo tipo di aberrazioni (ma anche ad altre analoghe, di altro segno).
 Carl Schmitt si è spento nel 1985 a Plettenberg in Westfalia alla veneranda età di 97 anni. Ciò significa che il suo sguardo non supera la «cortina di ferro» e si estende solo alla realtà della guerra fredda. Anche durante questo delicato periodo Schmitt ha continuato la sua attività di studioso e attento indagatore delle questioni di diritto internazionale dei suoi anni. Si espresse quindi sul dualismo USA-URSS, vedendo in esso una tensione verso l’unità del mondo nel segno della tecnica che avrebbe sancito l’egemonia universale di un «Unico padrone del mondo». Superando il 1989, e guardando al presente, possiamo dire che gli Stati Uniti dopo il ’91 hanno definitivamente preso scettro e globo in mano? L’American way of life è il futuro o il passato? Già Alexandre Kojève, per esempio, parlava di un nuovo attore politico e culturale e di una possibile «giapponizzazione dell’occidente».
Carl Schmitt si è spento nel 1985 a Plettenberg in Westfalia alla veneranda età di 97 anni. Ciò significa che il suo sguardo non supera la «cortina di ferro» e si estende solo alla realtà della guerra fredda. Anche durante questo delicato periodo Schmitt ha continuato la sua attività di studioso e attento indagatore delle questioni di diritto internazionale dei suoi anni. Si espresse quindi sul dualismo USA-URSS, vedendo in esso una tensione verso l’unità del mondo nel segno della tecnica che avrebbe sancito l’egemonia universale di un «Unico padrone del mondo». Superando il 1989, e guardando al presente, possiamo dire che gli Stati Uniti dopo il ’91 hanno definitivamente preso scettro e globo in mano? L’American way of life è il futuro o il passato? Già Alexandre Kojève, per esempio, parlava di un nuovo attore politico e culturale e di una possibile «giapponizzazione dell’occidente».
Lascerei da parte Kojève, a suo tempo affascinato da Schmitt ma studioso di tutt’altra provenienza e di altre ambizioni. Quanto al resto, non è vero che gli Usa siano stati i padroni solitari del mondo, se non forse negli anni Novanta quando hanno affermato che il cuore del nomos della Terra è il benessere del cittadino americano. Hanno esportato la democrazia, e in realtà il loro capitalismo, ovunque e con ogni mezzo, praticando guerre presentate come azioni di polizia internazionale, con o senza la copertura dell’Onu. Ma hanno anche trovato resistenze ovunque: i terrorismi che spesso hanno armato, e che si sono rivoltati contro di loro; ma anche soggetti geo-politici e geo-economici abbastanza forti da essere in grado di affermare le proprie pretese – Cina, Russia, Iran, la stessa Germania con la sua forza economica di esportazione, solo per fare qualche esempio –. In ogni caso, gli Usa hanno dovuto assumere, dopo la crisi del 2008, una postura difensiva: protezionismo, per difendersi da economie più dinamiche della loro; ritiro militare da aree un tempo strategiche, come parte del Medio Oriente; scarsa propensione a interventi massicci in aree di crisi (che è la vera differenza fra l’amministrazione Trump e quelle democratiche che lo hanno preceduto); severa compressione della omogenea diffusione del benessere nella loro società. Resta invariato il diritto che gli Usa rivendicano ed esercitano di intervenire ovunque nel mondo con azioni mirate contro i loro nemici, che ora come sempre essi criminalizzano. Ma oggi non sono i padroni del mondo: l’Eurasia (Cina e Russia) ha un peso pari a quello dell’Euro-America (a parte il fatto, importantissimo, che entrambe queste macro-realtà sono divise al loro interno).
Al conflitto parziale e regolato tipico dello jus publicum europaeum (1648-1914) Schmitt contrapponeva la moderna guerra discriminatoria condotta per justa causa dove il nemico è concepito come criminale sul piano legale e inferiore moralmente. Le parti in conflitto non si pensano più come justi hostes, nemici reali che si riconoscono reciprocamente come sovrani sui propri confini, ma esprimono una guerra giusta che legittima l’impiego dei moderni mezzi di annientamento. La guerra regolare e circoscritta diventa allora con i due conflitti mondiali, totale e discriminatoria alla stregua di una guerra civile su scala mondiale; una guerra non tra regolari eserciti ma in cui anche i civili e la proprietà privata diventano oggetto di annientamento attraverso i bombardamenti aerei. Eppure in questa lucida e terribile diagnosi Schmitt aveva ancora la forza della speranza e concludendo il Dialogo sul nuovo spazio scrive: «sono convinto che dopo una difficile notte di minacce provenienti da bombe atomiche e simili terrori, l’uomo un mattino si sveglierà e sarà ben felice di riconoscersi figlio di una terra saldamente fondata». La questione, invece, oggi non solo è irrisolta ma si è radicalizzata lasciandoci uno Schmitt spaesato. Come si configura una guerra in un mondo globalizzato dove «le uniche linee generate dall’economia che siano geograficamente leggibili sono quelle degli oleodotti» e la religione torna ad essere politica e fortemente identitaria?
Oggi la guerra non ha più, prevalentemente, le forme della guerra totale che ha assunto nella Seconda guerra mondiale. Ma resta una guerra discriminatoria, come fu quella: democrazia contro terrorismo, Bene contro Male (concetto reversibile, com’è evidente). Nell’età globale, poi, in un mondo reso indistinto dall’omogeneità spaziale richiesta dal capitalismo, con l’ausilio dell’elettronica, si è rafforzata la tendenza verso la guerra discriminatoria, poliziesca, asimmetrica (Stati – e i loro contractors– contro bande armate, in mezzo a popolazioni civili): una guerra globale che scavalca i confini e che piomba dall’alto ovunque siano lesi gli interessi di alcune grandi potenze. Una guerra, certo, che – da entrambi i lati – non rispetta i vecchi parametri: distinzione fra interno ed esterno, fra civile e militare, fra nemico e criminale, fra pubblico e privato, fra religione e politica. Una guerra tanto lontana dai modelli tradizionali che un generale inglese ha potuto scrivere, citando John Lennon, «war is over».
Che cosa rimane dello studio di Schmitt sulla figura del combattente partigiano nell’epoca del terrorismo islamico e delle «crociate» americane per la democrazia e la libertà? Oggi il partigiano è ancora «l’ultima sentinella della terra»?
La figura del partigiano, elaborata da Schmitt nei primissimi anni Sessanta del XX secolo, è uno dei tentativi di pensare il ‘politico’ – in sé destabilizzante – in modo concreto e relativamente stabile: il che è possibile perché il partigiano è tellurico, perché difende un territorio. Il partigiano è portatore di inimicizia reale, non assoluta: combatte per uno scopo, non per mera volontà di distruggere. Non è un terrorista, un figlio dell’universalismo, della tecnica, di una volontà di dominio globale. Se al tempo di Schmitt il partigiano poteva essere il vietcong (il che provocò a Schmitt qualche precoce simpatia a sinistra), oggi non è chiaro dove e con chi possa essere identificato.
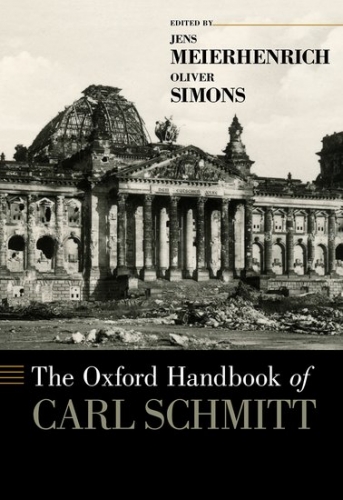 La grande questione dello Schmitt del secondo dopoguerra, concentrato su questioni di diritto internazionale, è l’urgenza di un «nuovo nomos della terra» che supplisca ai terribili sviluppi della dissoluzione dello jus publicum europaeum. Porsi il problema di un nuovo nomos significa considerare la terra come un tutto, un globo, e cercarne la suddivisione e l’ordinamento globali. Ciò sarebbe possibile solo trovando nuovi elementi di equilibrio tra le grandi potenze e superando le criminalizzazioni che hanno contraddistinto i conflitti bellici nel ’900. A scompaginare il vecchio bilanciamento tra terra e mare, di cui l’Inghilterra, potenza oceanica, si fece garante nel periodo dello jus publicum europaeum, si aggiunge, però, una nuova dimensione spaziale: l’aria. L’aria non è solo l’aereo, che sovverte le distinzioni «classiche» di «guerre en forme» terrestre e guerra di preda marittima, ma è anche lo spazio «fluido-gassoso» della Rete. Grazie ai nuovi sviluppi della politica nel mondo si rende sempre più evidente come l’era del digitale non apra solamente nuove possibilità (e nuovi problemi) per l’informazione e la comunicazione, ma si configuri, nella grande epopea degli uomini e della Terra, come l’ultima, grande, rivoluzione spaziale-globale. Come possono rispondere le categorie del nomos di Carl Schmitt al nuevo mundo del digitale?
La grande questione dello Schmitt del secondo dopoguerra, concentrato su questioni di diritto internazionale, è l’urgenza di un «nuovo nomos della terra» che supplisca ai terribili sviluppi della dissoluzione dello jus publicum europaeum. Porsi il problema di un nuovo nomos significa considerare la terra come un tutto, un globo, e cercarne la suddivisione e l’ordinamento globali. Ciò sarebbe possibile solo trovando nuovi elementi di equilibrio tra le grandi potenze e superando le criminalizzazioni che hanno contraddistinto i conflitti bellici nel ’900. A scompaginare il vecchio bilanciamento tra terra e mare, di cui l’Inghilterra, potenza oceanica, si fece garante nel periodo dello jus publicum europaeum, si aggiunge, però, una nuova dimensione spaziale: l’aria. L’aria non è solo l’aereo, che sovverte le distinzioni «classiche» di «guerre en forme» terrestre e guerra di preda marittima, ma è anche lo spazio «fluido-gassoso» della Rete. Grazie ai nuovi sviluppi della politica nel mondo si rende sempre più evidente come l’era del digitale non apra solamente nuove possibilità (e nuovi problemi) per l’informazione e la comunicazione, ma si configuri, nella grande epopea degli uomini e della Terra, come l’ultima, grande, rivoluzione spaziale-globale. Come possono rispondere le categorie del nomos di Carl Schmitt al nuevo mundo del digitale?
Se Schmitt non è solo il pensatore del conflitto indiscriminato, ma di un conflitto che è destinato a produrre un ordine, sia pure transitorio e mai neutrale, è chiaro che allora non convive bene né col capitalismo mondializzato, né con la tecnica globalizzata, né con la dimensione fluida e virtuale della Rete. In realtà, un significato contemporaneo di Schmitt sta in varie altre circostanze: inizia un’età post-globale, e per molti versi post-liberaldemocratica (ma non necessariamente post-statuale), contrassegnata da un nuovo pluralismo politico fra Grandi Spazi (non chiusi economicamente, però: questo è il problema) e quindi da un nuovo rilievo delle logiche geopolitiche e geostrategiche (di cui Schmitt è stato interprete originale e non pedissequo); nascono nuove richieste di sovranità anche in Occidente, dove prima regnava l’ideologia del mercato; la gestione della politica è sempre più spesso affidata a esecutivi forti, che agiscono attraverso «stati d’eccezione» più o meno espliciti; le dinamiche dell’esclusione interna verso i «diversi» si fanno più esplicite e il conflitto si fa più aspro (anche su questioni simboliche di fondo). Ma più ancora che di una importanza di Schmitt per decifrare il presente, è da sottolineare il suo grandissimo rilievo per decifrare la modernità e la sua crisi; per ri-codificare e ri-trascrivere la storia intellettuale, istituzionale e politica degli ultimi tre secoli (si pensi solo ai suoi libri sul parlamentarismo, sulla dittatura, sulla costituzione); per criticare genealogicamente e per decostruire il razionalismo e il pensiero dialettico. È questo rilievo critico – da assumere in modo non a-critico – a spiegare l’immensa fortuna attuale di Schmitt nella letteratura scientifica, filosofico-politica, a livello davvero mondiale, tanto a destra quanto a sinistra, tanto in Europa quanto nelle Americhe e in Asia: attraverso Schmitt si ri-pensa il rapporto fra ragione e politica, fra opacità e trasparenza, fra conflitto e ordine.





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
Les commentaires sont fermés.