mardi, 03 mai 2011
Sparta e i Sudisti nel pensiero di Maurice Bardèche
Sparta e i Sudisti nel pensiero di Maurice Bardèche
Cognato di Robert Brasillach, fucilato al termine della seconda guerra mondiale per aver collaborato coi nazisti; allievo di quel Charles Maurras, che il Nolte ha giudicato, insieme a Hitler e Mussolini, la più rappresentativa figura del fascismo a livello europeo; fermo sostenitore del governo di Vichy e della politica del maresciallo Pétain: tutto questo e altro ancora è stato Maurice Bardèche, saggista, giornalista e critico d’arte di levatura nazionale e internazionale, ma fascista impenitente, che si firmava appunto come «scrittore fascista».
Avendo votato la sua vita, dopo la Liberazione (o sedicente tale), alla riabilitazione della memoria di Brasillach – la cui esecuzione aveva definito un assassinio legalizzato – e, in genere, alla riabilitazione del collaborazionismo di Vichy e del fascismo in quanto tale, dovette subire l’ostracismo della cultura ufficiale e fondare una propria casa editrice, per mezzo della quale condusse una battaglia incessante per diffondere i suoi ideali.
Egli ebbe il coraggio di fare apertamente quello che altri fecero un po’ di soppiatto o che addirittura rinnegarono: continuò a professare i valori di un tempo e non venne mai a patti con l’ideologia dei vincitori. Non intendiamo qui fare l’apologia delle sue idee, anche perché ogni apologia è una operazione supremamente stupida in se stessa; ma rendere doverosamente atto della sua coerenza intellettuale e della sua onestà civile.
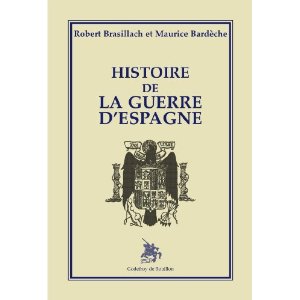 Come storico e saggista, fu tra i primi a contestare la legalità del processo di Norimberga e a mettere in dubbio il diritto giuridico e morale dei vincitori di ergersi a giudici dei vinti, magari per dei reati che, all’epoca dei fatti, non erano considerati tali in nessuna legislazione del mondo; così come fu uno dei primi a parlare in termini critici della distruzione di Dresda e delle esecuzioni sommarie avvenute dopo la Liberazione, da lui equiparate a crimini di guerra. Fu pure multato per essersi occupato dell’Olocausto in una forma vicina a quella di Robert Faurisson, che non piacque alla Vulgata democratico-resistenziale, la sola ufficialmente ammessa. Venne inoltre condannato a un anno di prigione per apologia dei crimini di guerra ed uscì solo perché gli venne concessa la grazia dal Presidente della Repubblica, René Coty.
Come storico e saggista, fu tra i primi a contestare la legalità del processo di Norimberga e a mettere in dubbio il diritto giuridico e morale dei vincitori di ergersi a giudici dei vinti, magari per dei reati che, all’epoca dei fatti, non erano considerati tali in nessuna legislazione del mondo; così come fu uno dei primi a parlare in termini critici della distruzione di Dresda e delle esecuzioni sommarie avvenute dopo la Liberazione, da lui equiparate a crimini di guerra. Fu pure multato per essersi occupato dell’Olocausto in una forma vicina a quella di Robert Faurisson, che non piacque alla Vulgata democratico-resistenziale, la sola ufficialmente ammessa. Venne inoltre condannato a un anno di prigione per apologia dei crimini di guerra ed uscì solo perché gli venne concessa la grazia dal Presidente della Repubblica, René Coty.
Come presidente del Movimento Sociale Europeo, coagulò esponenti della destra europea quali Oswald Mosley, ex capo dei fascisti inglesi, il tedesco Karl-Heinz Priester, lo svedese Per Engdahl e l’italiano Ernesto Massi. Concentrò poi la sua attenzione di studioso sull’esperienza della Repubblica Sociale Italiana (che, da noi, è tuttora considerata alla stregua di una misera e sanguinaria appendice del Ventennio, consumatasi all’ombra del “tedesco invasore” e quindi come tipico esempio di Stato collaborazionista fantoccio), e ne fece la base per una sua rinnovata proposta politica, che egli stesso denominò “fascismo perfezionato”.
Né ha giovato alla sua fama o alla sua memoria il fatto che, dopo la sua scomparsa, a tesserne l’elogio sia stato Jean-Marie Le Pen, capo del Fronte Nazionale Francese e considerato dalla cultura politica progressista nient’altro che il leader di un partito xenofobo e reazionario.
Nel suo saggio Sparte et les Sudistes (Les Sept Couleurs, 1969; traduzione italiana di Orsola Nemi col titolo Fascismo ’70. Sparta e i Sudisti, Edizioni del Borghese, 1970, pp. 81-86), egli così sintetizza il proprio pensiero politico:
«Insegnare di nuovo agli uomini il gusto e il rispetto delle qualità umane, ricondurre la vita e le anime verso il corso naturale delle cose, ecco le due massime che dovrebbero guidare quanti pensano che l’uomo può ancora mettere il morso al cavallo che gli ha preso la mano e che noi chiamiamo la nostra “civiltà”. Quella che io chiamo Sparta è la patria in cui gli uomini sono considerati in ragione delle loro qualità virili poste al di sopra di tutte le altre. Quelli che io chiamo i Sudisti sono gli uomini i quali si sforzano di vivere secondo la “natura delle cose”, e pretendono di correggerla aggiungendo soltanto la cortesia e la generosità.
In ciascuno di noi si trova una qualche aspirazione che ci trascina a volte verso Sparta, a volte verso i Sudisti. Per lo più, sono le circostanze che ci inducono a sostenere un concetto spartano pur rimpiangendo che non faccia maggiori concessioni ai Sudisti o, inversamente, ad avvicinarci a qualche prospettiva sudista, pur augurandoci che conservi qualcosa di Sparta. Queste intermittenze spiegano forse le contraddizioni di quel che si chiama arbitrariamente “La Destra”, la quale presenta tutte le sfumature di questi due atteggiamenti. Le due posizioni non sono tuttavia inconciliabili. Coincidono e si sposano tanto facilmente in ciascuno di noi perché sono l’una e l’altra “naturali”, il rispetto delle qualità umane essendo così conforme alla “legge naturale” come la conformazione al “corso naturale delle cose”. Ma l’uno e l’altro di questi atteggiamenti comportano rischi in cambio dei loro vantaggi: Sparta rischia di essere inabitabile, i sudisti spartani possono finire col divenire gendarmi, il sudismo può finire nell’egoismo e nell’insolenza. Noi dobbiamo chiederci che cosa si può conservare di sudista a Sparta o che cosa dobbiamo serbare di Sparta per impedire ai sudisti di essere soltanto uomini di mondo.
Non bisogna fidarsi ciecamente dei libri illustrati. Sparta non è una città dove non si sente che rumore di sproni e dove nessuno dei passanti sorride. Il precetto del coraggio era chiaro e risolveva tutte le difficoltà. Il coraggio dava accesso all’aristocrazia e si era esclusi dall’aristocrazia se non si aveva coraggio. La casta dei guerrieri governava la città, nessun’altra voce aveva diritto di farsi intendere. Era la casta che portava da sola il fardello della difesa del Paese e lo portava per tutta la vita. Ma gli altri, protetti dal suo servizio, non si sentivano stranieri. Il coraggio era ricompensato fra loro, e chi aveva dato prova di possedere le virtù del soldato, partecipava ai privilegi del soldato. Anche gli iloti, se si erano distinti per una azione meritoria, avevano diritto di partecipare al combattimento. Quelli che si erano battuti al fianco delle celebri falangi non erano mai più schiavi, divenivano uomini liberi, erano onorati. Si afferma anche che gli stranieri potevano ricevere il titolo di Spartani, se accettavano di vivere secondo la regola che gli Spartani si erano imposta. E, al contrario, i giovani della casta guerriera che si dimostravano vili nel combattimento o non si sottomettevano alla disciplina della Città, erano degradati ed esclusi dalla vita pubblica.
L’educazione non aveva altro scopo che l’esaltazione del coraggio e della energia. I ragazzi vivevano tra loro il più presto possibile, in truppe analoghe a quelle dei balilla dell’Italia fascista o della Hitlerjugend, di cui facevano parte dalla età di sette anni. […]
Spesso è riprovato il culto del coraggio e della virilità accusandolo di durezza e aridità. È un’interpretazione da moralisti che la vita privata a Sparta non conferma su tutti i punti. Si trova sotto la rudezza di Sparta una specie di bonomia tedesca la quale suggerisce che le cose non sono tanto semplici. Plutarco descrive Agesilao che giuoca ai cavalli coi suoi bambini, come si racconta del nostro re Enrico IV; Antalcida manda la sua famiglia a rifugiarsi a Citera, quando teme un’invasione; l’assemblea degli Spartani piange di commozione udendo recitare un coro dell’Elettra e sono appena usciti dalla guerra contro Atene: gli Spartani avevano anche un gusto innato e un sentimento abbastanza vivo della musica, il che stupiva i loro contemporanei. In quanto al loro orgoglio di casta, che bisogna pensarne, quando sentiamo dirci che i giovani Spartani avevamo ciascuno un fratello di latte scelto tra i figli dei suoi iloti, il quale riceveva la sua medesima educazione, prendeva parte con lui ai pasti collettivi, portava le armi accanto a lui nei combattimenti e condivideva i suoi stessi privilegi? Quale democrazia ha accordato questa eguaglianza autentica ai figli dei mezzadri? Gli iloti e i perieci vissero duecento anni sotto il “giogo” di Sparta e non vi furono ammutinamenti se non in circostanze del tutto eccezionali e per cause estranee al regime. È difficile credere che abbiano vissuto durante tutto questo tempo in una continua e insopportabile umiliazione.
L’idea che ci facciamo di Sparta è dunque spesso un’idea del tutto letteraria; riduciamo arbitrariamente Sparta a una esperienza di “laboratorio”. Ne facciamo uno stato nel quale regna solo l’energia. Quel che definisce Sparta non è la caserma, come troppo spesso si crede, ma il disprezzo dei falsi beni.
Sparta non è solo il ragazzo dalla volpe. L’energia non è che una conseguenza, non è che un segno di Sparta. Prima di tutto, Sparta è una particolare idea del mondo, una particolare idea dell’uomo. Per questo fa paura. Sparta crede che in definitiva sia la spada a decidere. Non si può sfuggire al suo verdetto. Il numero dei vascelli e i marmi dei portici, i palazzi, le sete, le sontuose lettighe, il prestigio, lo splendore non sono che girandole, palline di vetro, lampioni che una tempesta può a un tratto spegnere e spezzare: bisogna essere pronti per questa tempesta. Senza di ciò, non si ha libertà; le città le quali dimenticano che la libertà si difende in ogni istante, si guadagna in ogni istante, sono già, senza saperlo, città schiave. Il culto dell’energia, del coraggio, della forza sono soltanto le conseguenze di questa concezione della città».
Non sarà sfuggito al lettore che, a dispetto della piacevolezza dello stile, la tesi di Bardèche appare viziata da una forzatura ideologica che lo porta ad accostamenti storici quanto meno opinabili, come quello fra gli Spartiati ed i Balilla fascisti o i membri della Hitlerjugend; laddove è facile vedere come le somiglianze siano più esteriori che sostanziali, specialmente nel primo caso.
E tuttavia, per quanto la volontà di dimostrare una tesi precostituita faccia velo all’Autore, è difficile rifiutare in blocco la sua analisi del fenomeno sociale rappresentato dall’antica Sparta e ancor più quello della Confederazione sudista (che noi, per ragioni di spazio, abbiamo dovuto omettere).
Meglio: è difficile rifiutare in blocco la sua tesi circa la solidità e, si vorrebbe dire, la perennità di quella componente aristocratica, nel miglior senso della parola, che caratterizza non tanto questa o quella esperienza storica di governo, ma l’idea del governo in generale, così come Platone l’ha delineata nella Repubblica e nelle Leggi, ma che i pensatori politici moderni, da Locke in poi, non riescono neppure ad immaginare.
 A noi che siamo cresciti nella apparente ovvietà del sistema democratico, sfugge come l’umanità abbia potuto governarsi per millenni senza di esso, pur realizzando opere egregie; e sfugge come il cosiddetto miracolo greco non consista solo nella democrazia ateniese, ma anche nella oligarchia spartana, fondata su un valore che non è quantificabile in termini economici, ma solo e unicamente in termini di onore, dovere e spirito di sacrificio.
A noi che siamo cresciti nella apparente ovvietà del sistema democratico, sfugge come l’umanità abbia potuto governarsi per millenni senza di esso, pur realizzando opere egregie; e sfugge come il cosiddetto miracolo greco non consista solo nella democrazia ateniese, ma anche nella oligarchia spartana, fondata su un valore che non è quantificabile in termini economici, ma solo e unicamente in termini di onore, dovere e spirito di sacrificio.
Solo una lettura frettolosa e parziale, inficiata da pregiudizi tipicamente moderni, potrebbe vedere nella costituzione spartana null’altro che arbitrio, oppressione dei più deboli e brutale esercizio di un potere militaresco.
E solo uno spirito politicamente fazioso potrebbe negare quanto di perenne e di nobilmente spirituale vi sia in una idea del governo che pospone ogni altro valore, a cominciare da quello dell’interesse materiale, ad un severo ascetismo virile, tutto rivolto al bene supremo della Patria e spregiatore di quello spirito di parte dietro il quale sogliono camuffarsi gli egoistici interessi personali.
In questo senso è fuori di dubbio che noi pure avremmo qualche cosa da imparare dal modello spartano, così come avremmo qualcosa da imparare dal modello sudista: non certo in un ricupero del razzismo o magari dello schiavismo, ma nel riconoscimento che troppo spesso, nei sistemi democratici, il merito non riesce ad affermarsi e il bene dell’intera società soccombe davanti al prevalere delle logiche di parte.
Per quanto il ragionamento di fondo del Bardèche non ci convinca, laddove egli vorrebbe fare del principio aristocratico un fatto di natura positivo in se stesso – anche perché in tal modo verrebbero banditi o fortemente sminuiti ideali essenziali, quali la compassione e la sollecitudine per i più deboli – è tuttavia certo che il suo discorso contiene un monito a non lasciarsi prendere la mano dalla demagogia e dal populismo a buon mercato.
Una giusta idea della politica dovrebbe partire, come cosa ovvia, dallo spirito di servizio e dalla priorità del bene comune; dovrebbe inoltre recuperare l’importanza di concetti quale onore, valore, dedizione, lealtà e magnanimità.
Si obietterà che codesti valori sono quelli tipici della società cavalleresca e che, da quando la borghesia si è affermata come classe egemone a livello mondiale, non vi è più posto per essi e nemmeno potrebbe esservi.
Forse.
Ma siamo sicuri che onore, valore, dedizione, lealtà e magnanimità siano valori legati esclusivamente ad un certo modello economico e sociale e non, piuttosto, valori perenni dell’umanità, senza i quali nessuna società potrebbe contemperare in se stessa le inevitabili spinte centrifughe?
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, maurice bardèche |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



Les commentaires sont fermés.