Alessandra COLLA - http://www.alessandracolla.net/
Archives: 1994
 Negli scritti di Nietzsche, è stato detto, si può trovare tutto e il contrario di tutto. Questa pretesa contraddizione interna del grande pensatore ha fornito materiale in quantità per molte opere — talvolta critiche talvolta denigratorie — che hanno accompagnato negli anni la fortuna del filosofo senza, peraltro, mai scalfirne il nòcciolo.
Negli scritti di Nietzsche, è stato detto, si può trovare tutto e il contrario di tutto. Questa pretesa contraddizione interna del grande pensatore ha fornito materiale in quantità per molte opere — talvolta critiche talvolta denigratorie — che hanno accompagnato negli anni la fortuna del filosofo senza, peraltro, mai scalfirne il nòcciolo.
In mezzo alla feconda complessità dei temi trattati, emergono però alcuni aspetti interessanti e solitamente poco noti ai più. Vogliamo qui accennarne qualcuno, almeno per suggerire nuove curiosità.
L’UOMO CHE VISSE DIETRO LA SIEPE
… questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
(G. Leopardi, L’infinito, 1819)
Il XVIII secolo sta per finire quando, nel 1798, nasce a Recanati Giacomo Taldegardo Francesco Leopardi, figlio del conte Monaldo e della marchesa Adelaide Antici. Autentico bambino prodigio, all’età di undici anni Giacomo si ritrova senza precettore: sa già tutto quello che c’è da sapere, e non c’è nessuno in grado di seguirlo negli studi. Con la beata incoscienza della sua età, il primogenito di casa Leopardi continua da solo. Da solo impara il greco, l’ebraico, il francese, l’inglese e lo spagnolo; padrone, a soli quindici anni, di tante lingue vive e morte, sviluppa a quest’età l’amore per gli studi filologici: le grammatiche e le sintassi non hanno più per lui alcun segreto, ed ora è finalmente libero di cogliere nella loro pienezza i tesori che si celano dietro l’aridità apparente delle forme verbali e delle declinazioni.
Il 1816 segna una svolta di importanza capitale nella vita e nel pensiero di Leopardi: è in quest’anno, infatti, che il giovane scopre le lettere e la poesia, sulle quali riversa la passione finora consacrata all’erudizione e alla disciplina filologica. Dello stesso anno è anche la prima, e non la più grave, delle molte crisi fisiche e nervose che travaglieranno la sua breve vita: con orrore e certo senza rassegnazione, Giacomo intuisce di aver definitivamente minato la sua già gracile costituzione con un’applicazione mentale eccessiva. Ad aggravare la situazione psicologica del giovane sopraggiunge, sul finire dell’anno, il breve soggiorno in casa Leopardi della bella cugina Gertrude Cassi sposata Lazzari: scoppia la prima infatuazione amorosa, tutta platonica e ovviamente unilaterale, di Giacomo, che recita qui per la prima volta il copione dell’amore illuso e deluso — lo ripeterà per tutta la vita.
Il suo stato d’animo non migliora affatto. In una celebre, drammatica lettera all’amico scrittore Pietro Giordani, datata 2 marzo 1818, Leopardi lascia sgorgare senza pudori tutta la sua amarezza profonda e inconsolabile: «[…] in somma io mi sono rovinato con sette anni di studio matto e disperatissimo in quel tempo che mi s’andava formando e mi si doveva assodare la complessione. E mi sono rovinato infelicemente e senza rimedio per tutta la vita, e rendutomi l’aspetto miserabile, e dispregevolissima tutta quella gran parte dell’uomo, che è la sola a cui guardino i più; e coi più bisogna conversare in questo mondo». Nel settembre dello stesso anno il Giordani, allarmato dalle parole del giovane, lo raggiunge a Recanati per condurlo con sé a Macerata: un viaggio di ben pochi chilometri — il primo in assoluto di Giacomo, allora ventenne. L’impatto con una dimensione estranea a quella del sonnolento “borgo natio” e la consapevolezza di un mondo vasto e sconosciuto destinato a restare fuori dalla sua portata non fanno che aumentare l’inquietudine di Leopardi, che si sente (e sa di essere davvero) profondamente diverso dagli altri, e anela alla gloria.
Nella primavera del 1819 la sua già malferma salute va peggiorando: un esaurimento fisico generale lo prostra, e si manifestano i primi disturbi agli occhi che gli impediscono di leggere per quasi un anno e che, d’ora in poi, lo accompagneranno per tutta la vita. Questo episodio rientra a pieno titolo fra i motivi scatenanti di quel pessimismo assoluto che diverrà cifra e referente del pensiero leopardiano (1).
Corollario inevitabile di questo crollo di ogni illusione è la perdita della fede religiosa; per compensare la quale il Leopardi si getta nell’elaborazione di un suo sistema filosofico — una sorta di materialismo pessimistico radicale sull’onda, paradossalmente, delle suggestioni illuministiche. Se infatti l’illuminismo tracciava il disegno grandioso di un progresso inarrestabile volto a condurre l’umanità intera verso luminosi e necessari destini, per il Leopardi le istanze deterministiche e la constatazione di uno “stato di natura” suggeriscono piuttosto l’idea di un decadimento dell’uomo dalle altezze dell’età antica alle bassure di quella moderna; e la civiltà, lungi dal rappresentare il punto d’arrivo dell’evoluzione umana, si configura invece come l’allontanamento dell’uomo dalla beata condizione naturale, unica e sola in grado di garantire la felicità — cioè l’assenza o la cessazione del dolore (secondo la scuola stoica prediletta dal poeta-filosofo). Il grande passo è compiuto: da qui in avanti il Leopardi alternerà meditazioni filosofiche a composizioni poetiche, per approdare, dopo un silenzio durato cinque anni (dal 1823 al 1828), alla sublime fusione di sostanza filosofica e forma poetica. Sempre più minato nel fisico, trascinerà un’esistenza sofferente, alleviata soltanto dalle cure assidue e affettuose di pochi amici, fino alla morte, sopravvenuta il 14 giugno 1837 a Napoli, in casa dell’amico Antonio Ranieri.
IL POETA E IL FILOSOFO: AFFINITÀ ELETTIVE
È un destino singolare, come si vede, quello che accomuna Giacomo Leopardi e Friedrich Nietzsche: entrambi sono stati mutilati dalla critica, contemporanea e successiva, in gran parte della loro opera — si sa che il Leopardi è noto, apprezzato e studiato come poeta, ma per lo più ignorato come filosofo, mentre Nietzsche è giudicato a buon diritto un gigante del pensiero ma poco più che un semplice dilettante nel campo delle arti. Eppure, come pochi ormai si azzardano a negare, la verità è molto diversa.
Ma le somiglianze non finiscono qui. Sia l’italiano inquieto che il riservato tedesco iniziano il loro percorso intellettuale sui testi di filologia, anche se per motivi dìversi: il piccolo Giacomo perché la pur nutrita biblioteca paterna non era in grado di offrire più niente a un bambino così sorprendentemente dotato; il giovane Federico perché la formazione ricevuta nel prestigioso istituto di Pforta gli aveva rivelato le immense possibilità speculative legate allo studio del mondo classico e delle sue lingue. Inoltre, entrambi furono costretti a viaggiare molto, ed entrambi per questioni di sopravvivenza, soggiornando addirittura negli stessi luoghi; entrambi furono di salute assai cagionevole, soffrendo persino degli stessi disturbi; entrambi trovarono l’ultimo conforto nella vicinanza di amici fedeli e disinteressati; e, per finire, il pensiero di entrambi è stato spesso snaturato e stravolto così da renderli invisi non soltanto a generazioni di studenti, ma anche a molti seri studiosi irrimediabilmente viziati nell’interpretazione dei loro testi.
La complementarità dei loro destini li rende simili al di là delle differenze oggettive, portandoli verso un unico sentire e un’identica visione della vita, tanto che sarà proprio Leopardi ad anticipare alcune delle più brillanti e rivoluzionarie intuizioni di Nietzsche.
Il pensatore di Röcken conosceva, almeno in parte, il Leopardi: sappiamo che nella biblioteca di Nietzsche figuravano due traduzioni tedesche di Leopardi, ad opera dello Hamerling e dello Heyse; sicuramente vi erano compresi i Canti, che il poeta italiano scrisse a partire dal 1818, lo Zibaldone e molto probabilmente le Operette morali. Ed è lo stesso Nietzsche a menzionare il Leopardi, anche se di passata e in modo non proprio lusinghiero: «Gli infelici raffinati, come Leopardi, che dalla loro sofferenza traggono orgogliosamente vendetta su tutta l’esistenza, non si accorgono come il divino mezzano dell’esistenza rida di loro: proprio così essi ora berranno di nuovo dalla sua coppa; infatti la loro vendetta, il loro orgoglio, la loro inclinazione a pensare tutto quanto soffrono, la loro arte nel dirlo: tutto questo non è di nuovo — dolce miele?» (2).
Alla luce di un’attenta lettura del poeta italiano e del filosofo tedesco, è innegabile che le influenze del primo sul secondo esistano, e siano ben documentabili. Confrontiamo, ad esempio, Il sabato del villaggio e La sera del dì di festa (composte entrambe nel settembre 1829) con un frammento di Nietzsche. Il Leopardi scrive:
«[…] intanto riede alla sua parca mensa,
fischiando, il zappatore,
e seco pensa al dì del suo riposo.
Poi, quando intorno è spenta ogni altra face,
e tutto l’altro tace,
odi il martel picchiare, odi la sega
del legnaiuol, che veglia
nella chiusa bottega alla lucerna,
e s’affretta, e s’adopra
di fornir l’opra anzi il chiarir dell’alba.
Questo di sette è il più gradito giorno,
pien di speme e di gioia:
diman tristezza e noia
recheran l’ore, ed al travaglio usato
ciascuno in suo pensier farà ritorno» (3).
E ancora:
«[…] Ahi, per la via
odo non lunge il solitario canto
dell’artigian che riede a tarda notte,
dopo i sollazzi, al suo povero ostello;
e fieramente mi si stringe il core,
a pensar come tutto al mondo passa,
e quasi orma non lascia. Ecco è fuggito
il dì festivo, ed al festivo il giorno
volgar succede, e se ne porta il tempo
ogni umano accidente. […]» (4).
Quello che segue, invece, è il testo nietzscheano:
«Il pomeriggio del sabato si deve passare per un villaggio, se si vuol vedere sui volti dei contadini la vera quiete del dì di festa: allora essi hanno ancora indelibata davanti a sé la giornata di riposo e si industriano a far ordine e pulizia in suo onore con una specie di piacere anticipato, quale non sarà raggiunta dal piacere stesso. La domenica è già quasi lunedì» (5).
Oppure si paragonino questi due brani:
«Ogni grande amore porta con sé il crudele pensiero di uccidere l’oggetto dell’amore, perché sia sottratto una volta per tutte al sacrilego giuoco del mutamento: giacché di fronte al mutamento l’amore inorridisce più che di fronte alla distruzione»;
«Il veder morire una persona amata, è molto meno lacerante che il vederla deperire e trasformarsi nel corpo e nell’animo da malattia (o anche da altra cagione)».
Il primo è di Nietzsche (6), mentre il secondo è di Leopardi (7).
Con un minimo di attenzione, è facilissimo trovare, sparsi qua e là nello Zibaldone senza un ordine fisso, ma sull’onda di meditazioni e concatenamenti apparentemente confusi che fanno delle elaborazioni leopardiane un autentico “pensiero in movimento” destinato ad arrestarsi soltanto con la morte, intuizioni e abbozzi di teorie poi ripresi e sviluppati compiutamente da Nietzsche nell’arco di pochi decenni, e che nella prosa densa del Leopardi spiccano in tutta la loro grandezza.
Così alcuni notevoli passi che anticipano la Genealogia della morale sono del 4-5 settembre 1821: «La legge naturale varia secondo le nature. Un cavallo che non è carnivoro giudicherà forse ingiusto un lupo che assalga e uccida una pecora, l’odierà come sanguinario, e proverà un senso di ribrezzo e d’indignazione abbattendosi a vedere qualche sua carnificina. Non così un lione. Il bene e il male morale non ha dunque nulla di assoluto. Non v’è altra azione malvagia, se non quelle che ripugnano alle inclinazioni di ciascun genere di esseri operanti: né sono malvage quelle che nocciono ad altri esseri, mentre non ripugnino alla natura di chi le eseguisce» (8); «Si suol dire che tutte le cose, tutte le verità hanno due facce, diverse o contrarie, anzi infinite. Non c’è verità che prendendo l’argomento più o meno da lungi, e camminando per una strada più o meno nuova, non si possa dimostrar falsa con evidenza ec. ec. ec. Quest’osservazione (che puoi molto specificare ed estendere) non prova ella che nessuna verità né falsità è assoluta, neppure in ordine al nostro modo di vedere e di ragionare, neppur dentro i limiti della concezione e ragione umana?» (9); «Da ciò che si è detto della legge pretesa naturale, risulta che ne vi è bene né male assoluto di azioni; ci queste non sono buone o cattive fuorché secondo le convenienze, le quali son stabilite, cioè determinate dal solo Dio ossia, come diciamo, dalla natura; che variando le circostanze, e quindi le convenienze, varia ancora la morale, né v’è legge alcuna scolpita primordialmente ne’ nostri cuori; che molto meno v’è una morale eterna e preesistente alla natura delle cose, ma ch’ella dipende e consiste del tutto nella volontà e nell’arbitrio di Dio padrone sì di stabilire quelle determinate convenienze che voleva […]. Da tutto ciò resta spiegata la differenza fra la legge che corse prima di Mosè, quella di Mosè, e quella di Cristo. […] L’antica legge Ebraica permetteva il concubinato, fuorché colle donne forestiere ec. L’odio del nemico costituiva lo spirito delle antiche nazioni. Ecco le leggi di Mosè tutte patriottiche, ecco santificate le invasioni, le guerre contro i forestieri, proibite le nozze con loro, permesso anche l’odio del nemico privato. E Gesù comandando l’amor del nemico, dice formalmente che dà un precetto nuovo. Come ciò, se la morale è eterna e necessaria? Come è male oggi, quel ch’era forse bene ieri? Ma la morale non è altro che convenienza, e i tempi avevano portato nuove convenienze. Questo discorso potrebbe infinitamente estendersi generalizzando sullo stato del mondo antico e moderno, e sulla differente morale adattata a questi diversi stati. L’uomo isolato non aveva bisogno di morale, e nessuna ne ebbe infatti, essendo un sogno la legge naturale. Egli ebbe solo dei doveri d’inclinazione verso se stesso, i soli doveri utili e convenienti nel suo stato. Stretta la società, la morale fu convenienza, e Dio la diede all’uomo appoco appoco, o piuttosto ora una ora un’altra, secondo i successivi stati della società: e ciascuna di queste morali era ugualmente perfetta, perché conveniente; e perfetto è l’uomo isolato, senza morale» (10).
Un rilievo del 1823 sembra attagliarsi perfettamente a certe considerazioni contenute nell’Anticristo: «Persone imperfette, difettose, mostruose di corpo, tra quelle che non arrivano a nascere e […] tra quelle che son tali dalla nascita […]; quelle che così nate vivono e […] quelle finalmente che tali son divenute dopo la nascita […]; sommando dico e raccogliendo tutti questi individui insieme, si vedrà a colpo d’occhio e senza molta riflessione che il loro numero nel solo genere umano, anzi nella sola parte civile di esso, avanza di gran lunga non solamente quello che trovasi in qualsivoglia altro intero genere d’animali, non solamente eziandio quello che veggiamo in ciascheduna specie degli animali domestici, che pur sono corrotti e mutati dalla naturale condizione e vita, e da noi in mille guise travagliati e malmenati; ma tutto insieme il numero degl’individui difettosi e mostruosi che noi veggiamo in tutte le specie di animali che ci si offrono giornalmente alla vista, prese e considerate insieme. La qual verità è così manifesta, che niuno, io credo, purché vi pensi un solo momento e raccolga le sue reminiscenze, la potrà contrastare. Simile differenza si troverà in questo particolare fra le nazioni civile e le selvagge, e proporzionatamente fra le più civili e le meno, secondo un’esatta scala» (11). Di questa lunga citazione merita, a nostro avviso, sottolineare anche l’accenno agli animali, che è una costante del Leopardi: la sua attenzione nei confronti della natura e degli esseri viventi è continua e delicata, comprendendo ogni forma di vita nel mistero del dolore universale e del pessimismo cosmico. Anche questo è un tratto (e non dei minori) che lo accomuna a Nietzsche.
Sempre nell’Anticristo, troviamo invece una frase illuminante del filosofo tedesco: «Se si avesse nel petto una qualche misura, anche esigua, di religiosità, un Dio che cura al momento giusto il raffreddore o che ci fa salire in carrozza nel preciso istante in cui si scatena un acquazzone dovrebbe essere per noi tanto assurdo, che occorrerebbe eliminarlo anche nel caso in cui esistesse. Un Dio come domestico, come portalettere, come venditore d’almanacchi — una sola parola, in fondo, per indicare la specie più stupida tra tutte le circostanze fortuite…» (12). Il riferimento alla celebre operetta morale che il Leopardi scrisse nel 1832, e intitolata appunto Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, ci sembra assolutamente fuor di dubbio: nel Dialogo, il poeta immagina l’incontro fra un “passeggere” e un venditore di calendari che propone al passante l’acquisto di un calendario per l’anno nuovo. Il passante si informa se l’anno nuovo sarà o no migliore del precedente, e il venditore risponde di sì; ma il passante incalza, e vuole sapere a quale degli ultimi vent’anni potrebbe essere paragonato l’anno nuovo in quanto a bontà; il venditore annaspa, travolto dalla stupidità dei luoghi comuni che il passante gli sciorina uno dietro l’altro, e il dialogo si conclude col timido “speriamo…” del venditore che non può fare altro che rifilare al passante un calendario qualsiasi, nell’illusione che il futuro sarà comunque migliore del passato. Eccolo qua, il Dio schernito da Nietzsche: un Dio buono per tutte le stagioni, che porterà il sole al villeggiante e la pioggia al contadino, la pace a chi combatte e la guerra al mercante d’armi — proprio un Dio che, se davvero esistesse, andrebbe eliminato.
Non sono — ovviamente — tutti qui i paralleli fra il poeta-filosofo e il filosofo-poeta. L’argomento meriterebbe ben più di qualche cenno frettoloso, ma sappiamo che l’insofferenza di troppi per la poesia leopardiana non è certo né il minore né l’ultimo dei guasti fatti dalla scuola italiana. Per chiudere in bellezza, scegliamo l’insegnamento supremo di Zarathustra il Distruttore: «Uomini superiori, imparatemi - a ridere!» (13), adombrato in uno degli ultimi appunti dello Zibaldone: «Terribile e awful è la potenza del riso; chi ha il coraggio di ridere, è padrone degli altri, come chi ha il coraggio di morire» (14).
(testo apparso originariamente sulla rivista “Origini”,
numero monografico su Friedrich Nietzsche, 1994)
NOTE
(1) Lui stesso descriverà così l’avvenuto mutamento, in un’annotazione datata 1 luglio 1820: «Sono stato sempre sventurato, ma le mie sventure d’allora erano piene di vita, e mi disperavano perché mi pareva […] che m’impedissero la felicità, della quale gli altri credea che godessero. […] La mutazione totale in me […] seguì […] nel 1819 dove privato dell’uso della vista, e della continua distrazione della lettura, cominciai […] a divenir filosofo di professione (di poeta ch’io era), a sentire l’infelicità certa del mondo» (Giacomo Leopardi, Zibaldone, Oscar Mondadori, Milano 1972, vol. 1, p. 118).
(2) Friedrich Nietzsche, Umano, troppo umano (e scelta di frammenti postumi), Oscar Mondadori, Milano 1976, vol. II, fr. 38 [2], p. 273.
(3) G. Leopardi, Il sabato del villaggio, vv. 28-42.
(4) Idem, La sera del dì di festa, vv. 24-33.
(5) F. Nietzsche, Umano…, cit., fr. 45 [3], p. 286.
(6) Ivi, fr. 280. p. 95.
(7) G. Leopardi, Zibaldone, cit., p. 290 (8 gennaio 1821).
(8) Idem, Zibaldone, cit., vol. II, p. 582 (4 settembre 1821).
(9) Ivi, p. 585 (5 settembre 1821).
(10) Ivi, pp. 587-589 (5 settembre 1821).
(11) Ivi, p. 844 (28 luglio 1823).
(12) F. Nietzsche, L’Anticristo. Maledizione del cristianesimo, Adelphi, Milano 1977, par. 52, p. 75.
(13) F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano 1973, p. 359 (“Dell’uomo superiore” - 20, 25).
(14) G. Leopardi, Zibaldone, cit., vol. II, p. 1160 (23 settembre 1828).
(© Alessandra Colla, Prima che Nietzsche venisse, 1994, in “Origini - Nietzsche”, 2006)




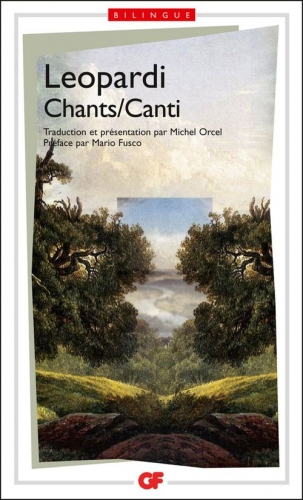 Revenons à Nietzsche et à Spinoza. Il y a une troisième figure sans laquelle la destruction ultime de la métaphysique n'aurait pas été accomplie par le philosophe allemand : elle s’appelle Leopardi, qui a eu une influence fondamentale sur la philosophie de Nietzsche. Car le "comte" de Recanati (qui ne connaissait pas l'allemand -mais il n'en avait pas besoin- car il possédait les langues anciennes comme le plus expert des philologues classiques, et ce dès son adolescence). Friedrich Nietzsche le connaissait bien. Et, chose que l'on oublie parfois, il est non seulement l'un des plus grands poètes du XIXe siècle - en italien, le plus grand, mais au sommet de tous les poètes de notre continent - mais aussi le plus grand philosophe italien du XIXe siècle, et l'un des plus grands d'Europe. Il ne faut pas oublier qu’il a fait largement usage d’une forme et d’un style qu'il partage avec Nietzsche : sa façon de penser par aphorismes. Hegel s'est lancé dans une divagation sur des systèmes d'une incroyable lourdeur et il a été le recréateur d'une théodicée moderne à laquelle nous devons, conjuguée à d'autres éléments, le nazisme. Le Zibaldone di pensieri de Leopardi semble être une suite d'aphorismes d'une concision latine apparemment désordonnée. Il possède cependant une formidable cohérence interne qui se fond avec la poésie de son auteur (même la poésie non "philosophique" : tout le monde peut comprendre que le Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, ou La ginestra, sont de la philosophie chantée en vers sublimes, ou comprendre l'Operette morali et l'Epistolario. Et Friedrich Nietzsche était un connaisseur et un admirateur attentif de Leopardi. Sans lui, il serait resté prisonnier de la métaphysique wagnérienne.
Revenons à Nietzsche et à Spinoza. Il y a une troisième figure sans laquelle la destruction ultime de la métaphysique n'aurait pas été accomplie par le philosophe allemand : elle s’appelle Leopardi, qui a eu une influence fondamentale sur la philosophie de Nietzsche. Car le "comte" de Recanati (qui ne connaissait pas l'allemand -mais il n'en avait pas besoin- car il possédait les langues anciennes comme le plus expert des philologues classiques, et ce dès son adolescence). Friedrich Nietzsche le connaissait bien. Et, chose que l'on oublie parfois, il est non seulement l'un des plus grands poètes du XIXe siècle - en italien, le plus grand, mais au sommet de tous les poètes de notre continent - mais aussi le plus grand philosophe italien du XIXe siècle, et l'un des plus grands d'Europe. Il ne faut pas oublier qu’il a fait largement usage d’une forme et d’un style qu'il partage avec Nietzsche : sa façon de penser par aphorismes. Hegel s'est lancé dans une divagation sur des systèmes d'une incroyable lourdeur et il a été le recréateur d'une théodicée moderne à laquelle nous devons, conjuguée à d'autres éléments, le nazisme. Le Zibaldone di pensieri de Leopardi semble être une suite d'aphorismes d'une concision latine apparemment désordonnée. Il possède cependant une formidable cohérence interne qui se fond avec la poésie de son auteur (même la poésie non "philosophique" : tout le monde peut comprendre que le Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, ou La ginestra, sont de la philosophie chantée en vers sublimes, ou comprendre l'Operette morali et l'Epistolario. Et Friedrich Nietzsche était un connaisseur et un admirateur attentif de Leopardi. Sans lui, il serait resté prisonnier de la métaphysique wagnérienne.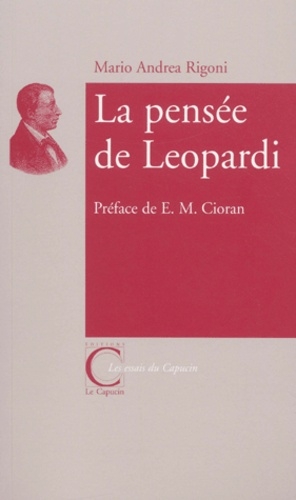 Rigoni connaît chaque virgule du Zibaldone, chaque ligne poétique, chaque épître du Contino ; chaque repli des Operette morali, qui sont un des sommets de la prose italienne et, venant du matérialisme français du XVIIIe siècle et de Fontenelle (auteur des Dialogues des morts), ils ont trouvé un Style Grotesque qui est soudé à l'ancien nihilisme, si je puis dire, de Lucian de Samosata. Même ses pages, ostensiblement un recueil d'essais successifs dans le temps (il a même l'habitude de dater chacun des essais), possèdent une formidable unité. Y a-t-il des livres qui ont été écrits par eux-mêmes ? En voici une. Les pages sont nées, recherchées et ensuite soudées.
Rigoni connaît chaque virgule du Zibaldone, chaque ligne poétique, chaque épître du Contino ; chaque repli des Operette morali, qui sont un des sommets de la prose italienne et, venant du matérialisme français du XVIIIe siècle et de Fontenelle (auteur des Dialogues des morts), ils ont trouvé un Style Grotesque qui est soudé à l'ancien nihilisme, si je puis dire, de Lucian de Samosata. Même ses pages, ostensiblement un recueil d'essais successifs dans le temps (il a même l'habitude de dater chacun des essais), possèdent une formidable unité. Y a-t-il des livres qui ont été écrits par eux-mêmes ? En voici une. Les pages sont nées, recherchées et ensuite soudées.
 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg