MIGRAZIONI E DIASPORE:
PROSPETTIVE GEOPOLITICHE
di Louis Sorel*
SINERGIE EUROPEE – BOLZANO / BRUXELLES – AGOSTO 2004
La mobilità degli uomini e, correlativamente, l’esistenza delle diaspore sono fenomeni antichi, ma in questi ambiti come in molti altri ci troviamo a vivere un’accelerazione della storia. Effettivamente questi ultimi decenni hanno conosciuto importanti e durevoli movimenti di popolazioni su scala planetaria, nonché una generalizzazione del fatto diasporico. Nei limiti del tempo qui concessoci cercheremo di inquadrare questi fenomeni in una prospettiva geopolitica, la geopolitica essendo qui compresa come analisi dei rapporti di potenza tra politìe/unità politiche così come fra «attori anomici ed esotici» — come dice Lucien Poirier — vale a dire non-statuali.
Utilizzeremo qui lo studio delle migrazioni e delle diaspore per imparare le dinamiche del sistema-Mondo. Dopo aver tracciato una rapida geografia delle migrazioni e diaspore, ne prenderemo in considerazione le conseguenze geopolitiche interne — la destrutturazione degli Stati-Nazione del «Nord» — ed esterno: il rinnovamento delle problematiche «internazionali» e conflittuali.
IL «PIANETA NOMADE»
[Questo titolo riprende il tema dell’VIII edizione del Festival internazionale di geografia di Saint-Dié-des-Vosges (ottobre 1997), «Il pianeta nomade, le mobilità geografiche di oggi»]
I flussi migratori contemporanei si organizzano attorno a pochi grandi poli/centri attrattori che possono agevolmente essere rappresentati su di un planisfero.
Principale centro attrattore, gli Stati Uniti: nel secolo scorso questo grande paese d’immigrazione ha polarizzato l’essenziale dei flussi europei, ma nel corso degli anni venti, e in seguito alla trasformazione delle correnti migratorie — la maggior parte delle quali è rappresentata dalle popolazioni euro – mediterranee e slave — lo Stato federale ha deciso di adottare misure restrittive. Nel 1965, al termine di quattro decenni di chiusura delle frontiere, queste misure sono state abolite, e negli ultimi
anni l’immigrazione è ripresa al ritmo di circa un milione di ingressi legali l’anno. Questi flussi originano dall’immediata periferia — Messico, Caraibi e America Latina —, dall’Asia orientale e dai paesi del «Sud»
non europei. Gli Stati Uniti contano così circa 20 milioni d’immigrati della prima generazione.
Altro centro attrattore, il continente europeo: l’Europa del Nord – Ovest, a partire dagli anni Cinquanta, e ormai l’Europa del Sud. Gli immigrati rappresentano circa 15 milioni di individui nell’Unione europea (senza contare i naturalizzati e i clandestini) e questi flussi persistono.
Dapprima essi hanno avuto origine dagli ex territori coloniali, più o meno periferici, ma oggi assistiamo a una mondializzazione dei flussi migratori senza rapporto con le eredità storiche (colonizzazione/decolonizzazione).
Terzo centro attrattore, fino alla fine degli anni Ottanta, i paesi petroliferi del Medio Oriente (ai quali bisogna aggiungere la Libia). In mancanza di censimenti, il peso delle popolazioni immigrate è di difficile valutazione, ma è ragionevole stimarlo fra i 7 e gli 8 milioni di persone — il che, in termini relativi, è parecchio. In molte petromonarchie gli immigrati rappresentano più della metà della popolazione. Tuttavia è necessario precisare che dopo la Guerra del Golfo i flussi migratori si sono invertiti e ancora nel 1997 le espulsioni sono state numerose.
La geografia delle migrazioni comprende anche centri d’attrazione secondari, tali cioè da polarizzare flussi su distanze più corte: l’Australia, paese – continente stiracchiato tra geografia e storia; la Costa d’Avorio, la
Nigeria e la Repubblica sud – africana; il Venezuela, l’Argentina e il Brasile; certe zone dell’Asia sul versante Pacifico… Nel corso di quest’esposizione analizziamo le cose dal punto di vista del «Nord» e di
conseguenza privilegiamo i flussi a lunga distanza e i ragionamenti su scala planetaria.
Diversi e numerosi fattori si combinano per spiegare la potenza e la direzione di questi flussi migratori: fattori demografici, economici, storici, culturali e politici.
FATTORI DEMOGRAFICI: anche se oggi è un po’ riduttivo, in materia tutti sono a conoscenza del dualismo Nord/Sud. Nei paesi sviluppati, ci sono popolazioni stabili e in via d’invecchiamento; nei paesi in via di
sviluppo, popolazioni giovani dalla demografia galoppante. Questo differenziale di crescita si spiega con la transizione demografica, modello che sembra unanimemente accettato. Tuttavia s’impongono due osservazioni. La prima è la differenziazione crescente delle situazioni dei paesi e delle macro - regioni del «Sud», autentico mosaico demografico. La seconda è il rinnovamento delle tesi maltusiane presso alcuni autori, fra cui Jean – Christophe Rufin (L’empire et les nouveaux barbares, Jean-Claude Lattès, 1991) e Yves – Marie Laulan (Les nations suicidaires, François-Xavier de Guibert, 1998).
FATTORI ECONOMICI: tanto per i flussi Nord/Sud che per quelli Sud/Sud, la ricerca di migliori condizioni di vita è uno dei principali fattori esplicativi delle migrazioni internazionali. Nel corso del periodo che va dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta, e in seguito all’afflusso di petrodollari in Medio Oriente fra gli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta, gli immigrati sono in cerca d’impiego. Al giorno d’oggi, sono i sistemi sociali che giocano il ruolo di pompa aspirante.
FATTORI STORICI E CULTURALI: abbiamo già menzionato il ruolo del passato coloniale nei flussi migratori; l’espansione delle potenze europee ha comportato la diffusione delle lingue del Vecchio Continente e la mondializzazione delle sue forme di civiltà. In compenso questi retaggi hanno facilitato le migrazioni Nord/Sud. È vero che a partire dalla metà degli anni Settanta le ondate migratorie sono planetarie e scarsamente rapportabili alle geografie coloniali di un tempo. È altresì necessario
prendere in considerazione un altro fattore culturale: lo strapotere dei media occidentali (soprattutto americani). La circolazione a tutto campo dei medesimi suoni e delle medesime immagini genera una sorta di «immaginario migratorio» e un’ideologia dello sradicamento che stanno alla base dei
movimenti di popolazione. Nei paesi ricettori, questa stessa atmosfera globale è propizia ad un certo lassismo in materia di regolazione dei flussi migratori. Per concludere col ruolo dei fattori culturali, è del pari necessario segnalare che le delocalizzazioni – rilocalizzazioni delle unità produttive nei paesi del «Sud», diffondendo i modelli occidentali, contribuiscono a un certo numero di partenze, com’è stato possibile osservare nelle cosiddette maquiladoras — unità produttive messicane situate nelle immediate vicinanze della frontiera settentrionale del paese e controllate da aziende statunitensi.
FATTORI POLITICI: è il caso delle persone che fuggono da un regime politico dato e/o da una situazione bellica. Lo statuto di questi rifugiati politici è stato specificato dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e l’Alto
Commissariato per i Rifugiati dell’ONU, creato nello stesso anno e con sede nella stessa città, si fa carico attualmente di circa 27 milioni di persone.
Per far fronte alla pressione migratoria derivante da questa trafila, quasi tutti i paesi sviluppati hanno, chi più chi meno, inasprito le condizioni d’accesso allo statuto di rifugiato politico.
Come si vede, nella perennità e nell’espansione dei flussi migratori giocano un complesso di cause rilevanti e un vero e proprio sistema di mobilità.
La conseguenza di questi flussi migratori è la costituzione di diaspore.
Il fenomeno è antico, legato a migrazioni non meno antiche. Gérard Chaliand e Jean – Pierre Rageau (Atlas des diasporas, Odile Jacob, 1991) chiamano «diaspora» un popolo disperso su vasti spazi e territori non collegati fra loro, e le cui differenti ramificazioni persistono nella loro identità, a dispetto della pressione delle popolazioni autoctone. Nella maggior parte dei casi questa dispersione è legata ad un evento originario traumatico: massacri, genocidi, deportazioni, catastrofi naturali. Tuttavia, gli autori dell’Atlas des diasporas non mantengono sistematicamente l’insieme di questi criteri, il che ci permette di utilizzare a buon diritto il termine «diaspora» lato sensu.
Gli esempi più antichi di questo fenomeno sono ben noti: si pensi alla diaspora greca, ebrea e armena, senza dimenticare gli Zigani che al giorno d’oggi sono gli unici a non possedere né Stato né territorio di
riferimento (diaspora integrale). Nel corso del XVI secolo, con la tratta atlantica (il commercio triangolare), ha avuto inizio la dispersione delle popolazioni nere; nel XIX secolo si sono verificate la diaspora irlandese, quella cinese e quella indiana. Il nostro secolo ha rafforzato il fenomeno con un nuovo esodo di popolazioni armene, in seguito al genocidio commesso dai Turchi e dai Curdi alla fine della prima guerra mondiale, e altri avvenimenti e rapporti di forza geopolitici hanno poi generato la diaspora palestinese,
quella libanese e quella vietnamita.
Con il potenziamento e la mondializzazione dei flussi migratori, il fatto diasporico si generalizza: ci accontenteremo qui di menzionare le diaspore arabo – musulmana e nera, particolarmente visibili in Europa occidentale.
Certo, non sempre un disastro è all’origine di queste diaspore contemporanee e i loro membri talvolta rappresentano soltanto una parte poco rilevante della popolazione dei paesi d’origine. In compenso, con la rivoluzione delle comunicazioni (aeree e satellitari) i differenti segmenti di queste popolazioni sono sempre meglio collegati fra loro e la loro coscienza culturale e geopolitica comune si va rafforzando. Non sembra dunque indebito estendere il termine di «diaspora» a questi fenomeni.
LA DESTRUTTURAZIONE DEGLI STATI-NAZIONE DEL «NORD»
La conseguenza geopolitica interna della ridistribuzione delle popolazioni è dunque la destrutturazione degli Stati – Nazione del «Nord». Prima di esaminare questo fenomeno, dobbiamo prima di tutto soffermarci sulla forma politica che domina l’Occidente moderno.
Secondo Carl Schmitt e Julien Freund, il politico è un’essenza, vale a dire un’attività umana originaria rispondente a un dato basilare, in questo caso la conflittualità. Funzione del politico è di assicurare la concordia interna e la sicurezza esterna delle collettività umane costituite.
Successore dello Stato regale, lo Stato – Nazione è una delle manifestazioni storiche del politico, la forma politica propria della modernità. I suoi tratti distintivi sono i seguenti: centralizzazione dei poteri e abbassamento dei corpi intermedi; omogeneizzazione culturale e giuridica del territorio assunto. Questo tipo di politica cerca di far coincidere popolo – lingua – cultura, territorio e Stato.
Questa volontà di omogeneizzazione è strettamente legata al processo di democratizzazione delle società politiche occidentali. In effetti la democrazia è un regime che postula l’identità della volontà popolare e
della legge, l’identità dei governanti e dei governati. Essa suppone un démos, vale a dire un popolo la cui forte omogeneità e la chiara coscienza di ciò che propriamente lo fonda permettono l’emergere di un’autentica volontà generale (si pensi a Jean – Jacques Rousseau). È per questo che in epoca
moderna si è potuto esercitare la democrazia, o quantomeno approssimarvisi, soltanto all’interno di un quadro nazionale.
Questo ideale «nazionale» non è sempre stato realizzato, al di là di tutto.
Si sa che certe nazioni — e non delle minori: pensiamo alla Francia — si sono forgiate all’incrocio di aree culturali distinte (benché in seno ad una medesima civiltà) e sono multietniche. Se non altro ci si è avvicinati, in certa misura, all’omogeneità degli spiriti, sia nelle nazioni dell’Europaoccidentale che in quelle dell’America settentrionale. Oggi, flussi migratori massicci da un lato e la crescita correlativa delle minoranze razziali dall’altro (popolazioni arabo – musulmane in Francia e in numerosi altri Stati europei; popolazioni ispaniche negli Stati Uniti) mettono nuovamente in discussione l’omogeneità del paese d’accoglienza. La coesione di queste società, la loro «governabilità» — tanto per usare un termine
in voga — sono intaccate e, infine, a essere minacciati sono proprio i fondamenti e le strutture dello Stato – Nazione stesso.
Costretti a far fronte alla sfida immigratoria, un certo numero di Stati pensa di riuscire a controllare la situazione praticando una politica di assimilazione. In questo contesto il termine è preso come sinonimo di «naturalizzazione» nel senso etimologico del termine.
Tuttavia l’assimilazione non avviene per decreto: essa dipende da molteplici variabili — peso numerico e dinamismo demografico della popolazione da assimilare; distanza etnoculturale; dinamismo demografico, forza e attrattività del modello culturale della popolazione d’accoglienza. Ora, i paesi interessati dall’immigrazione vivono una crisi dei modelli di assimilazione. Prendiamo la Francia: essa non è più un impero, e neppure la Grande Nazione di un tempo; ha perduto il suo prestigio, e i suoi
meccanismi d’integrazione (scuola, esercito, partiti politici e sindacati) hanno perduto smalto proprio quando il mercato del lavoro non riesce più ad assorbire l’impatto dei nuovi venuti. La distanza etnoculturale degli immigrati aumenta sempre più, dal momento che i paesi d’origine non rientrano più in ambito continentale europeo ma appartengono ad altre sferedi civiltà.
Altro esempio, gli Stati Uniti. Il melting–pot si è rivelato inefficace di fronte alle identità negra e ispano-americana, tanto che oggi quando si parla delle popolazioni degli Stati Uniti, si preferisce usare il
termine di salad–bowl (insalata mista) per indicare la giustapposizione, e non la fusione, di elementi disparati e irriducibili fra loro. Una parte dell’establishment WASP (White, Anglo-Saxon, Protestant) teme addirittura che gli Stati Uniti finiscano col divenire una «maggioranza di minoranze». L’immigrazione e le sue conseguenze sono all’origine di numerosi dibattiti politici, di referendum e di nuove leggi: nel 1986, legge Simpson – Rodino sul ristabilimento delle quote; referendum californiano sulla risoluzione 187 detta «Save Our State» (i clandestini non avranno più accesso ai servizi sociali, medici e amministrativi); nel 1996, adozione di una legislazione più restrittiva sull’immigrazione; nel 1998, nuovo referendum
californiano sull’adozione dell’inglese come lingua ufficiale.
Nei paesi del «Nord» di tradizione assimilatrice, questo tipo di politica non è dunque riuscito a «naturalizzare» la maggior parte delle popolazioni interessate. Di fronte ai problemi migratori, oltre alle politiche di controllo e d’inversione dei flussi che s’impongono appare necessaria un’altra opzione, già praticata da parecchi anni in area anglosassone: quella del multiculturalismo.
L’opzione multiculturale è stata scelta dapprima in America del Nord — il «comunitarismo all’americana» è di volta in volta un modello o uno spauracchio — in ragione della sconfitta subita dal melting – pot. Essa
si articola sui seguenti princìpi:
- la diversità etnoculturale è non soltanto un fatto, ma un fatto positivo che occorre tutelare e promuovere;
- gli uomini concreti non possono essere separati dalle loro appartenenze etnoculturali;
- le culture devono pertanto essere riconosciute nella sfera pubblica.
È da poco che l’Europa deve confrontarsi con questo tipo di situazione — il necessario riconoscimento delle identità regionali e delle patrie carnali non deve essere confuso con l’immigrazione su vasta scala di elementi non–europei: quindi il dibattito assimilazionismo/multiculturalismo vi è di recente introduzione.
Questa scelta corrisponde alla visione del mondo e ai valori che ci sono propri, ma nel contempo ci induce a porci un certo numero di domande:
- tutte le «differenze» sono compatibili?
- non esistono necessariamente dei fenomeni di rigetto?
- è possibile mettere legittimamente sullo stesso piano il sistema diusi/costumi/norme degli allogeni e quello degli indigeni?
- ci si può accontentare di giustapporre orizzontalmente delle «comunità» nel quadro di una «grande società» (di mercato)?
- e se no, su quali basi enunciare delle norme collettive sovracomunitarie?
- un «patriottismo costituzionale» senza contenuto culturale?
In realtà, c’è da temere che l’opzione multiculturale non sia altro che l’intellettualizzazione di evoluzioni che si è ormai rinunciato a controllare, avendo come orizzonte una società di mercato all’americana in cui le
solidarietà comunitarie giochino il ruolo di assistenti sociali.
Ricordiamo che gli insiemi multiculturali, particolarmente gli imperi, che hanno preceduto e/o sono coesistiti con gli Stati – Nazione, e hanno saputo resistere al tempo, avevano un collante: lealismo dinastico, pratica di una medesima religione e patriottismo basato su di un’unica civiltà permettevano
di superare le differenze etnoculturali e linguistiche. Oggi, niente di tutto questo!
L’opzione multiculturale va dunque rivista secondo il metro della ragione politica, quand’anche la ragione filosofica dovesse soffrirne. Per assicurare il necessario primato demografico, culturale e politico degli
autoctoni bisogna rispettare qualche condizione sine qua non: controllo e inversione dei flussi migratori; cittadinanza piena e totale per i soli indigeni e assimilati; politica prevalentemente nazionale ed europea. Le popolazioni immigrate non-assimilate non beneficerebbero né della cittadinanza né di un certo numero di diritti ad essa connessi, ma in compenso esse si vedrebbero concedere uno statuto di popolo – ospite. A queste condizioni, l’opzione multiculturale è compatibile con la perennità delle nostre identità europee; in caso contrario, essa sfocerà immancabilmente in situazioni drammatiche, poiché i paesi d’accoglienza
dei flussi migratori saranno lacerati fra civiltà diverse. Le cose sono già molto avanti su questa china…
IL RINNOVAMENTO DELLE PROBLEMATICHE «INTERNAZIONALI»
L’espansione delle correnti migratorie mondiali e la moltiplicazione delle diaspore partecipano, con i movimenti di valuta e di capitale (si pensi al mega-mercato finanziario mondiale) e la rivoluzione delle comunicazioni, alla complessificazione delle relazioni cosiddette internazionali, dal momento che nuovi attori s’impongono sulla scena mondiale.
Dal XVI al XX secolo, lo spazio mondiale si è venuto progressivamente lastricando di Stati — forma politica che ha conosciuto l’apogeo nel XIX secolo. Attore totale, lo Stato-Nazione è l’unico soggetto del diritto
internazionale; dopo il 1945, il fenomeno di territorializzazione (appropriazione delle terre emerse) si è esteso all’Oceano mondiale.
Oggi si contano circa 200 Stati, 185 dei quali sono membri dell’ONU.
Tuttavia la mondializzazione dell’ordine statuale e territoriale non può dissimulare altre e più gravi tendenze. L’«èra occidentale» è stata segnata anche dalla massificazione dei flussi di ogni tipo, particolarmente nella seconda metà del XX secolo: flussi di merci, di capitali, d’immagini e di suoni, e infine di uomini. Contrariamente alla crisi del 1929, quella del 1973 non ha affatto rallentato il movimento bensì l’ha accelerato: grazie a questo, reti molteplici — anche migratorie — scavalcano i territori statali.
Dunque nuovi attori si affermano — aziende transnazionali e multinazionali, organizzazioni non-governative, mafia, sette… e diaspore. Così queste catene di «colonie» e di enclaves collegate da flussi più o meno intensi, avvolgono doppiamente gli Stati-Nazione. Dall’alto, con le reti transnazionali che
esse costituiscono; dal basso, con la formazione di comunità infra-nazionali che si autoregolano. A fianco degli Stati, ineludibili ma di fatto elusi, e non più in grado di padroneggiare in modo esclusivo il gioco mondiale, si affermano dunque delle forze transnazionali, «attori anomici ed esotici», legate alle migrazioni passate e presenti. Le questioni della Svizzera, Stato sovrano, col Congresso Ebraico mondiale danno l’idea della potenza di alcune di queste forze.
Altra conseguenza dei flussi migratori, lo «scontro delle civiltà» descritto e analizzato da Samuel P. Huntington. È noto che secondo il geopolitologo americano la politica mondiale si ricompone secondo degli assi culturali, e le linee di frattura traccerebbero nuove frontiere fra le civiltà. Il metodo
di suddivisione scelto da Huntington è certo contestabile — si pensi alla confusione di Europa e America del Nord in una stessa civiltà occidentale da un lato, e dall’altro il limite stabilito fra cristianità latina e
cristianità greca (spazio slavo-ortodosso) — ma il modello interpretativo che egli propone, il «paradigma civilizzazionale», non è privo d’interesse.
Per riprendere le categorie utilizzate da questo autore, non si può fare a meno di constatare che le civiltà occidentale e slavo-ortodossa dividono uno stesso destino demografico. Altri autori — Yves Lacoste (Silhouetter le troisième millénaire. Tout sauf la fin de l’histoire, in “Le Monde”, 24 ottobre 1997) e Yves-Marie Laulan (Les nations suicidaires, op. cit.) — adottano del resto una definizione di Occidente allargata, che comprende America del Nord, Europa e Russia. In questo senso l’Occidente — il
«mondo-razza bianco», per dirla con Jean Cau — dovrebbe confrontarsi con le civiltà demograficamente massicce: arabo-musulmana, negro-africana, indiana e cinese.
Al riguardo, le proiezioni della Banca Mondiale, pubblicate nel 1994 poco prima della conferenza dell’Onu sulle popolazioni e lo sviluppo organizzata al Cairo, sono particolarmente illuminanti. Da qui al 2030 la
popolazione dovrebbe raggiungere la cifra di 8,5 miliardi (+ 50%) e, soprattutto, le dinamiche regionali saranno destinate a differenziarsi profondamente: l’Europa, Russia inclusa, passerebbe da 731 a 742 milioni di individui (+2%); l’Asia da 3,4 a 5,1 miliardi (+ 35%); l’Africa da 720 milioni a 1,6 miliardi
(+ 103%); l’America del Nord da 295 a 368 milioni (+ 25%); l’America Latina da 475 a 715 milioni (+ 50%). Si può dunque rilevare la forte atonia demografica delle popolazioni di ceppo europeo, tanto più che il tasso di crescita previsto per l’America del Nord, certo più importante che in Europa, sarebbe dovuto soprattutto alla forza dell’immigrazione e alla fecondità delle minoranze etniche. Secondo altre stime recenti, di qui a trent’anni i “Caucasici” (Americani di ceppo europeo) rappresenteranno il 52% della popolazione degli Stati Uniti, contro il 73% di oggi.
Queste dinamiche demografiche differenziate inducono una nuova geografia strategica, quella delle interfacce Nord/Sud: la frontiera Usa/Messico, fra America del Nord e America Latina; più ancora la frontiera Mediterranea, fra Europa e Africa; e il lato meridionale della Russia, contiguo alle aree arabo-musulmana e sino-confuciana. Queste linee di divisione sul piano demografico e su quello civilizzazionale sono dei potenziali fronti di aggressività, con qualche riserva sul Rio Grande. Naturalmente la geografia
strategica non si riduce a queste zone polemogene; è possibile circoscrivere molte altre linee di frattura, relative a poste ben altro che demografiche.
Del resto, migrazioni e diaspore comportano lo straripamento di certe civiltà sulle aree di altre civiltà. Qui è necessario ricorrere alla descrizione fatta da Huntington della struttura di una civiltà: al
centro, lo Stato o gli Stati faro, i più potenti e i più centrali dal punto di vista culturale; intorno, gli Stati membri che s’identificano pienamente, in termini culturali, con la loro civiltà d’appartenenza; alla periferia,
paesi divisi, a cavallo di una o più frontiere di civiltà, con importanti differenze culturali fra le loro componenti umane; all’estrema periferia, negli Stati delle civiltà adiacenti, minoranze culturalmente affini.
Questo schema può essere facilmente applicato alle situazioni geopolitiche contemporanee. Così la civiltà arabo-musulmana beneficia dello scambio con importanti minoranze culturalmente affini nell’ecumene europeo, particolarmente dinamiche sul piano demografico e religioso e, dopo gli accordi di Dayton (1995), con un’entità musulmana, il principato di Sarajevo. Del pari, la civiltà cinese dispone, con le sue importanti minoranze d’oltremare, di una «rete di bambù» estesa sull’Asia del Sud-Est ma anche sull’America del Nord e, benché in misura minore, sull’Europa Occidentale. Lo «scontro delle civiltà» è anche interno. Strettamente legata con l’interazione generalizzata degli spazi e delle popolazioni —questa è una delle definizioni del mondialismo — è l’elaborazione di nuovi modelli conflittuali a partire da situazioni osservabili.
Primo modello, l’intervento esterno, divenuto frequente con le numerose crisi statuali e la riconfigurazione del sistema internazionale. Dopo la fine del conflitto Est/Ovest, le potenze cosiddette occidentali (e la
Russia) manifestano una spiccata propensione agli interventi esterni sui loro confini meridionali per mantenervi una certa stabilità. I governi cercano soprattutto di evitare un confronto diretto con flussi improvvisi e massicci di rifugiati politici e, nel quadro di una politica di controllo dei flussi migratori, intendono tenere la situazione ben salda in pugno.
Dunque gli eserciti sono ristrutturati in modo da poter condurre a buon fine questo tipo di operazione (forze ridotte ma flessibili ed estremamente mobili). Questi interventi non sono sempre militari e aperti: vi si
devono includere le politiche di sostegno agli Stati-cuscinetto e ai regimi-bunker del «Sud».
Altro modello conflittuale, quello dei conflitti identitari. François Thual** (Les conflits identitaires, Ellipse-IRIS, 1995) ha descritto e teorizzato questo scontro dei caos limitati del Sud e, in Europa, quelli
dei Balcani e del Caucaso. Quando questi conflitti si scatenano in prossimità degli spazi sviluppati del «Nord», essi inducono le grandi potenze a intervenire. Questa forma di conflitto mette alle prese gruppi
culturalmente/religiosamente differenziati (etnie, nazionalità, confessioni religiose), ciascuno dei protagonisti essendo convinto del pericolo di estinzione (processo di vittimizzazione). I mezzi di comunicazione moderni permettono di mobilitare le popolazioni interessate e la diaspora, se c’è diaspora, che in tal caso assicura il sostegno economico e lo scambio mediatico. Le ricomposizioni della geografia umana dei paesi sviluppati potrebbero portare benissimo all’estensione di questo tipo di conflitto, prefigurato, su scala minore, dagli scontri etnici delle periferie.
Questo rapido giro panoramico sui fenomeni migratori e sul fatto diasporico ha mostrato gli stretti legami esistenti fra il mercato del sistema-Mondo e la crescente potenza dei flussi umani. Il sistema-Mondo è di fatto un sistema di mobilità fondato sulla messa in relazione generalizzata (mondializzazione/globalizzazione) e l’elogio del nomade (Jacques Attali, Lignes d’horizon, Fayard, 1990). Esso genera una delocalizzazione planetaria e uno sradicamento massiccio di cui la «crisi migratoria globale» (S. P. Huntington) è l’aspetto più visibile e più gravido di conseguenze.
Gli effetti destrutturanti dei flussi transnazionali — umani, commerciali, finanziari, informativi — sono tali che sembra necessario imporre loro una logica politica e quindi riterritorializzarli. Se è vero che lo Stato-Nazione resta un elemento fondamentale del sistema-Mondo, è anche vero che esso attualmente è superato dall’estensione delle scale geografiche e dalla potenza dei flussi planetari, segnatamente umani. La «crisi migratoria globale», come gli altri aspetti della mondializzazione, richiedono dunque una riflessione sul rinnovamento delle forme politiche. Qualcuno si richiama agli imperi.
* Autore con Robert Steuckers e Gunther Maschke del volume “Idee per una geopolitica europea”, pubblicato dalla Società Editrice Barbarossa
** Autore del volume “Geopolitica dell’ortodossia”, pubblicato in Italia dalla Società Editrice Barbarossa




 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg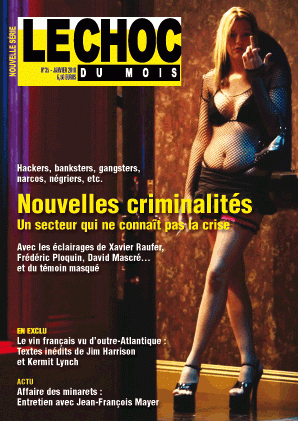 « Chaos mondial : la face noire de la mondialisation », par Alain Bauer et Xavier Raufer
« Chaos mondial : la face noire de la mondialisation », par Alain Bauer et Xavier Raufer