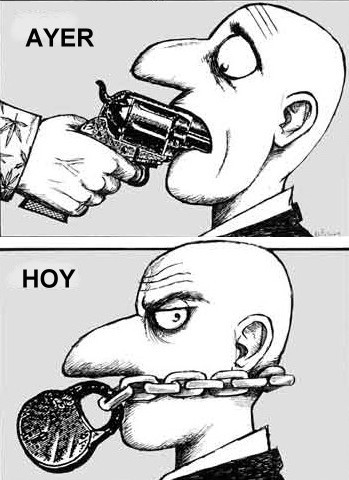Articolo di Marco Iacona
Articolo di Marco IaconaDal Secolo d'Italia di martedì 3 febbraio 2009

 ppresentano al meglio quella nuova sintesi verso la quale, nel suo esito post-totalitario, il Novecento auspicava nel profondo. È il caso di figure come Charles Peguy, Hannah Arendt, Albert Camus o l’Ernst Jünger del secondo dopoguerra. Figure nel cui pensiero si conciliava l’apparentemente inconciliabile: la spiritualità e la trasformazione politica, la libertà e la tradizione, la battaglia per i diritti sociali e l’adesione al principio di realtà. È questo anche, e soprattutto, il caso di Simone Weil, di cui proprio oggi ricorre il centenario della nascita. In Italia fu Adriano Olivetti a tradurne per primo alcune opere già nei secondi anni Quaranta e saranno, successivamente, Cristina Campo, Alfredo Cattabiani e Augusto Del Noce a valorizzarne l’importanza filosofica, in particolare la riscoperta moderna del platonismo. Un editore non di sinistra come Rusconi pubblicherà il fondamentale La Grecia e le intuizioni precristiane e, infine, le edizioni Adelphi di Roberto Calasso ne tradurranno quasi l’intera opera a cominciare dalle Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale. Una pensatrice, la Weil, che sfugge a
ppresentano al meglio quella nuova sintesi verso la quale, nel suo esito post-totalitario, il Novecento auspicava nel profondo. È il caso di figure come Charles Peguy, Hannah Arendt, Albert Camus o l’Ernst Jünger del secondo dopoguerra. Figure nel cui pensiero si conciliava l’apparentemente inconciliabile: la spiritualità e la trasformazione politica, la libertà e la tradizione, la battaglia per i diritti sociali e l’adesione al principio di realtà. È questo anche, e soprattutto, il caso di Simone Weil, di cui proprio oggi ricorre il centenario della nascita. In Italia fu Adriano Olivetti a tradurne per primo alcune opere già nei secondi anni Quaranta e saranno, successivamente, Cristina Campo, Alfredo Cattabiani e Augusto Del Noce a valorizzarne l’importanza filosofica, in particolare la riscoperta moderna del platonismo. Un editore non di sinistra come Rusconi pubblicherà il fondamentale La Grecia e le intuizioni precristiane e, infine, le edizioni Adelphi di Roberto Calasso ne tradurranno quasi l’intera opera a cominciare dalle Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale. Una pensatrice, la Weil, che sfugge a  qualsiasi facile classificazione di natura ideologica: da ebrea si avvicinò alla fede cattolica, socialista e molto legata al sindacalismo rivoluzionario scoprirà che una vera rivoluzione s’invera nella religione, studiosa di livello sceglierà di andare a lavorare in fabbrica per sperimentare la questione sociale del Novecento.
qualsiasi facile classificazione di natura ideologica: da ebrea si avvicinò alla fede cattolica, socialista e molto legata al sindacalismo rivoluzionario scoprirà che una vera rivoluzione s’invera nella religione, studiosa di livello sceglierà di andare a lavorare in fabbrica per sperimentare la questione sociale del Novecento. na, le condizioni). L’analisi filosofica di Simone Weil, asistematica e irregolare, difficilmente collocabile all’interno delle correnti tradizionali, ha purtroppo finito per passare in secondo piano rispetto al vissuto dell’autrice. Ci si trovava immedrsi, a suo dire, in un mondo moderno dove nulla è a misura dell’uomo, dove tutto è squilibrio e la società è collettività cieca, trasformata in una macchina per comprimere cuore e spirito e per fabbricare l’incoscienza. Separando il lavoro dalla conoscenza, la società moderna e soprattutto la società industriale, avervano aumentato enormemente la complessità della sua organizzazione, ponendo quindi le condizioni per un potere sempre più forte che tende a riprodursi anche là dove è stata fatta una rivoluzione. Emerge, già da queste sue analisi, il grande contributo weiliano a quel pensiero anti-totalitario e post-totalitario che è ancora oggi l’orizzonte sul quale si muove il dibattito pubblico. Ma
na, le condizioni). L’analisi filosofica di Simone Weil, asistematica e irregolare, difficilmente collocabile all’interno delle correnti tradizionali, ha purtroppo finito per passare in secondo piano rispetto al vissuto dell’autrice. Ci si trovava immedrsi, a suo dire, in un mondo moderno dove nulla è a misura dell’uomo, dove tutto è squilibrio e la società è collettività cieca, trasformata in una macchina per comprimere cuore e spirito e per fabbricare l’incoscienza. Separando il lavoro dalla conoscenza, la società moderna e soprattutto la società industriale, avervano aumentato enormemente la complessità della sua organizzazione, ponendo quindi le condizioni per un potere sempre più forte che tende a riprodursi anche là dove è stata fatta una rivoluzione. Emerge, già da queste sue analisi, il grande contributo weiliano a quel pensiero anti-totalitario e post-totalitario che è ancora oggi l’orizzonte sul quale si muove il dibattito pubblico. Ma  veniamo a lei. Il suo stesso volto da eterna e pensosa giovane – i suoi occhi così grandi in un ovale imperfetto – ricorda una poesia triste, una poesia che raramente si legge in pubblico ma che ciascuno di noi ama ripetere fra sé e sé, alla ricerca di sottili verità. Verità umili e sofferte da sgranare come i chicchi di un Rosario. Come dicevamo, Simone oggi avrebbe cento anni, un’età patriarcale impossibile da raggiungere da una come lei che la vita la sudò fino all’ultima goccia. Nata e cresciuta in un mondo colmo di afflizioni ed ella stessa di salute cagionevole, interpretò la vita al pari di un vero grande scrittore contemporaneo, mescolando la teoria alla pratica, la fede – quella con la F maiuscola – alla parola, la speranza alla fatica, il lavoro al sublime pensiero. E mescolando, sopra ogni cosa, la cerca delle più grandi verità (c
veniamo a lei. Il suo stesso volto da eterna e pensosa giovane – i suoi occhi così grandi in un ovale imperfetto – ricorda una poesia triste, una poesia che raramente si legge in pubblico ma che ciascuno di noi ama ripetere fra sé e sé, alla ricerca di sottili verità. Verità umili e sofferte da sgranare come i chicchi di un Rosario. Come dicevamo, Simone oggi avrebbe cento anni, un’età patriarcale impossibile da raggiungere da una come lei che la vita la sudò fino all’ultima goccia. Nata e cresciuta in un mondo colmo di afflizioni ed ella stessa di salute cagionevole, interpretò la vita al pari di un vero grande scrittore contemporaneo, mescolando la teoria alla pratica, la fede – quella con la F maiuscola – alla parola, la speranza alla fatica, il lavoro al sublime pensiero. E mescolando, sopra ogni cosa, la cerca delle più grandi verità (c osì come viene fuori dai suoi Quaderni), alla preziosa ma passiva attesa che saranno esse stesse – le verità – a manifestarsi nel cuore degli uomini prima o dopo. Ci ha lasciato oltre che la forza di un pensiero innalzato sulle fondamenta della realtà sociale, l’immagine di una tenue dolcezza (e di un amore sincero): la compagna di una scelta di vita che obbliga al rispetto, quasi all’adorazione, da qualsiasi parte – quella scelta di vita – la si contempli e da qualsiasi parte si scelga d’ammirarla. La sua vita è stata un romanzo interrotto, forse, nel capitolo più bello. Simone Weil era stata tentata dal marxismo (ma mai scritta ad alcun partito), anarco-sindacalista e rivoluzionaria, una donna pugnace dunque che era partita volontaria per la guerra di Spagna già nel ’36, militando ovviamente fra le fila degli anarchici. Di professione era stata una insegnate di filosofia nei licei francesi fino al 1934, fino a quando cioè aveva capito che occupare una comoda sedia (pontificando su questo e quello), sarebbe stato solo
osì come viene fuori dai suoi Quaderni), alla preziosa ma passiva attesa che saranno esse stesse – le verità – a manifestarsi nel cuore degli uomini prima o dopo. Ci ha lasciato oltre che la forza di un pensiero innalzato sulle fondamenta della realtà sociale, l’immagine di una tenue dolcezza (e di un amore sincero): la compagna di una scelta di vita che obbliga al rispetto, quasi all’adorazione, da qualsiasi parte – quella scelta di vita – la si contempli e da qualsiasi parte si scelga d’ammirarla. La sua vita è stata un romanzo interrotto, forse, nel capitolo più bello. Simone Weil era stata tentata dal marxismo (ma mai scritta ad alcun partito), anarco-sindacalista e rivoluzionaria, una donna pugnace dunque che era partita volontaria per la guerra di Spagna già nel ’36, militando ovviamente fra le fila degli anarchici. Di professione era stata una insegnate di filosofia nei licei francesi fino al 1934, fino a quando cioè aveva capito che occupare una comoda sedia (pontificando su questo e quello), sarebbe stato solo  un pratico lasciapassare per una buona carriera. Redditizia e borghese. Una carriera dimentica della rilevanza e della dignità dell’altro da sé, con la voce “giustizia” confinata all’interno di un freddo manuale di storia ad uso scolastico. Così aveva deciso di rimettersi in gioco, d’inventarsi salariata della Renault di Parigi per conoscere e toccare con mano le condizioni della classe operaia. Per dividere e condividere le sofferenze di chi a quel tempo sembrava davvero riassumere i mali di quella fetta di genere umano chiamato Occidente. Ovvio che i temi ricorrenti negli scritti della Weil (tutti usciti postumi a cura di padre Joseph-Marie Perrin e del grande pensatore cattolico Gustav Thibon con la collaborazione di Albert Camus), fossero quelli della miseria, della schiavitù e dell’oppressione. Ed altrettanto ovvio che uno dei suoi rimedi per porre fine alle condizioni sfavorevoli dei più deboli fosse quel vero, sano, umanismo calpestato da qualsiasi rivoluzione in qualunque epoca storica.
un pratico lasciapassare per una buona carriera. Redditizia e borghese. Una carriera dimentica della rilevanza e della dignità dell’altro da sé, con la voce “giustizia” confinata all’interno di un freddo manuale di storia ad uso scolastico. Così aveva deciso di rimettersi in gioco, d’inventarsi salariata della Renault di Parigi per conoscere e toccare con mano le condizioni della classe operaia. Per dividere e condividere le sofferenze di chi a quel tempo sembrava davvero riassumere i mali di quella fetta di genere umano chiamato Occidente. Ovvio che i temi ricorrenti negli scritti della Weil (tutti usciti postumi a cura di padre Joseph-Marie Perrin e del grande pensatore cattolico Gustav Thibon con la collaborazione di Albert Camus), fossero quelli della miseria, della schiavitù e dell’oppressione. Ed altrettanto ovvio che uno dei suoi rimedi per porre fine alle condizioni sfavorevoli dei più deboli fosse quel vero, sano, umanismo calpestato da qualsiasi rivoluzione in qualunque epoca storica. italismo industriale; in esso aveva posto al centro della società il valore del lavoro non più rigidamente diviso in lavoro manuale e lavoro intellettuale, causa profonda secondo lei di ingiustizia. In Oppressione e libertà invece aveva denunciato alcune forme di varia oppressione, quella dovuta all’uso della forza, quella dovuta al capitale e quella dovuta appunto alla divisione del lavoro. Un giorno però messa a dura prova da un’esperienza professionale e di vita (il lavoro in fabbrica appunto), nella quale il semplice apporto volontaristico sembrava non essere più sufficiente, la giovane Weil imprime alle sue riflessioni e ai suoi modi una direzione in senso affatto teologico. Cristo? Sì il Cristo dei Vangeli venuto a redimere l’uomo… Lui poteva mostrarsi quale “pietra angolare”, capace di dar ragione alle sue sofferenze, capace di motivare le sue sopportazioni e di assegnare un significato alle infinite realtà e con esse al passato filosofico e al visto e al non-visto. Nel 1937 (non a caso ad Assisi), c’è così la svolta nella vita dell’agnostica Simone Weil. Quella crisi mistica che la condurrà a cercare anche con estrema durezza verso se stessa, una conoscenza diretta della Verità e della Bellezza, dunque – per lei – della divinità. La conoscenza di quel Dio la cui vicinanza è condizione essenziale perché l’uomo sconfigga l’infelicità che lo possiede, di quel Dio di fronte al quale è opportuno annullarsi e annullare il proprio io (“decreando” quello che lui ha creato limitandosi, cioè noi stessi).
italismo industriale; in esso aveva posto al centro della società il valore del lavoro non più rigidamente diviso in lavoro manuale e lavoro intellettuale, causa profonda secondo lei di ingiustizia. In Oppressione e libertà invece aveva denunciato alcune forme di varia oppressione, quella dovuta all’uso della forza, quella dovuta al capitale e quella dovuta appunto alla divisione del lavoro. Un giorno però messa a dura prova da un’esperienza professionale e di vita (il lavoro in fabbrica appunto), nella quale il semplice apporto volontaristico sembrava non essere più sufficiente, la giovane Weil imprime alle sue riflessioni e ai suoi modi una direzione in senso affatto teologico. Cristo? Sì il Cristo dei Vangeli venuto a redimere l’uomo… Lui poteva mostrarsi quale “pietra angolare”, capace di dar ragione alle sue sofferenze, capace di motivare le sue sopportazioni e di assegnare un significato alle infinite realtà e con esse al passato filosofico e al visto e al non-visto. Nel 1937 (non a caso ad Assisi), c’è così la svolta nella vita dell’agnostica Simone Weil. Quella crisi mistica che la condurrà a cercare anche con estrema durezza verso se stessa, una conoscenza diretta della Verità e della Bellezza, dunque – per lei – della divinità. La conoscenza di quel Dio la cui vicinanza è condizione essenziale perché l’uomo sconfigga l’infelicità che lo possiede, di quel Dio di fronte al quale è opportuno annullarsi e annullare il proprio io (“decreando” quello che lui ha creato limitandosi, cioè noi stessi). Di quel Dio che non va cercato, perché si incontra semplicemente non amando tutto ciò che Egli stesso non è. Di quel Dio che, infine, si manifesterà se impariamo ad accettarlo così com’è; e del resto come è opportuno che Egli stesso venga accettato.
Di quel Dio che non va cercato, perché si incontra semplicemente non amando tutto ciò che Egli stesso non è. Di quel Dio che, infine, si manifesterà se impariamo ad accettarlo così com’è; e del resto come è opportuno che Egli stesso venga accettato. rema coerenza (da ebrea fu costretta a fuggire dalla Francia di Vichy a rifugiarsi per poco tempo in America, e poi stabilirsi in Inghilterra ove morì). Una Chiesa nel cui grembo Simone non entrerà mai, rimandando il battesimo e con esso l’ingresso ufficiale nella comunità dei cristiani, rifiutando tutto quel che di feroce e oppressivo era stato avallato dalla Chiesa fino a quel dato momento. Ma forse Simone – morta troppo giovane – non ebbe il tempo per fare il passo definitivo.
rema coerenza (da ebrea fu costretta a fuggire dalla Francia di Vichy a rifugiarsi per poco tempo in America, e poi stabilirsi in Inghilterra ove morì). Una Chiesa nel cui grembo Simone non entrerà mai, rimandando il battesimo e con esso l’ingresso ufficiale nella comunità dei cristiani, rifiutando tutto quel che di feroce e oppressivo era stato avallato dalla Chiesa fino a quel dato momento. Ma forse Simone – morta troppo giovane – non ebbe il tempo per fare il passo definitivo.



 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg