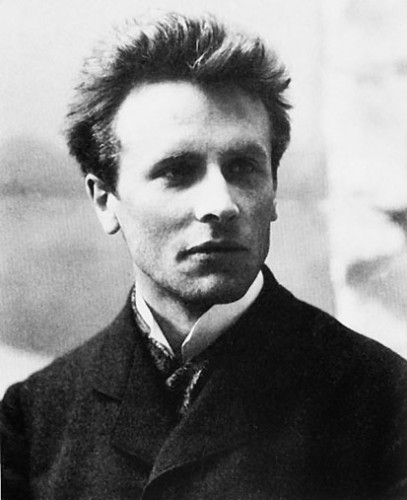vendredi, 20 mars 2009
Ernst Jünger et le retour aux Grecs

Ernst Jünger et le retour aux Grecs
(conférence d'Isabelle Fournier lors de l'Université d'été de la FACE, juillet 1995)
L'œuvre jüngerienne est, selon l'auteur lui-même, divisée en deux parties, un “ancien testament” (1920-1932), dont le fleuron est Le Travailleur (1932) et un “nouveau testament”, commencé par Sur la douleur. Pour Jünger, comme pour tous les hommes de culture en Europe, le recours aux Grecs est une démarche essentielle, malgré l'irrevéresibilité de l'histoire. Aujourd'hui, époque nihiliste, la clef de voûte de la civilisation hellénique, c'est-à-dire la Cité, s'effondre. L'homme libre doit la quitter, retourner à la forêt, au resourcement.
Dans l'œuvre jüngerienne, le symbolisme de la Cité est essentiel. Du temps des Grecs, la Cité s'opposait au chaos des périphéries incultes et sauvages. Mais cette Cité, symbole de l'empire que l'homme est parfois capable d'exercer sur lui-même, est périssable, comme nous le constantons, constat qui autorise à proclamer son imperfection. Jünger s'intéresse à la signification de cette mort des cités. Dans le monde grec, la Cité, justement, permettait d'élaborer, à l'abri du chaos, une pensée rationnelle, se substituant progressivement au mythe, fondateur de la culture initiale. L'esprit grec est celui qui a inscrit la pensée humaine dans la mémoire et la durée. C'est Hérodote qui fait passer l'hellénité du mythe à l'histoire. C'est aussi dans cette intersection que se situe Thucydide. Mais cette construction va s'éroder, s'effondrer. Nous sommes alors entrés dans l'âge des cités imparfaites.
Les cités imparfaites découlent de la dévaluation des valeurs supérieures: elles annoncent le nihilisme. La décadence est le concours de l'érosion de l'autorité spirituelle, de la dissolution des hiérarchies et du déclin de la langue. Le temps des virtualités religieuses est épuisé, l'unité mentale du peuple n'existe plus, les fidélités communautaires sont fissurées, on rompt avec le mos majorum. La Cité des Falaises de marbre est une de ces cités imparfaites, où il n'y a plus unité de culte, où les rites funéraires sont en déchéance, banalisés par la technique, où le sacré se retire, où la raison n'est plus qu'un outil de puissance. Mais Jünger sait surtout que l'on n'exhume pas les dieux morts. Dans Heliopolis, il se penche sur cette question du vide laissé par ces dieux et place cette autre cité imparfaite qu'imagine son génie poétique, à l'enseigne des néo-spiritualismes, palliatifs éphémères et maladroits à cette déchéance. Toute chute est précédée d'un affaiblissement intérieur, nous dit Jünger. Comment supporter ce déclin, qui est en même temps terreur? Par la fuite. Les héros jüngeriens présentent dès lors des itinéraires individuels tout de solitude, de nostalgie du monde originel, d'inquiétude existentielle. Ils sont volontairement des étrangers à l'histoire.
Œuvre et des cités primordiales et des cités imparfaites, l'œuvre de Jünger est aussi celle qui tente de donner un sens à cette fuite. L'homme peut-il guérir d'un monde foncièrement vicié? Oui, à condition de passer par l'athanor de la souffrance (de la douleur). Oui, à condition de recourir aux archétypes féminins, de retourner à la Grande Mère, retour qui est simultanément “réhabilitation du temps”.
(notes prises par Etienne Louwerijk et Catherine Niclaisse).
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, révolution conservatrice, traditions, grèce antique, antiquité grecque, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 12 mars 2009
De traditionele Vlaamse Studentenbeweging
De traditionele Vlaamse Studentenbeweging
Ex: http://onsverbond.wordpress.com/
De oorspronkelijke betekenis van de Vlaamse studentenbeweging.
De traditionele katholieke Vlaamse studentenbeweging verenigde alle katholieke en conservatief-nationalistische studentenclubs in de geest van Albrecht Rodenbach en zijn Blauwvoeterij. Rodenbach stelde zijn talenten en energie ten dienste van wat hij de ‘Vlaamsche studentenkamp’ noemde, de toen opkomende katholieke Vlaamse studentenbeweging. In zijn krachtige oproep tot nationaal zelfbewustzijn ligt Rodenbachs voornaamste betekenis en daarvoor inspireerden generaties studenten zich op hem, zelfs tot op heden. Hij onderstreepte de eigen rol die de studerende jeugd daarin te vervullen had en gaf aan zijn generatiegenoten een zendingsbewustzijn dat sindsdien gemeengoed werd bij katholieke scholieren en studenten[1]. Op methodologisch vlak ontdekte hij de kracht van zang en toneel voor de propagandistische werking. Alzo bleef toneel tot de jaren 1930 een typische activiteit van de studentenbonden. Door het ontwikkelen van de Blauwvoetromantiek reikte Albrecht Rodenbach bovendien de vele studentengeneraties een symboliek aan, waarvan hij zelf ten gevolge van zijn vroegtijdige dood ook een onderdeel werd. Daardoor werd hij binnen de traditionele Vlaamse studentenbeweging een echte mythe[2].
Rodenbachs opvolgers streefden er tevens naar het clubleven stijlvol te laten verlopen. Zo introduceerde Jef vanden Eynde stijl in de studentenbeweging, terwijl Mon De Goeyse vanden Eyndes stijlgebruiken verder uitwerkte en perfectioneerde door onder meer de clubcodex op te stellen. De drie voornoemde studentenleiders vormden de Vlaamse studentenbeweging naar de Duitse studententradities, meer bepaald naar het model van de Duitse Burschenschaften. De Vlaamse studenten raakten zo eigen aan deze traditie, dat zij later zelfs niet meer beseften dat deze van Duitse oorsprong was[3].
Een ander belangrijk gegeven is dat de tradities van de Vlaamse studentenbeweging ontwikkeld werden binnen het Vlaamsch Verbond aan de Katholieke Universiteit van Leuven. In 1911 namen dit Leuvense Vlaamsch Verbond en de Gentse Rodenbachs Vrienden gezamenlijk de naam Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond van België (KVHVB) aan. Vanuit Leuven werden deze studententradities verspreid naar de andere studentensteden. Het is ook daardoor dat zich onder de Leuvense overkoepeling der Vlaamse studentenclubs, namelijk KVHV-Leuven, zowel de andere KVHV-afdelingen als de regionale studentenclubs plaatsten[4].
De Vlaamse studentenbeweging was ook een samenhangend geheel: nagenoeg alle katholieke studenten waren politiek conservatief-nationalistisch en hingen de Vlaamse studententradities aan. Ze beschouwden zichzelf ook duidelijk als een onderdeel van de Vlaamse Beweging en fungeerden als één geheel wanneer het overkoepelende bestuur opriep voor grote manifestaties, zoals de Groot-Nederlandse Studentencongressen, de Ijzerbedevaarten, de vernederlandsing van de Rijksuniversiteit Gent, de Koningskwestie, de Schoolstrijd, de sluiting van de mijn van Zwartberg, Leuven Vlaams enzovoort[5].
Er was in de Vlaamse studentenbeweging ook altijd een streven naar volksverheffing, opvoeding, vorming, bewustzijn van eigenwaarde en fierheid. Dit gaat terug op het beeld dat Albrecht Rodenbach had van de Vlaamse nationaliteit, die hij weerspiegeld vond in het door Joseph Kervyn de Lettenhove geïdealiseerde oude Kerelsvolk met zijn vrijheidsdrang, zijn ontembare fierheid, zijn heldenmoed, zijn trouw aan de ruwe Noordse aard en gebruiken. Met zijn studentenbeweging wilde Rodenbach een Kulturkampf voeren, het volk wekken tot een nationaal bewustzijn door de herbronning van het onderwijs, de kunst en de gehele cultuur van volkstradities. Alleen zo kon volgens hem het land gered worden van de verfransende loge. Albrecht Rodenbach was de harstochtelijkste vertegenwoordiger van de nationale heldenromantiek in Vlaanderen. De jaren 1877-1879 waren voor zijn letterkundige bedrijvigheid ongemeen vruchtbare jaren. In 1879 werd hij door de stad Antwerpen bekroond voor zijn drama ‘Gudrun’. De traditionele Vlaamse student was ook onmiskenbaar politiek actief, zonder onderhevig te zijn aan enige druk van buitenaf. Dit was de kracht van de traditionele student: de enige vrije, ongebonden denker in de maatschappij. Rodenbach zag de wederopstanding van zijn volk als de taak van een elite, die door overtuiging en overredingskracht de massa zou bezielen en de macht veroveren om in een Groot-Nederlands perspectief de doelstellingen van de Vlaamse Beweging te verwezenlijken[6].
Herkomst van de Vlaamse studentenbeweging.
De Vlaamse studentenbeweging ontstond omstreeks 1870 in de West-Vlaamse colleges met de Blauwvoeterij van Albrecht Rodenbach, waarbij de scholieren beïnvloed werden door een militante Zouavenbeweging[7] en door de ideologische strijd tussen klerikalen en anti-klerikalen. De West-Vlaamse scholieren paarden, onder invloed van hun priesters-leraars, een strijdend anti-liberalisme met een nationalistisch conservatisme, daar enkel door het behoud van de Vlaamse taal, godsdienst en zeden de rationalistische en ongodsdienstige Franse invloed kon worden tegengegaan[8]. De oorsprong van de studentenbeweging dient gezocht te worden bij de Duitse Burschenschaften, waarin Duitse studenten zich verenigden om het vaderland te bevrijden van de Napoleontische overheersing. Studenten in heel Europa raakten in de ban van hun romantische en nationalistische ideeën en tradities die ook Vlaanderen bereikten[9].
De Blauwvoeterij van Rodenbach, een dichter en een knap organisator, streefde de hergeboorte van een bewust Vlaams volk na en zocht hiervoor inspiratie in het romantische verleden van Vlaamse grootheid, zoals Hendrik Conscience dat geschetst had. Deze beweging deed met zijn typische symboliek (bijvoorbeeld de Blauwvoet, een mythische stormvogel), gedichten en liederen ook een nieuwe jeugdcultuur ontstaan. Vanaf 1876 zetten Rodenbach en zijn gezellen hun actie verder aan de Leuvense universiteit, waar zij een enorme organisatorische activiteit ontwikkelden. Om de studentenbeweging ook op nationaal vlak te organiseren riepen Albrecht Rodenbach en Pol De Mont in Gent in 1877 een algemene Vlaamse studentenbond in het leven, die echter na de vroegtijdige dood van Rodenbach in 1880 uiteenviel[10]. Rodenbach organiseerde dit verbond naar het voorbeeld van de Duitse Burschenschaften. Hij wou “een soort Vlaamsche Burschenschaft” en “een soort van strijdende Vlaamsche Knapenschap, om alzo de Vlaamsche Beweging te schenken, hetgeen de almachtige zegevierende Burschenschaft indertijd de Duitsche Beweging bijbracht”[11]. Op deze basis entte de traditionele Vlaamse studentenbeweging zich.
Albrecht Rodenbach wordt terecht beschouwd als dé bezieler van het Vlaamse studentenleven en werd dan ook door sommigen bijna mythisch vereerd. Zijn vroege dood (op vierentwintigjarige leeftijd) speelde hierin uiteraard mee. Hij werd het symbool en het ideaal van de Vlaamse studentengenootschappen. Zijn werkkracht, idealisme, sterk Vlaams volksgevoel en organisatorisch talent hadden een grote indruk op de studenten gemaakt. Zij droegen dan ook zijn naam en ideeën over op de volgende studentengeneraties. Het enorme morele gezag dat hij na zijn dood kreeg, maakte dat al zijn uitspraken en voorbeelden een steeds absolutere waarde kregen. Op die manier reikte hij de Vlaamse studentenbeweging de argumenten aan, die de invoering van de Duitse studententradities na 1900 rechtvaardigden. Rodenbach lag aldus niet alleen aan de grondslag van de Blauwvoetsymboliek, die hij zelf schiep, maar ook - indirect - aan die van de Vlaamse studententradities, die van Duitse oorsprong zijn[12].
Na 1880 begon de uitbouw van een Vlaams studentenleven te Leuven in de geest van de Blauwvoeterij met de oprichting van regionale (stads- of streekgebonden) clubs en (provinciale) gilden. De Vlaamse studenten wilden zo ontsnappen aan het Franstalige en vaak door professoren geleide studentenleven. Er ontstond ook een eigen Vlaamse studentencultuur, omdat zij zich wilden onderscheiden van de Franstalig-Belgische studententraditie. Na 1900 was er ook een Duitse invloed op het Vlaamse studentenleven, enerzijds vanuit een romantische interesse voor de Duitse studententraditie en anderzijds vanuit de behoefte zich te onderscheiden van de Waalse studenten. Zo werd in 1907 een eigen Vlaamse studentenpet ingevoerd naar Duits model. De regionale clubs en gouwgilden bleken echter al vlug Vlaamse gezelligheid te verkiezen boven politieke strijd. Daarom ontstond een kernwerking: de meest overtuigden verenigden zich in vijf provinciale strijdersbonden. Zij moesten - met succes - binnen de gilden de politieke actie aanwakkeren. In 1902 sloten deze vijf Vlaamse gouwgilden zich aaneen tot het Vlaamsch Verbond, dat zich in 1923 omvormde tot KVHV-Leuven. Van de jaren 1880 tot halverwege de 20ste eeuw zou de Vlaamse studentenbeweging te Leuven op hetzelfde stramien gebaseerd blijven: aan de basis regionale gezelligheidsverenigingen, die het voetvolk leverden voor de grote manifestaties; aan de top de radicale kern van het KVHV, die de strekking van de beweging bepaalde[13].
Rodenbachs geest bleef dus voortleven en, na een mislukte poging in 1890, ontstond in 1903 - een jaar na de stichting van het Vlaamsch Verbond als overkoepeling van de studentengenootschappen - een overkoepeling van de scholierenbonden aan de colleges: het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (AKVS). De scholieren- en studentenbeweging vulden elkaar zeer goed aan. De als scholier genoten vorming zorgde er voor dat de jongeren reeds als flamingant aan de Leuvense universiteit toekwamen, waar zij zich bij het KVHV aansloten. Vele KVHV-kopstukken speelden tevens een leidende rol in het AKVS, waardoor de samenhang van de beweging verzekerd was. Als jongerenafdeling van de Vlaamse Beweging stelde de katholieke Vlaamse studentenbeweging zich tot doel de leden te vormen voor hun taak in de maatschappij, maar hen tegelijk ook te richten op een actieve participatie aan de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Rodenbach had de collegeleerlingen voorgehouden dat ze zich tijdens hun opleidingsperiode moesten ontwikkelen tot authentieke Vlamingen: in taal, karakter (fier en trouw), gedrag (beleefdheid) en in kleding. Hiertoe moesten de eigen taal en geschiedenis bestudeerd worden[14].
De Vlaamse studententraditie is dus van oudsher van katholieke en conservatieve inslag. Door het prominent aanwezige katholicisme was het dan ook niet meer dan normaal dat deze beweging ontstond aan de Katholieke Universiteit van Leuven. De rol van de in de 19de eeuw verdienstelijke vrijzinnig-flamingantische studentenbeweging was na de Eerste Wereldoorlog uitgespeeld[15]. Het boek ‘Het aktivistisch avontuur’ van Daniël Vanacker geeft bijvoorbeeld een uitstekend beeld van de Gentse tegenhanger van de katholiek-flamingantische studentenbeweging. Daarnaast schetst dit werk ook zeer goed het experiment met de studentenbeweging aan de door de Duitsers vernederlandste universiteit in 1916-1918: men wou toen immers vrijzinnige en katholieke studenten door een godsvrede doen samengaan in een studentenkorps naar Nederlands model. Hiertoe richtte men het Gentsch Studentencorps Hou ende trou op[16].
Aan het eind van de 19de eeuw trad het cultuurflamingantisme op de voorgrond in de Vlaamse Beweging. Dit stelde dat de Vlaamse Beweging meer moest zijn dan een taalstrijd en het Vlaamse volk ook geestelijk en materieel diende te verheffen. Figuren als Lodewijk Dosfel en Frans Van Cauwelaert vertolkten dit cultuurflamingantisme in de studentenbeweging. Er ontstond onder de Leuvense studenten ook een stroming die zich afzette tegen het vrijblijvende ‘bierflamingantisme’ van de clubs en de gilden. Het Leuvense cultuurflamingantisme kende een hoogtepunt ten tijde van de grote studentenleider Jef vanden Eynde, praeses van het Vlaamsch Verbond (KVHV) in 1905-1907, die het Vlaamse studentenleven cultureel wou verheffen. Daartoe haalde hij toondichters, letterkundigen en Vlaamse voormannen naar Leuven voor voordracht-, muziek- en toneelavonden. Ten gevolge hiervan richtten nu ook de gouwgilden dergelijke avonden in. Van Ons Leven, het tijdschrift van het Vlaamsch Verbond, waarvan vanden Eynde zeven jaar hoofdredacteur was (1901-1908), maakte hij een hoogstaand weekblad, waarin de Vlaamse kunst een aanzienlijke plaats kreeg. Ook het studentenlied werd op een hoger echelon geplaatst[17].
Jef vanden Eynde schreef zelfs eigenhandig enkele studentenliederen, waaronder de tekst en de muziek van het Verbondslied van KVHV-Leuven. Hij vertaalde ook een groot aantal Duitse studentenliederen in het Nederlands. Het was ook vanden Eynde die in 1907 - steeds bekommerd om stijl in het studentenleven - de slonzige groene studentenpet verving door de keurige Duitse studentenpet. Iedere gouwgilde kreeg zijn eigen kleur. Vanden Eynde had een hekel aan boertigheid, idioot gedrag en zuipfestijnen: hij wou dat de Vlaamse studenten zich stijlvol gedroegen. Hij was ook lid van de Duitstalige Katholische Akademische Verbindung Lovania[18], die bekend stond om zijn stijl en tucht en zijn leden daarop selecteerde. Dit genootschap van Duitstalige studenten oefende tevens een enorme invloed uit op het beeld dat de Vlaamse studenten hadden van de Duitse studententradities. Ook introduceerde Lovania het Lebensbund-principe, dat oud-studenten verplicht om hun studentenvereniging materieel te blijven steunen. Vermeldenswaard is ook nog dat vanden Eynde, die over een aanzienlijke erfenis kon beschikken, zijn talloze initiatieven - muziek- en toneelopvoeringen, artiesten, drukwerk en Ons Leven - grotendeels uit eigen zak betaalde. Hij was dan ook enorm verarmd, toen hij Leuven verliet. Niet voor niets vermeldde het opschrift op zijn grafsteen: “Hij was de belangeloze en offervaardige bezieler en weldoener van kunst en volksverheffing in Vlaanderen”[19].
In dezelfde periode, vlak voor de Eerste Wereldoorlog, woedde ook de strijd voor de vernederlandsing van het onderwijs. Het uitblijven van concrete wetgevende resultaten versterkte de nationale reflex bij de studenten. Hierdoor werd binnen de studentenbeweging de politieke strijd meer benadrukt, waardoor het godsdienstige meer op de achtergrond raakte, terwijl ook de autonomie tegenover de kerkelijke overheid beklemtoond werd[20] . Reeds vóór de Eerste Wereldoorlog ontstond hierdoor binnen de Vlaamse studentenbeweging een radicale en anti-Belgische strekking[21]. Dit zette zich na de oorlog door vanwege de wet-Nolf, die de Gentse universiteit slechts half vernederlandste, en vanwege de als onrechtvaardig aangevoelde behandeling der activisten, waaronder veel voormalige studentenleiders zoals Lodewijk Dosfel en August Borms.
Het ware pionierswerk inzake studentikoze gebruiken en tradities van Jef vanden Eynde werd verder gezet door diens geestelijke erfgenaam Edmond De Goeyse, die in 1925 in Leuven Germaanse filologie kwam studeren en er in 1933 promoveerde tot doctor. Hij stichtte onder meer het Brussels Katholiek Studentencorps, waarvan hij ook vijf jaar praeses was (1925-1930). Door de Duitse studentikoze regels en gebruiken die De Goeyse introduceerde in zijn club zou deze tot na de Tweede Wereldoorlog voor het Vlaamse traditionele studentenleven model staan voor een stijlvolle studentikoziteit[22].
‘Mon’ De Goeyse streefde naar een volledige hervorming van de Leuvense studententradities naar Duits model. Hij stichtte hiertoe, naar Duits voorbeeld, het Seniorenkonvent (SK), bestaande uit de clubvoorzitters van iedere Leuvense studentenvereniging. Hiervoor schreef hij ook, opnieuw naar Duits model, een eigen Vlaamse clubcodex. Het doel van het SK was binnen het kader van het KVHV het clubleven te ordenen en meer stijl te geven door de studentikoze en traditionele aspecten van het studentenleven voor zijn rekening te nemen. Dit succesvolle initiatief grondvestte het studentenleven op traditie, stijl, tucht en levenslange kameraadschap. De Goeyse wou hiermee de onbeschaafdheid en het gebrek aan ‘voornaamheid’ van het Vlaamse studentenmilieu tegengaan[23]. Een ex-Lovaniensis, Rik Wyckmans, zou in 1934 te Gent met succes ook een SK oprichten en er de clubcodex invoeren. De Vlaamse studententradities, zoals ze door Mon De Goeyse werden vastgelegd in de clubcodex, werden door de meeste studentenclubs en faculteitskringen in andere studentensteden overgenomen. Hierdoor overkoepelde het KVHV dus zowel de regionale als de faculteitsclubs[24]. Veel later zou Edmond De Goeyse in Leuven nog het Archief en Museum van het Vlaams Studentenleven (AMVS) oprichten, waarvan hij tevens de eerste conservator was. Dit AMVS is gevestigd in de Centrale Universiteitsbibliotheek, Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven. De verzameling omvat talloze foto’s, affiches, clubvaandels, studentenlinten en -petten en andere attributen met betrekking tot het traditionele studentenleven.
Aldus werd de traditionele Vlaamse studentenbeweging in de geest van Albrecht Rodenbach en zijn Blauwvoeterij gevormd naar het model van de Duitse Burschenschaften, terwijl Jef vanden Eynde stijl bracht in de Vlaamse studentenbeweging door de introductie van Duitse studentengebruiken. Mon De Goeyse inspireerde zich eveneens op Duitse voorbeelden om hierop qua stijl en organisatie van het studentenleven verder te werken.
Hoe en waarom veranderde de betekenis van de Vlaamse studentenbeweging?
Mei ‘68 markeerde voor de Vlaamse studentenbeweging het einde van een periode van bijna 100 jaar waarin de Vlaamse ontvoogdingsstrijd centraal stond. Door de democratisering van het onderwijs stroomden sinds het midden van de jaren 1950 massa’s studenten uit de lagere bevolkingsklassen naar het hoger onderwijs, waardoor de studentenpopulatie een enorme aangroei kende. Deze hadden eerder een boodschap aan de sociale strijd dan aan het katholiek flamingantisme en wendden zich dan ook tot het marxisme. Zij beschouwden zichzelf als ‘intellectuele arbeiders’, in plaats van als de ‘leiders van morgen’. Een steeds grotere groep studenten plaatste zich buiten het georganiseerde studentenleven, waardoor het KVHV zijn traditionele achterban verloor. Hierdoor transformeerde de katholiek-flamingantische studentenbeweging in een marxistische studentenbeweging, die tot ver in de jaren 1970 zou overheersen. Het feit dat bijvoorbeeld de Marxistisch-Leninistische Beweging (MLB) uit het KVHV ontstond, spreekt boekdelen. De katholiek-flamingantische stroming sprak sindsdien nog slechts een kleine minderheid der studenten aan[25].
De studentenelite bleef verzamelen rond de Vlaamse leeuw tot op het einde van de jaren 1960. Nadien verloor het KVHV zijn invloed op de studentenbevolking. De clubs gingen hun eigen weg en de politieke vleugel van de oude studentenbeweging geraakte geïsoleerd en zelfs gemarginaliseerd. De Vlaamse studentenbeweging, zoals ze gegroeid was sinds Albrecht Rodenbach, bestaat vandaag niet meer. De neergang van het KVHV als representatieve Vlaamse studentenorganisatie is hier de hoofdoorzaak van. We zagen aldus een inkrimping van het politieke studentenpubliek dat de Vlaamse studententradities hanteert, maar ook een brede verspreiding van deze tradities in apolitieke kringen sinds de jaren 1980[26].
De sociaal-progressieve stroming binnen het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond meende dat men zich moest richten op de grondige veranderingen die plaatsvonden in de studentenwereld. Het KVHV begon dan ook vanaf 1962 afstand te nemen van de traditionele studentencultuur, dat het beschouwde als een remmende factor, en ging zelfs de pluralistische toer op. Hierdoor verhuisde een groot deel van de traditionele, conservatief-nationalistische vleugel naar de toenmalige Vlaams-Nationalistische Studentenunie (VNSU), die daardoor een opmerkelijke groei kende en spoedig het KVHV overtrof in ledenaantallen. Er gaapte dus een kloof tussen de marxistische, anti-klerikale top van het KVHV en de traditionalistische basis. Daarbovenop kwam nog dat de progressieve studentenleiders begonnen te vervreemden van de Vlaamse Beweging. In 1967 werd ook het Faculteitenkonvent (FK), tot dan een onderdeel van het KVHV, een zelfstandige organisatie, omdat de faculteitskringen zich niet langer konden verzoenen met de koers van het KVHV. Bovendien zat het KVHV in 1967 bijna volledig aan de grond. Vanwege het hevige verzet besefte het progressieve bestuur van het KVHV dat deze traditioneel-conservatieve studentenbond niet de juiste voedingsbodem was voor een studentenrevolte. Daarom verlieten de progressieven in 1967 het KVHV, om in 1970 de Marxistisch-Leninistische Beweging te stichten. De hegemonie van het KVHV over de studentenbeweging was op dat moment voorgoed gebroken en het grootste deel van het actieve kader had het KVHV verlaten. Op het einde van de jaren 1970 zorgde een steeds verder schrijdende depolitisering er voor dat politiek engagement in het studentenmilieu een marginaal gegeven werd [27].
Marxistische studentenverenigingen, zoals Alle Macht Aan De Arbeiders (AMADA) en MLB, betekenden felle concurrentie voor KVHV en VNSU, wat tot felle verdeeldheid leidde binnen de flamingantische studentenverenigingen. Zo kwam bijvoorbeeld in 1968 de Gentse VNSU-praeses Vic Van Branteghem in conflict met zijn eigen praesidium, wat hem tot opstappen noodzaakte. Dezelfde dag nog richtte hij het sinds een jaar verdwenen KVHV-Gent weer op, waarmee hij de Gentse VNSU zeer zware concurrentie aandeed en spoedig zelfs overvleugelde. De verdeeldheid in de conservatief-nationalistische rangen zette zich verder in de jaren 1970, mede dankzij de progressieve studentenverenigingen die van de KUL en de VUB maoïstische bolwerken maakten, terwijl trotskisten en anarchisten vooral in Gent sterk stonden. Als reactie daarop benadrukte het KVHV, dat verworden was tot een hoofdzakelijk culturele organisatie, opnieuw meer de eigen oude conservatief-nationalistische tradities. Hierin werd het aan het einde van de jaren 1970 nagevolgd door de pas opgerichte Nationalistische Studentenvereniging (NSV), dat zich ook als een traditionele, studentikoze vereniging manifesteerde met onder meer een eigen studentenpet en nauwe contacten met de Duitse Burschenschaften. Het terugvinden van de wortels van het oude KVHV uitte zich in 1974 in Gent in een protestactie van het KVHV - die op een ware veldslag tegen gewapende leden van MLB en AMADA uitliep - tegen een progressieve vertolking van het toneelstuk ‘Verschaeve’. Deze heropleving van de oude katholieke tradities beperkte zich tot een minderheid van de studentenpopulatie. De VNSU was ondertussen de marxistische toer opgegaan en daardoor verschrompeld tot een kleine progressieve kaderledenorganisatie[28].
Een andere oorzaak van de versplintering binnen de politieke vleugel van de Vlaamse studentenbeweging was de ideologische discussie over het doel van de Vlaamse Beweging. Politieke discussies slorpten bijvoorbeeld binnen het KVHV alle energie op en ook partijpolitieke invloed liet zich gelden. Zo verdrong de duidelijk met de Volksunie verbonden VNSU in Gent het KVHV van de flamingantische studentenmarkt vanaf het einde van de jaren 1950. De VNSU wedijverde ook in andere studentensteden met het KVHV. Alleen al het bestaan van de VNSU naast het oude, traditonele KVHV toont de versplintering in de politieke vleugel van de flamingantische studentenbeweging aan[29]. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de VNSU geen traditionele, maar wel een louter politieke studentenvereniging was.
Een opvallend verschil tussen traditionalisten en progressieven is het woordgebruik van vóór en ná 1968, waarvan de titels van de algemene studententijdschriften een weerspiegeling zijn. Zo was er vroeger Ons Leven (Leuven, bestaat nog steeds), Aula (Gent) en De Geus (Brussel), terwijl vandaag Veto (Leuven), Schamper (Gent) en De Moeial (Brussel) die rol vervullen. Ook de typische studententaal kwijnde door de algemene vervlakking weg na mei ‘68. Daardoor zijn heden vele begrippen uit de studententaal onbekend bij de Vlaamse studenten. Deze zijn uitgestorven en soms vervangen door bargoense woorden. Zo is ‘pandoer’ vervangen door ‘flic’, een woord uit de Franse dieventaal. Ook de triomfantelijke levensstijl van de traditionele Vlaamse student - “Het is al jarenlang bekend, dat alles zwicht voor een student” - ging ten onder in de algemene nivellering van de maatschappij. De huidige student heeft met andere woorden geen eigen gelaat meer[30].
Tegen het begin van de jaren 1980 was het maatschappelijk engagement verdwenen bij de studentenmassa, zodat de studentenbeweging als dusdanig ophield te bestaan. De erfgenamen van mei ‘68 behielden hun greep op de studentengemeenschap en de overkoepelende studentenorganisaties, waarbij vooral de MLB zich sterk wist te handhaven, hoewel deze organisatie qua ledenaantal uiterst marginaal was. Tegelijk bloeide de NSV, vooral in Antwerpen. Deze studentengroepering wist de meerderheid van de conservatief-nationalistische studenten aan te trekken, terwijl zich in het KVHV een katholiserende tendens aftekende. De Gentse VNSU ging in het begin van de jaren 1980 zelfs volledig op in de NSV[31]. De marxistische omwentelingen van de jaren 1960 zorgden dus niet alleen voor grondige maatschappelijke en universitaire veranderingen, maar tevens onderging de aloude traditionele Vlaamse studentenbeweging er ingrijpende wijzigingen door.
De huidige betekenis van de Vlaamse studentenbeweging.
Heden bestaat de oorspronkelijke brede politieke studentenbeweging niet meer. Meer en meer ging het gezelschapsleven de boventoon voeren. Sinds de val van het communisme in 1989 brak ook het postmodernisme door, waardoor alle bestaande levensbeschouwingen en ideologieën in vraag gesteld werden. Voor de brede studentenmassa was dit een reden te meer om zich te hullen in een zelfgenoegzaam individualisme[32]. De traditionele katholieke en dus politiek geëngageerde studentenbeweging verwaterde sterk door depolitisering, individualisering, secularisering, liberalisering en commercialisering en verwerd tot een bijna marginale minderheid in de studentenwereld. Zo is de Vlaams-Nationale Studentenunie verdwenen, terwijl het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond zijn aloude functie, namelijk het overkoepelen van de andere studentenclubs, verloren heeft.
Vandaag werkt het KVHV opnieuw in de lijn van de oorspronkelijke katholieke Vlaamse studentenbeweging en behoort het tot de meest actieve politieke studentenverenigingen (van welke strekking ook). Maar de vroeger erg brede Vlaamse politieke studentenbeweging is verschrompeld en slechts een schim van wat het ooit was[33]. De loskoppeling van het politieke aspect sinds de jaren 1960 leidde er toe dat de studentenclubs een tamelijk geïsoleerd bestaan gingen leiden zonder noemenswaardige hoogte- of laagtepunten. De clubs trekken zich sindsdien niets meer aan van de politieke discussies in het studentenmilieu, noch van de kritiek die ze van progressieve studenten krijgen. In Leuven kwamen er steeds minder nieuwe leden, het clubmilieu werd alsmaar kleiner en er groeide zelfs een kloof tussen de studenten en de oud-studenten, een regelrechte generatiekloof dus. Het huldeboek van Moeder Brugse omschrijft deze periode zelfs als ‘Mama’s Menopauze’[34]. Buiten Leuven nam het apolitieke clubleven echter juist een hoge vlucht door de depolitisering van de Vlaamse studententradities. De meeste van de vele nieuwe studentenclubs hebben nauwelijks nog weet van de politieke achtergrond die ooit zo innig met de studentengebruiken was verweven. In Gent bewijst de regelmatige uitgave en de vlotte verkoop van de studentencodex de levenskracht van het Gentse clubleven. Uit dé Gentse bloeiperiode, namelijk de jaren 1970 met de stichting van een groot aantal clubs, zijn tot op heden nog vele clubs actief[35].
Vbr. lic. hist. et rer. oec. Filip Martens
[1] Zie hiervoor Rodenbachs redevoering ‘Vlaamsche kamp’ te Gent in 1877 bij de oprichting van een algemene Vlaamse studentenbond in: LAMBERTY (Max), VAN ROOSBROECK (Rob), VANDEKERCKHOVE (Michiel) e.a., Twintig eeuwen Vlaanderen, deel 15: Oude en nieuwe visies, 15 delen, Hasselt, Uitgeverij Heideland-Orbis NV, 1976, pp. 73-81.
[2] LAMBERTY (Max), VAN ROOSBROECK (Rob), VANDEKERCKHOVE (Michiel) e.a., Twintig eeuwen Vlaanderen, deel 13: Vlaamse figuren I, 15 delen, Hasselt, Uitgeverij Heideland-Orbis NV, 1976, pp. 411-414.
[3] DE GOEYSE (Edmond), O vrij-studentenheerlijkheid. Historisch-studentikoze schetsen, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1987.
[4] gent.kvhv.org, www.kvhv.be en s.n., Studentencodex, Dendermonde, Studentencentrum Leuven vzw, 2001, pp. 163-166.
[5] WEETS (Wilfried), Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging, Vosselaar, Oranjejeugd vzw en Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, 1996.
[6] LAMBERTY (Max), VAN ROOSBROECK (Rob), VANDEKERCKHOVE (Michiel) e.a., Twintig eeuwen Vlaanderen, deel 13: Vlaamse figuren I, 15 delen, Hasselt, Uitgeverij Heideland-Orbis NV, 1976, pp. 413-414.
[7] De Zouaven waren vrijwilligerskorpsen van katholieke jongeren, die de door de Italiaanse eenmaking bedreigde Pauselijke Staten gingen verdedigen.
[8] WEETS (Wilfried), Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging, Vosselaar, Oranjejeugd vzw en Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, 1996, pp. 6.
[9] DE GOEYSE (Edmond), O vrij-studentenheerlijkheid. Historisch-studentikoze schetsen, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1987.
[10] WEETS (Wilfried), Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging, Vosselaar, Oranjejeugd vzw en Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, 1996, pp. 7 en Rodenbachs redevoering ‘Vlaamchse kamp’ te Gent in 1877 bij de oprichting van de algemene Vlaamse studentenbond in: LAMBERTY (Max), VAN ROOSBROECK (Rob), VANDEKERCKHOVE (Michiel) e.a., Twintig eeuwen Vlaanderen, deel 15: Oude en nieuwe visies, 15 delen, Hasselt, Uitgeverij Heideland-Orbis NV, 1976, pp. 73-81.
[11] DE BRUYNE (M.) en GEVERS (Lieve), Kroniek van Albrecht Rodenbach (1856-1880), Brugge, 1980, pp. 141-143 en 151.
[12] GEVERS (Lieve), De ‘Kulturkampf’ van Albrecht Rodenbach, in: Onze Alma Mater, jg. 48, nr. 1, februari 1994, pp. 81 en 83.
[13] WEETS (Wilfried), Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging, Vosselaar, Oranjejeugd vzw en Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, 1996, pp. 8 en 10.
[14] WEETS (Wilfried), Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging, Vosselaar, Oranjejeugd vzw en Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, 1996, pp. 7-8.
[15] MARTENS (Filip), Julius Mac Leod en de radicalisering van de Vlaamse studentenbeweging (1904-1914), Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, UG, 2006.
[16] VANACKER (Daniël), Het aktvistisch avontuur, Gent, Stichting Mens en Kultuur, 1991.
[17] WEETS (Wilfried), Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging, Vosselaar, Oranjejeugd vzw en Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, 1996, pp. 10 en 12.
[18] www.lovania.org
[19] DE GOEYSE (Edmond), O vrij-studentenheerlijkheid. Historisch-studentikoze schetsen, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1987, p. 69.
[20] WEETS (Wilfried), Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging, Vosselaar, Oranjejeugd vzw en Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, 1996, pp. 13.
[21] MARTENS (Filip), Julius Mac Leod en de radicalisering van de Vlaamse studentenbeweging (1904-1914), Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, UG, 2006.
[22] VAN NIEUWENHUYSEN (P.) en DE GOEYSE (Edmond), Katholiek Studentenkorps te Brussel 1925-1975, Brussel, 1975.
[23] DE BAEKE (S.) Van schachtendoop tot zwanenzang. 100 jaar Vlaams studentenleven te Leuven. Moeder Westland, Langemark, 1991, pp. 125-126.
[24] s.n., Studentencodex, Dendermonde, Studentencentrum Leuven vzw, 2001, pp. 7 en 57-80.
[25] WEETS (Wilfried), Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging, Vosselaar, Oranjejeugd vzw en Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, 1996, pp. 30.
[26] VOS (Louis), Van Vlaamse leeuw tot rode vaan … en verder: de naoorlogse Leuvense studentenbeweging, in: Onze Alma Mater, jg. 47, nr. 3, augustus 1993, pp. 241.
[27] WEETS (Wilfried), Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging, Vosselaar, Oranjejeugd vzw en Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, 1996, pp. 30, 32, 34-36 en 38.
[28] s.n., Studentencodex, Dendermonde, Studentencentrum Leuven vzw, 2001, pp. 86 en WEETS (Wilfried), Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging, Vosselaar, Oranjejeugd vzw en Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, 1996, pp. 41-42.
[29] DE SCHRIJVER (Reginald) e.a., Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 3 delen, Tielt, Uitgeverij Lannoo, 1998.
[30] DE GOEYSE (Edmond), O vrij-studentenheerlijkheid. Historisch-studentikoze schetsen, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1987.
[31] WEETS (Wilfried), Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging, Vosselaar, Oranjejeugd vzw en Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, 1996, pp. 67-68.
[32] www.studiant.be en WEETS (Wilfried), Historische schets van de Vlaamse studentenbeweging, Vosselaar, Oranjejeugd vzw en Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, 1996, pp. 67 en 71.
[33] VOS (Louis), Van Vlaamse leeuw tot rode vaan … en verder: de naoorlogse Leuvense studentenbeweging, in: Onze Alma Mater, jg. 47, nr. 3, augustus 1993, pp. 241.
[34] DE MEY (J.) en VAN HOONACKER (M.), Moeder Brugse 1885-1985, Oostkamp, 1985, pp. 225 en 227.
[35] s.n., Clubcodex-Liederboek S.K. Ghendt, Gent, 1986, pp. 35-67.
00:15 Publié dans Mouvements de jeunesse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mouvement étudiant, étudiants, universités, flandre, belgique, belgicana, contestation, traditions |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 06 mars 2009
Le féodalisme, une légende?
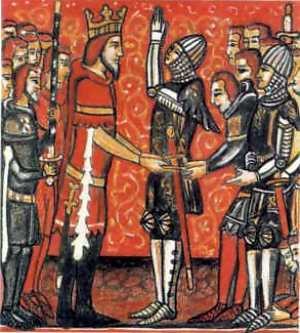
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1994
Le féodalisme, une légende?
L'historienne britannique Susan Reynolds avance une thèse innovatrice: le féodalisme médiéval n'aurait pas existé tel qu'on l'imagine communément; il serait une invention ultérieure de juristes modernes, hostiles au Moyen Age. La cérémonie symbolique, liant le vassal à son suzerain, n'est pas le fondement général, omniprésent en Europe, de l'Etat féodal, dominant notre continent de Charlemagne à la chute de Constantinople en 1453. Susan Reynolds affirme que les preuves sont trop peu nombreuses pour pouvoir affirmer sans nuances que l'ensemble du Moyen Age européen ait été marqué par ce type de contrat, fondé sur la fidélité et la dépendance réciproque. Cette affirmation, impertinente au regard de l'historiographie conventionnelle, notre historienne d'Oxford la tire d'une exploration systématique des documents, des actes, etc., conservés dans tous les musées et bibliothèques d'Europe.
Première révision, due à cette analyse systématique des écrits médiévaux: après l'Empire romain, l'Europe n'a pas sombré dans un “vide juridique” et n'a pas vraiment été livrée à la “loi de la jungle”. La réglementation féodale était conçue pour calmer les puissants, les obliger à respecter la paix et l'harmonie. Au départ, le lien de vassalité, liant par exemple un duc à son roi ou à son empereur, n'était pas conçu pour durer éternellement. Le principe de l'hérédité d'un fief n'avait pas été retenu. Charles le Chauve a dû finalement le concéder (mais partiellement) à sa noblesse franque pour calmer les esprits et pour s'assurer ses arrières quand il guerroyait en Italie entre 870 et 880.
La féodalité conçue comme système rigide est une invention des juristes du début de l'ère moderne, qui s'opposaient aux concepts vagues, souples et imprécis du droit coutumier. Il fallait donc qu'ils le schématisent et lui donnent une image négative. Cette construction artificielle de juristes en mal de pouvoir, poursuivant un objectif finalement totalitaire, visant à annihiler les autonomies multiples tolérées par le droit coutumier, a oblitéré la vision des historiens. Ceux-ci sont demeurés prisonniers d'une vision du Moyen Age figée, ne correspondant nullement à sa grande diversité et à son étonnante variété. L'omniprésence de cette légende, fabriquée par les juristes, a fait que les historiens n'ont plus pris la peine de consulter les archives. Susan Reynolds s'attend bien entendu à des critiques serrées de ses thèses, surtout de la part de l'école française de Marc Bloch, fidèle à la modernité des juristes, des jacobins et des idéologues marxistes. Mais cette modernité, plus idéologique que fiable, tiendra-t-elle le coup devant le sérieux d'Oxford, déployé par Susan Reynolds?
Susan REYNOLDS, Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted, Oxford University Press, 544 p., £20.
00:05 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : moyen-âge, féodalisme, histoire, traditions, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 28 janvier 2009
Hypathie, vierge martyre des païens
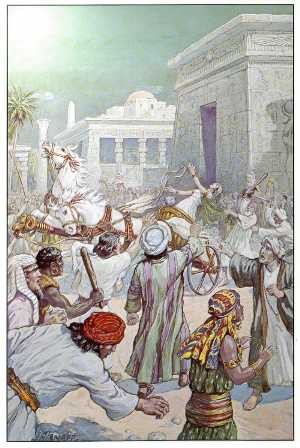
Archives de SYNERGIES EUROPÉENNES - COMBAT PAÏEN - DÉCEMBRE 1990
B. Favrit-Verrieux:
Hypathie, vierge martyre des Païens
"Dors, ô blanche victime en notre âme profonde,
Dans ton linceul de vierge et ceinte de lotos;
Dors! l'impure laideur est la reine du monde
Et nous avons perdu le chemin de Paros (…)
Demain, dans mille années,
Dans vingt siècles, —qu'importe au cours des destinées—
L'homme étouffé par vous se dressera (…)
Votre œuvre ira dormir dans l'ombre irrévocable".
Leconte de Lisle (Hypathie et Cyrille)
Alexandrie, 415. Cinq ans après le sac de Rome, alors que l'Empire s'écroule, l'Egypte vit à l'heure des derniers feux du paganisme antique. L'Occident est acquis à la cause du "Galiléen", l'Orient résiste encore, mais il n'est qu'en sursis. La ville égyptienne abrite une population multiconfessionnelle; la cohabitation s'avère de plus en plus difficile. Face aux Juifs et aux païens "Hellènes": les partisans de Jésus, manœuvrés par l'évêque Cyrille, et qui comptent bien se rendre maîtres de la place.
Dans cette atmosphère tendue se dresse Hypatie, la vierge des païens et, si l'on en croit les relations de Socrate (1) et Damaskios, l'ultime rempart du paganisme. Son père, prêtre des dieux et scientifique de renom, lui a enseigné la mathématique, l'astrologie et la philosophie. Elle a grandi dans le culte des dieux; elle sait que tout flanche et agonise autour d'elle; pourtant, elle se refuse à suivre la théorie des conversions. Un combat sans espoir, perdu d'avance… En cela réside toute sa signification.
Hypathie enseigne la philosophie, elle a le verbe haut mais la grâce l'habite; tous les témoignages convergent lorsqu'il s'agit d'évoquer sa grande beauté. On a coutume de la représenter au milieu d'un cénacle, le cercle de ses fidèles qui, avec elle, refusent de voir les dieux s'exiler pour céder la place aux religions de l'intolérance.
Les Juifs et les chrétiens s'affrontent à coups d'émeutes et de pogroms sous les regards inquiets d'Hypatie et des siens; à quand leur tour?… Il y aussi la lutte d'influence que se livrent Oreste, préfet de la ville, et l'évêque Cyrille. Pour une cause mal définie, le préfet d'Alexandrie aurait fait torturer à mort un chrétien, un provocateur dont les Juifs ont exigé la tête. L'affaire dégénère bientôt et c'est le massacre entre les deux communautés. Cyrille, qui a l'avantage de la supériorité numérique, fait détruire les synagogues et expulser les Juifs. Puis, emporté par son élan, l'évêque harangue ses troupes qui jettent l'anathème sur le représentant de Rome. Oreste cherche alors à se concilier les faveurs d'Hypatie dont l'influence est toujours notoire pour tenter de réduire Cyrille et ses moines fauteurs de troubles. On rapporte aussi que frappé par la beauté de la jeune femme, le préfet d'Alexandrie, bien que baptisé, aurait longuement hésité à s'engager sur le voie du paganisme. Il n'en fit rien.
Lorsque la vierge païenne est prise à partie en pleine ville par la foule chrétienne fanatisée qui l'arrache de sa voiture et la traîne au Caesarium, il ne réagira pas. Sur les marches du temple impérial, Hypatie est "déshabillée, tuée à coups de tessons, mise en pièces… Ses restes sont ensuite promenés dans les rues et brûlés…" (3). Désormais, Cyrille et Oreste peuvent envisager la réconciliation…
Dans son avant-propos à un ouvrage de Gabriel Trarieux (4), George Clemenceau eut cette phrase: "Hypatie contre Jésus. La Grèce toujours contre sa mère l'Asie, la beauté contre la bonté, fût-il jamais plus passionnante tragédie?" Passionnantes ou pas, il est des tragédies dont les païens que nous sommes ne peuvent s'accommoder et veulent éviter. Contre l'éradication de la beauté et le règne du lit de Procustre, nous devons montrer notre détermination face à l'intolérance qui règne chez nous et le retour des tabous et des amalgames minables. Nos spécificités, notre religiosité européennes nous ont toujours enseigné de ne pas nous agenouiller, nous encaloter, nous voiler, nous asservir, de privilégier l'amour des libertés pour que s'élève l'être face à ses sensibilités identitaires. Hypatie, la chaste et belle païenne, n'a pas voulu se taire et se prosterner. Elle a montré la voie. Souvenons-nous du culte d'Athénée Poilias qu'elle tenta d'honorer jusqu'au bout et de sa croisade contre le Crucifié.
B. Favrit-Verrieux.
Notes:
(1) Histoire de l'Eglise.
(2) Vie d'Isidore.
(3) Chronique des derniers païens - Pierre Chuvin (Les belles Lettres: Fayard, Paris, 1990).
(4) Hypatie - Cahiers de la quinzaine (Paris, avril 1904).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, christianisme, judaïsme, antiquité, antiquité grecque, egypte ancienne, religion |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 08 janvier 2009
L'oeuvre de Herman Wirth

L'oeuvre de Herman WIRTH (1885-1981)
par Robert Steuckers
Né le 6 mai 1885 à Utrecht aux Pays-Bas, Herman Wirth étudie la philologie néerlandaise, la philologie germanique, l'ethnologie, l'histoire et la musicologie aux universités d'Utrecht, de Leipzig et de Bâle. Son premier poste universitaire est une chaire de philologie néerlandaise à Berlin qu'il occupe de 1909 à 1919. Il enseigne à Bruxelles en 1917/18 et y appuie l'activisme flamand germanophile. Séduit par le mouvement de jeunesse contestataire et anarchisant d'avant 1914, le célèbre Wandervogel, il tente de lancer l'idée aux Pays-Bas à partir de 1920, sous l'appelation de Dietse Trekvogel (Oiseaux migrateurs thiois). En 1921, il entame ses études sur les symboles et l'art populaire en traitant des uleborden, les poutres à décoration animalière des pignons des vieilles fermes frisonnes. Convaincu de la profonde signification symbolique des motifs décoratifs traditionnels ornant les pignons, façades, objets usuels, pains et pâtisseries, Wirth mène une enquête serrée, interrogeant les vieux paysans encore dépositaires des traditions orales. Il tire la conclusion que les symboles géométriques simples remontent à la préhistoire et constituent le premier langage graphique de l'homme, objet d'une science qu'il appelle à approfondir: la paléo-épigraphie. Le symbole est une trace plus sûre que le mythe car il demeure constant à travers les siècles et les millénaires, tandis que le mythe subit au fil des temps quantités de distorsions. En posant cette affirmation, Wirth énonce une thèse sur la naissance des alphabets. Les signes alphabétiques dérivent, selon Wirth, de symboles désignant les mouvements des astres. Vu leur configuration, ils seraient apparus en Europe du Nord, à une époque où le pôle se situait au Sud du Groenland, soit pendant l'ère glacière où le niveau de la mer était inférieur de 200 m, ce qui laisse supposer que l'étendue océanique actuelle, recouvrant l'espace sis entre la Galice et l'Irlande, aurait été une zone de toundras, idéale pour l'élevage du renne. La montée des eaux, due au réchauffement du climat et au basculement du pôle vers sa position actuelle, aurait provoqué un reflux des chasseurs-éleveurs de rennes vers le sud de la Gaule et les Asturies d'abord, vers le reste de l'Europe, en particulier la Scandinavie à peine libérée des glaces, ensuite. Une autre branche aurait rejoint les plaines d'Amérique du Nord, pour y rencontrer une population asiatique et créer, par mixage avec elle, une race nouvelle. De cette hypothèse sur l'origine des populations europides et amérindiennes, Wirth déduit la théorie d'un diffusionnisme racial/racisant, accompagné d'une thèse audacieuse sur le matriarchat originel, prenant le relais de celle de Bachofen.
Wirth croyait qu'un manuscrit frison du Moyen-Age, l'Oera-Linda bok, recopié à chaque génération depuis environ le Xième siècle jusqu'au XVIIIième, contenait in nuce le récit de l'inondation des toundras atlantiques et de la zone du Dogger Bank. Cette affirmation de Wirth n'a guère été prise au sérieux et l'a mis au ban de la communauté scientifique. Toutefois, le débat sur l'Oera-Linda bok n'est pas encore clos aux Pays-Bas aujourd'hui.
Très en vogue parmi les ethnologues, les folkloristes et les «symbolologues» en Allemagne, en Flandre, aux Pays-Bas et en Scandinavie avant-guerre, Wirth a été oublié, en même temps que les théoriciens allemands et néerlandais de la race, compromis avec le IIIième Reich. Or Wirth ne peut être classé dans la même catégorie qu'eux: d'abord parce qu'il estimait que la recherche des racines de la germanité, objectif positif, était primordiale, et que l'antisémitisme, attitude négative, était «une perte de temps»; ensuite, en butte à l'hostilité de Rosenberg, il est interdit de publication. Il reçoit temporairement l'appui de Himmler mais rompt avec lui en 1938, jugeant que les prétoriens du IIIième Reich, les SS, sont une incarnation moderne des Männerbünde (des associations masculines) qui ont éradiqué, par le truchement du wotanisme puis du christianisme, les cultes des mères, propres à la culture matricielle atlanto-arctique et à son matriarchat apaisant, remontant à la fin du pliocène. Arrêté par les Américains en 1945, il est rapidement relaché, les enquêteurs ayant conclu qu'il avait été un «naïf abusé». Infatigable, il poursuit après guerre ses travaux, notamment dans le site mégalithique des Externsteine dans le centre de l'Allemagne et organise pendant deux ans, de 1974 à 1976, une exposition sur les communautés préhistoriques d'Europe. Il meurt à Kusel dans le Palatinat le 16 février 1981. Sans corroborer toutes les thèses de Wirth, les recherches des Britanniques Renfrew et Hawkins et du Français Jean Deruelle ont permis de revaloriser les civilisations mégalithiques ouest-européennes et de démontrer, notamment grâce au carbone 14, leur antériorité par rapport aux civilisations égyptienne, crétoise et mésopotamienne.
L'ascension de l'humanité (Der Aufgang der Menschheit), 1928
Ouvrage majeur de Wirth, Der Aufgang der Menschheit se déploie à partir d'une volonté de reconnaître le divin dans le monde et de dépasser l'autorité de type augustinien, reposant sur la révélation d'un Dieu extérieur aux hommes. Wirth entend poursuivre le travail amorcé par la Réforme, pour qui l'homme a le droit de connaître les vérités éternelles car Dieu l'a voulu ainsi. Wirth procède à une typologie racisée/localisée des religiosités: celles qui acceptent la révélation sont méridionales et orientales; celles qui favorisent le déploiement à l'infini de la connaissance sont «nordiques». La tâche à parfaire, selon Wirth, c'est de dépasser l'irreligion contemporaine, produit de la mécanisation et de l'économisme, en se plongeant dans l'exploration de notre passé. Seule une connaissance du passé le plus lointain permet de susciter une vie intérieure fondée, de renouer avec une religiosité spécifique, sans abandonner la démarche scientifique de recherche et sans sombrer dans les religiosités superficielles de substitution (pour Wirth: le néo-catholicisme, la théosophie ou l'anthroposophie de Steiner). Les travaux archéologiques ont permis aux Européens de replonger dans leur passé et de reculer très loin dans le temps les débuts hypothétiques de l'histoire. Parmi les découvertes de l'archéologie: les signes symboliques abstraits des sites «préhistoriques» de Gourdan, La Madeleine, Rochebertier et Traz-os-Montes (Portugal), dans le Sud-Ouest européen atlantique. Pour la science universitaire officielle, l'alphabet phénicien était considéré comme le premier système d'écriture alphabétique d'où découlaient tous les autres. Les signes des sites atlantiques ibériques et aquitains n'étaient, dans l'optique des archéologues classiques, que des «griffonnages ludiques». L'œuvre de Wirth s'insurge contre cette position qui refuse de reconnaître le caractère d'abord symbolique du signe qui ne deviendra phonétique que bien ultérieurement. L'origine de l'écriture remonte donc au Magdalénien: l'alphabet servait alors de calendrier et indiquait, à l'aide de symboles graphiques abstraits, la position des astres. Vu la présence de cette écriture linéaire, indice de civilisation, la distinction entre «histoire» et «préhistoire» n'a plus aucun sens: notre chronologie doit être reculée de 10.000 années au moins, conclut Wirth. L'écriture linéaire des populations du Magdalénien atlantique d'Ibérie, d'Aquitaine et de l'Atlas constituerait de ce fait l'écriture primordiale et les systèmes égyptiens et sumériens en seraient des dégénérescences imagées, moins abstraites. Théorie qui inverse toutes les interprétations conventionnelles de l'histoire et de la «pré-histoire» (terme que conteste Wirth). Der Aufgang der Menschheit commence par une «histoire de l'origine des races humaines» (Zur Urgeschichte der Rassen). Celle-ci débute à la fin de l'ère tertiaire, quand le rameau humain se sépare des autres rameaux des primates et qu'apparaissent les différents groupes sanguins (pour Wirth, le groupe I, de la race originelle —Urrasse— arctique-nordique, précédant la race nordique proprement dite, et le groupe III de la race originelle sud-asiatique). Ce processus de différenciation raciale s'opère pendant l'éocène, l'oligocène, le miocène et le pliocène. A la fin de ces ères tertiaires, s'opère un basculement du pôle arctique qui inaugure une ère glaciaire en Amérique du Nord (glaciation de Kansan). Au début du quaternaire, cette glaciation se poursuit (en Amérique: glaciations de Günz, de l'Illinois et de l'Iowa; en Europe, glaciation de Mindel). Ces glaciations sont contemporaines des premiers balbutiements du paléolithique (culture des éolithes) et, pour Wirth, des premières migrations de la race originelle arctique-nordique vers l'Amérique du Nord, l'Atlantique Nord et l'Asie septentrionale, ce qui donne en Europe les cultures «pré-historiques» du Strépyen et du Pré-Chelléen. Le réchauffement du climat, à l'ère chelléenne, permet aux éléphants, rhinocéros et hippopotames de vivre en Europe. L'Acheuléen inaugure un rafraîchissement du climat, qui fait disparaître cette faune; ensuite, à l'ère moustérienne, s'enclenche une nouvelle glaciation (dite de Riß ou de Würm; en Amérique, première glaciation du Wisconsin). Sur le plan racial, l'Europe est peuplée par la race de Néanderthal et les hommes du Moustier, de Spy, de la Chapelle-aux-Saints, de La Ferrasie, de La Quina et de Krapina. Lors d'un léger réchauffement du climat, apparaît la race d'Aurignac, influencée par des éléments de la race arctique-nordique-atlantique, porteuse des premiers signes graphiques symboliques. C'est l'époque des cultures préhistoriques de l'Europe du Sud-Ouest, de la zone franco-cantabrique (squelette de Cro-Magnon, type humain mélangé, où se croise le sang arctique nordique et celui des populations non nordiques de l'Europe), à l'ère dite du Magdalénien (I & II). Epoque-charnière dans l'optique de Wirth, puisqu'apparaissent, sur les parois des cavernes, notamment celles de La Madeleine, de Gourdan et du Font de Gaume en France, d'Altamira en Espagne, les dessins rupestres et les premières signes symboliques. Vers 12.000 avant notre ère, le climat se réchauffe et le processus de mixage entre populations arctiques-atlantiques-nordiques et Pré-Finnois de l'aire baltique (culture de Maglemose au Danemark) ou éléments alpinoïdes continentaux se poursuit, formant les différentes sous-races européennes. La Mer du Nord n'existe pas encore et l'espace du Dogger Bank (pour Wirth, le Polsete-Land) est occupé par le peuple Tuatha, de souche arctique-nordique, qui conquiert, à l'Est, le Nord-Ouest de l'Europe et, à l'Ouest, l'Irlande, qu'il arrache aux tribus «sud-atlantiques», les Fomoriens. La Mer du Nord disparaît sous les flots et, selon la thèse très contestée de Wirth, les populations arctiques-nordiques émigrent par vagues successives pendant plusieurs millénaires dans toute l'Europe, le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient, transmettant et amplifiant leur culture originelle, celle des mégalithes. En Europe orientale, elles fondent les cultures dites de Tripolje, Vinça et Tordos, détruisent les palais crétois vers 1400 avant notre ère, importent l'écriture linéaire dans l'espace sumérien et élamite, atteignent les frontières occidentales de la Chine, s'installent en Palestine (les Amourou du Pays de Canaan vers -3000 puis les Polasata et les Thakara vers -1300/-1200), donnent naissance à la culture phénicienne qui rationalise et fonctionnalise leurs signes symboliques en un alphabet utilitaire, introduisent les dolmens en Afrique du Nord et la première écriture linéaire pré-dynastique en Egypte (-3300), etc.
Pour prouver l'existence d'une patrie originelle arctique, Wirth a recours aux théories de la dérive des continents de W. Köppen et A. Wegener (Die Entstehung der Kontinente und Ozeane, 1922) et aux résultats de l'exploration des fonds maritimes arctiques et des restes de flore qu'O. Heer y a découverts (Flora fossilis artica, Zürich, 1868-1883). A la fin du tertiaire et aux débuts du quaternaire, les continents européen et américain étaient encore soudés l'un à l'autre. La dérive de l'Amérique vers l'ouest et vers le sud aurait commencé lors de la grande glaciation du pléistocène. Le Groenland, les Iles Spitzbergen, l'Islande et la Terre de Grinell, avec le plateau continental qui les entoure, seraient donc la terre originelle de la race arctique-nordique, selon Wirth. Le plateau continental, aujourd'hui submergé, s'étendant de l'Ecosse et l'Irlande aux côtes galiciennes et asturiennes serait, toujours selon Wirth, la seconde patrie d'origine de ces populations. Comme preuve supplémentaire de l'origine «circum-polaire» des populations arctiques-nordiques ultérieurement émigrées jusqu'aux confins de la Chine et aux Indes, Wirth cite l'Avesta, texte sacré de l'Iran ancien, qui parle de dix mois d'hiver et de deux mois d'été, d'un hiver si rigoureux qu'il ne permettait plus aux hommes et au bétail de survivre, d'inondations post-hivernales, etc. La tradition indienne, explorée par Bal Gangâdhar Tilak (The Arctic Home in the Vedas, 1903), parle, elle, d'une année qui compte un seul jour et une seule nuit, ce qui est le cas au niveau du pôle. Aucun squelette de type arctique-nordique n'a été retrouvé, ni en Ecosse ou en Irlande, zones arctiques non inondées, ni le long des routes des premières migrations (Dordogne/Aquitaine, Espagne, Atlas, etc. jusqu'en Indonésie), parce que les morts étaient d'abord enfouis six mois dans le giron de la Terre-mère pour être ensuite exhumés et exposés sur une dalle plate, un pré-dolmen, pour être offerts à la lumière, pour renaître et retourner à la lumière, comme l'atteste le Vendidad iranien, la tradition des Parses et les coutumes funéraires des Indiens d'Amérique du Nord.
L'organisation sociale des premiers groupes de migrants arctiques-nordiques est purement matriarcale: les femmes y détiennent les rôles dominants et sont dépositaires de la sagesse.
En posant cette série d'affirmations, difficiles à étayer par l'archéologie, Wirth lance un défi aux théories des indo-européanisants qui affirment l'origine européenne/continentale des «Indo-Européens» nordiques (appelation que Wirth conteste parce qu'il juge qu'elle jette la confusion). La race nordique et, partant, les «Indo-Européens» ne trouvent pas, pour Wirth, leur origine sur le continent européen ou asiatique. Il n'y aurait jamais eu, selon lui, d'Urvolk indo-européen en Europe car les nordiques apparaissent toujours mélangés sur cette terre; les populations originelles de l'Europe sont finno-asiatiques. Les Nordiques ont pénétré en Europe par l'Ouest, en longeant les voies fluviales, en quittant leurs terres progressivement inondées par la fonte des glaces arctiques. Cette migration a rencontré la vague des Cro-Magnons sud-atlantiques (légèrement métissés d'arcto-nordiques depuis l'époque des Aurignaciens) progressant vers l'Est. La culture centre-européenne du néolithique est donc le produit d'un vaste métissage de Sud-Atlantiques, de Nordiques et de Finno-asiatiques, que prouvent les études sérologiques et la présence des symboles. Les Celtes procèdent de ce mélange et ont constitué une civilisation qui a progressé en inversant les routes migratoires et en revenant en Irlande et dans la zone franco-cantabrique, emmenant dans leur sillage des éléments raciaux finno-asiatiques. En longeant le Rhin, ils ont traversé la Mer du Nord et soumis en Irlande le peuple nordique des Tuatha, venu de la zone inondée du Dogger Bank (Polsete-Land) et évoqué dans les traditions mythologiques celto-irlandaises. L'irruption des Celtes met fin à la culture matriarcale et monothéiste des Tuatha de l'ère mégalithique pour la remplacer par le patriarcat polythéiste d'origine asiatique, organisé par une caste de chamans, les druides. Wirth se réfère à Ammien Marcellin (1. XV, c.9, §4) pour étayer sa thèse: celui-ci parle des trois races de l'Irlande: l'autochtone, celle venue des «îles lointaines» et celle venue du Rhin, soit la sud-atlantique fomorienne, les Tuatha arcto-nordiques et les Celtes.
Le symbolisme graphique abstrait, que nous ont laissé ces peuples arcto-nordiques, temoigne d'une religiosité cosmique, d'un regard jeté sur le divin cosmique, d'une religiosité basée sur l'expérience du «mystère sacré» de la lumière boréale, de la renaissance solaire au solstice d'hiver. Dans cette religiosité, les hommes sont imbriqués entièrement dans la grande loi qui préside aux mutations cosmiques, marquée par l'éternel retour. La mort est alors un re-devenir (ein Wieder-Werden). Le divin est père, Weltgeist, depuis toujours présent et duquel procèdent toutes choses. Il envoie son fils, porteur de la «lumière des terres», pour se révéler aux hommes. Les hiéroglyphes qui expriment la présence de ce dieu impersonnel, qui se révèle par le soleil, se réfèrent au cycle annuel, aux rotations de l'univers, aux mutations incessantes qui l'animent, au cosmos, au ciel et à la terre. L'étymologie de tu-ath (vieil-irl.), ou de ses équivalents lituanien (ta-uta), osque (to-uto), vieux-saxon (thi-od), dérive des racines *ti, *to, *tu (dieu) et *ot, *ut, *at (vie, souffle, âme).
Ce peuple, connaisseur du «souffle divin», soit du mouvement des astres, a élaboré un système de signes correspondant à la position des planètes et des étoiles. Les modifications de ces systèmes de signes astronomiques étaient entraînées par les mouvements des corps célestes. Toute la civilisation mégalithique, explique Wirth, avant Renfrew, Hawkins et Deruelle, procède d'une religiosité astronomique. Elle est née en Europe occidentale et septentrionale et a essaimé dans le monde entier: en Amérique du Nord, au Maghreb (les mégalithes de l'Atlas), en Egypte, en Mésopotamie et, vraisemblablement, jusqu'en Indonésie et peut-être en Nouvelle-Zélande (les Maoris).
(Robert Steuckers).
- Bibliographie: Pour une bibliographie très complète, se référer au travail d'Eberhard Baumann, Verzeichnis der Schriften von Herman Felix WIRTH Roeper Bosch von 1911 bis 1980 sowie die Schriften für, gegen, zu und über die Person und das Werk von Herman Wirth, Gesellschaft für Europäische Urgemeinschaftskunde e.V., Kolbenmoor, 1988. Notre liste ci-dessous ne reprend que les ouvrages principaux: Der Untergang des niederländischen Volksliedes, La Haye, 1911; Um die wissenschaftliche Erkenntnis und den nordischen Gedanken, Berlin, 1929 (?); Der Aufgang der Menschheit, Iéna, 1928 (2ième éd., 1934); Die Heilige Urschrift der Menschheit, Leipzig, 1931-36; Was heißt deutsch? Ein urgeistgeschichtlicher Rückblick zur Selbstbestimmung und Selbstbesinnung, Iéna, 1931 (2ième éd., 1934); Führer durch die Erste urreligionsgeschichtliche Ausstellung "Der Heilbringer". Von Thule bis Galiläa und von Galiläa bis Thule, Berlin/Leipzig, 1933; Die Ura-Linda-Chronik, Leipzig, 1933; Die Ura-Linda-Chronik. Textausgabe (texte de la Chronique d'Oera-Linda traduit par H.W.), Leipzig, 1933; Um den Ursinn des Menschseins, Vienne, 1960; Der neue Externsteine-Führer, Marbourg, 1969; Allmutter. Die Entdeckung der "altitalischen" Inschriften in der Pfalz und ihre Deutung, Marbourg, 1974; Führer durch das Ur-Europa-Museum mit Einführung in die Ursymbolik und Urreligion, Marbourg, 1975; Europäische Urreligion und die Externsteine, Vienne, 1980.
- Sur Wirth: consulter la bibliographie complète de Eberhard Baumann (op. cit.); cf. également: Eberhard Baumann, Der Aufgang und Untergang der frühen Hochkulturen in Nord- und Mitteleuropa als Ausdruck umfassender oder geringer Selbstverwirklung (oder Bewußtseinsentfaltung) dargestellt am Beispiel des Erforschers der Symbolgeschichte Professor Dr. Herman Felix Wirth, Herborn-Schönbach, 1990 (disponible chez l'auteur: Dr. E. Baumann, Linzer Str. 12, D-8390 Passau). Cf. également: Walter Drees, Herman Wirth bewies: die arktisch-atlantische Kulturgrundlage schuf die Frau, Vlotho-Valdorf, chez l'auteur (Kleeweg 6, D-4973 Vlotho-Valdorf); Dr. A. Lambardt, Ursymbole der Megalithkultur. Zeugnisse der Geistesurgeschichte, Heitz u. Höffkes, Essen, s.d.
00:05 Publié dans archéologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, traditionalisme, révolution conservatrice, allemagne, pays-bas, préhistoire, proto-histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 24 novembre 2008
Jean Markale le celtisant est mort
Jean Markale le celtisant est mort
Auteur d’une centaine d’ouvrages, notamment sur les Celtes, Jean Markale est mort hier matin, à l’hôpital d’Auray. Il avait quatre-vingts ans.
De son vrai nom Jacques Bertrand, Jean Markale avait, avant de se lancer dans l’écriture, exercé, pendant vingt-cinq ans, le métier de professeur de lettres classiques dans un collège parisien. Mais, en 1979, fort de son succès avec « La femme celte » (Payot), il avait arrêté l’enseignement et était venu s’installer à Camors, près d’Auray, le pays de ses ancêtres. C’est là qu’il écrira, à une cadence pour le moins soutenue, tous ses livres. Ses grandes spécialités : les Celtes, le mythe du Graal, l’histoire de la Bretagne, l’ésotérisme et les énigmes historiques. Autant de thèmes qu’il a développés à satiété et exploités sous différentes formes, en particulier à travers des « cycles » qui lui permettaient de laisser libre cours à sa verve épique et à son imagination.
Son manque de rigueur scientifique était, d’ailleurs, le reproche que lui faisaient ses nombreux détracteurs. Mais Markale s’en moquait : « Je préfère être considéré comme poète plutôt que comme chercheur ».
11:56 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : celtisme, celtes, bretagne, irlande, traditions |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 21 novembre 2008
Savitri Devi: Hellénisme et hindouisme, la grande aventure

Savitri Devi:
Hellénisme et hindouisme, la grande aventure
par Jean Mabire
Le goût très moderne pour le scandale et l’étrange peut parfois transfigurer les aventures intellectuelles les plus captivantes en trompeuse pâture médiatique. C'est ainsi que le livre de Nicholas Goodrick-Clarke, Hitler’s priestess, récemment traduit en français sous l’étiquette La prêtresse d’Hitler, risque d'attirer les amateurs d’ésotérisme de pacotille en dissimulant l’itinéraire absolument passionnant de cette Grecque, née en France, qui devait découvrir aux Indes le point d'ancrage d’une singulière croyance politico-religieuse.
Personne ne connaissait cette femme, auteur d’une vingtaine de livres, où un authentique chef-d’œuvre, L’Etang aux lotus, témoignage d’une fort poétique conversion, voisinait avec un portrait fabuleux du pharaon Akhenaton, fils du soleil s’il en fut, et des pamphlets d’une rare violence publiés après la guerre en éditions semi-clandestines.
Celle qui se faisait appeler Savitri Devi et épousa le militant nationaliste hindou Asit Krishna Mukherji devait, sur la fin de sa vie, fréquenter les milieux les plus extrémistes d’Europe et d’Amérique où elle passa pour une sorte d’illuminée.
Les chemins intellectuellement et spirituellement les plus insolites comme les plus dangereux qu’elle fréquenta par passion tout autant que par devoir, ne peuvent faire oublier les longues années où elle rechercha, toujours sincère, une sorte de foi indo-européenne exaltée, dont elle fut, plus qu’une prêtresse, un véritable « gourou », à la fois oriental et « polaire ».
L’hérédité est là. Implacable. Celle qui se fera un jour appeler Savitri Devi est née le 30 septembre 1905, dans le Rhône, d’une mère originaire de Cornouaille britannique nommée Nash et d'un père moitié italien de Londres [Lombardy—ed.] et moitié grec de Lyon, qui portait le nom de Portas. L’enfant reçoit le prénom de Maximiani, forme féminine hellénique de Maximien. En remontant fort loin dans le temps, elle pouvait se dire « nordique », Jutlandaise du côté maternel et Lombarde du côté paternel.
Elle était aussi « Barbare », influencée par les poèmes de Charles Leconte de Lisle, le dieu littéraire de sa jeunesse.
Curieusement, sa germanophilie remonte à un premier séjour en Grèce, où elle rêvait des Doriens sur les ruines de l’Acropole d'Athènes. De retour en France, elle devait acquérir la nationalité hellénique en 1928 par une démarche au consulat grec de Lyon, sa ville natale. De solides études la conduisent à un double doctorat en 1935, avec un essai critique sur son lointain compatriote Théophile Kaïris, poète et patriote, éveilleur du nationalisme hellénique, et une thèse sur La simplicité mathématique.
C’est tout à la fois une littéraire, une scientifique et surtout une passionnée aux élans fort romantiques. De son enthousiasme pour la Grèce, elle tire un engouement pour l’aventure indo-européenne qui la conduira en Inde, où elle découvre l'immense richesse d’une culture païenne pré-chrétienne.
Elle se veut désormais citoyenne de l’Âryâvarta, nom traditionnel des territoires aryens de l’Asie du Sud où elle va rechercher « les dieux et les rites voisins de ceux de la Grèce antique, de la Rome antique et de la Germanie antique, que les gens de notre race ont possédés, avec le culte du Soleil, il y a six mille ans, et auxquels des millions d’êtres vivants de toutes les races restent attachés ».
Au printemps 1932, à 27 ans, elle accomplit ce que Lanza del Vasto nommera un jour « le pèlerinage aux sources ».
Elle n’est pas une touriste mais une croyante. Elle va rapidement apprendre les langues du pays, l’hindî et le bengali, et vivre dans l’âshram de Rabîndranâth Tagore à Shantiniketan, dans le Bengale. Elle part ensuite comme professeur dans un collège non loin de Delhi, où elle enseigne l’histoire.
Maximiani Portas prend alors le nom de Savitri Devi, en l’honneur de la divinité solaire féminine.
En 1940, elle fait paraître à Calcutta son premier livre, L’Etang aux lotus, où elle raconte dans un style très lyrique sa « conversion » à l’hindouisme, à la fin des années trente. Ce livre, publié en français, est à la fois récit de voyage et longue quête spirituelle d’une jeune femme qui va désormais vivre illuminée par une foi qui ne la quittera plus jamais :
« Si j’avais à me choisir une devise, je prendrais celle-ci : Pure, dure, sûre, en d’autres termes : inaltérable. J’exprimerais par là l’idéal des Forts, de ceux que rien n’abat, que rien ne corrompt, que rien ne fait changer ; de ceux sur qui on peut compter, parce que leur vie est ordre et fidélité, à l’unisson avec l’éternel. »
Dès la fin de 1936, elle s’est fixée à Calcutta, où elle enseigne à ses nouveaux « compatriotes » l’hindouisme, « gardien de l’héritage aryen et védique depuis des siècles, essence même de l’Inde ».
Tout naturellement, sa vision religieuse est aussi une vision politique et elle s’implique totalement dans le nationalisme hindou et notamment dans le mouvement de D.V. Savarkar. L’Inde n'est pas seulement une patrie, une future nation, c’est aussi une véritable Terre Sainte, celle des Védas, des dieux et des héros.
Elle écrit, cette fois en anglais : A Warning to the Hindus, où elle critique les influences chrétiennes et musulmanes, dans une optique à la fois païenne et anticolonialiste. Elle épouse alors Asit Krishna Mukherji, un éditeur hindou, assez anti-britannique pour s’affirmer pro-germanique.
Du combat culturel et religieux, elle passe, sous son influence, à la lutte clandestine dans le sillage du chef nationaliste Subhas Chandra Bose, qui rêve d’une armée capable de libérer les Indes, avec l’aide des Allemands et des Japonais.
Savitri Devi, devenue militante, n’en poursuit pas moins sa grande quête spirituelle. Elle se passionne alors pour le pharaon égyptien Akhenaton, époux de la reine Néfertiti et fondateur d’une religion solaire vieille de 3.300 ans.
Son penchant pour ce souverain, qu’elle nomme « fils de Dieu », se double d’un véritable culte de la Nature qui la conduit à prendre la défense des animaux dans son livre Impeachment of Man, critique radicale de l’anthropocentrisme.
Le livre paraît en 1945. Elle vient d’avoir 40 ans et décide de partir en Europe, où elle veut voir ce que devient l'Allemagne de la défaite. Elle séjourne d’abord à Londres et à Lyon. Puis elle se rend dans les ruines du IIIe Reich. Elle affirme vivre alors dans le « Kali-Yuga », l’Age de Fer, d’où repartira un nouveau cycle : Ages d’Or, d’Argent et de Bronze.
Elle défend la théorie des trois types d’Hommes : les Hommes dans le Temps, les Hommes au-dessus du Temps et les Hommes contre le Temps. Elle s’exalte de plus en plus et considère désormais Hitler comme un « avatar », une réincarnation des héros indiens de la Bhagavad Gîtâ !
Ses propos et ses brochures lui vaudront d’être emprisonnée à Werl par les autorités de la zone d’occupation britannique qui l’accusent de néo-nazisme.
Libérée en 1949, elle va désormais se partager entre l’Inde, l’Europe et l’Amérique, écrivant des pamphlets politico-religieux d’une rare violence : Défiance (1950), Gold in the Furnace (1953), Pilgrimage (1958), The Lightning and the Sun (1958).
Tandis que ses livres paraissent à Calcutta, elle parcourt le monde au hasard de ses obsessions et de ses amitiés, rencontrant, sans discernement, quelques rescapés de l’aventure hitlérienne et bon nombre de néo-nazis, souvent parmi les plus folkloriques.
Elle vit chichement de son métier d’institutrice et fera plusieurs séjours dans des asiles de vieillards indigents, alors qu’elle est devenue presque aveugle. Elle meurt chez une amie, dans un petit village anglais de l’Essex, le 22 octobre 1982, à l’âge de 77 ans.
Si le livre, assez hostile, que lui a consacré Nicholas Goodrick-Clarke la qualifie de « prêtresse d’Hitler », il aurait peut-être été plus juste de la présenter comme « prophétesse du New Age et de l’écologie profonde »…
Publié dans la série de Jean Mabire, « Que lire ? », volume 7, 2003.
00:10 Publié dans Biographie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : histoire, hindouisme, traditions, traditionalisme, hellénisme, national-socialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 28 octobre 2008
Bruno Favrit: le recours aux montagnes
Le recours aux montagnes
Auteur entre autres d’un essai remarqué sur Nietzsche et d’un court roman de guerre, Bruno Favrit est à la fois un homme à la culture aussi profonde qu’originale et un alpiniste chevronné. Avec Ceux d’En Haut, son récent recueil de nouvelles, il nous offre un hymne à la haute montagne en tant qu’école de vie, car l’ascension s’y révèle surtout comme une rude initiation à une vision du monde spartiate. Des Cévennes au Caucase, ses héros, solitaires ou groupés en phalanstères (voire en patrouilles), affrontent la montagne pour mieux échapper aux blandices d’une modernité pour laquelle B. Favrit éprouve une tendresse limitée. Sveltes et bronzés (y compris sur le plan mental), ces jeunes gens qui comptent dans leurs rangs quelques troublantes amazones choisissent -ou refusent - cette conversion « hérakléenne » qui fascine cet écrivain pétri de pensée antique. Celui-ci tente en fait de mettre en pratique la sentence de Malraux : « approfondir sa communion ou cultiver sa différence ». Aussi, chez ses personnages, le panthéisme vécu sous la morsure du gel ou du soleil invaincu débouche-t-il sur la solitude des sommets. Quant aux culs de plomb, ceux qui sont morts sans le savoir, malheur à eux ! Livre attachant, d’un courage certain - qui pourrait toutefois être plus serein, au ton moins polémique, mais Favrit se veut disciple d’Héraclite - et à mille lieues de la chiennerie dominante, Ceux d’En Haut illustre la permanence d’une posture à la fois stoïcienne et épicurienne (somptueuse évocation d’un festin solsticial). Bel exemple de refus de l’aliénation techno-marchande, de quête de l’excellence et d’exaltation du « divin imprévu » cher à Stendhal, ce livre tonifiera tous ceux que tente la méditation du haut des cimes.
Christopher Gérard
Bruno Favrit, Ceux d’En Haut, Ed. Auda Isarn, 194 pages, 18€
Rencontre avec Bruno Favrit
Propos recueillis par Christopher Gérard
Qui êtes-vous ? Comment vous définiriez-vous ? Les grandes étapes de votre itinéraire littéraire et spirituel ?
S'il me faut absolument répondre, je dirai : un passionné qui accepte de connaître ce qui veut le réduire pour mieux s'en défaire ensuite. Former une réponse plus complète m'épuiserait assurément. Parce que je n'ai pas cessé, comme dirait Hamsun, de constituer un petit sujet d'étonnement pour moi-même. Ce qui, en un sens, peut être bon signe, si cela signifie qu'à l'échelle d'une vie, rien n'est jamais acquis mais rien n'est jamais achevé.
Pour ce qui est des grandes étapes de mon itinéraire, je ne serai guère plus affirmatif. Il y a une sorte de constante mue par une soif originelle. Un phénomène dont l'explication est au-dessus de mon entendement mais dont je suis conscient qu'il n'a rien d'exceptionnel pour qui est à l'écoute. Je peux tout de même citer le passage par le scoutisme. Je crois que je me suis aussi construit dans ce mouvement qui n'eut alors pour moi absolument rien d'ordinaire. Mais je n'ai lu les romans de Foncine et de Dalens que bien plus tard : je m'appliquais à vivre la réalité avant tout. A quinze ans, il y a eu Nietzsche. Je ne comprenais pas tout, évidemment, mais je percevais que se tenait dans le Crépuscule des idoles et le Zarathoustra une éthique très différente de tout ce qui m'avait été enseigné jusque-là. Cette lecture m'a donné le goût d'aborder les écrits d'autres maîtres d'élévation sans renoncer pour autant à parcourir les forêts et les crêtes. La fréquentation de la Phusis, la Nature sous son acception la plus large, m'a appris l'essentiel, enseignement que la société moderne ne propose plus. Cette immersion m'a également aidé à penser par moi-même en me tenant éloigné des absolutismes tels l'empirisme et les ''valeurs'' spéculatives.
Spirituellement, le qualificatif de panthéiste me convient. Pour ne pas se laisser accaparer par le dogme il faut se construire sa vision du monde en convoquant ses évidences instinctive et héréditaires.
Les grandes lectures ?
Sans doute peut-on se prononcer sur les livres essentiels à ce que l'on éprouve le besoin de les relire. Nietzsche continue à me soutenir. Mais également des penseurs comme Schopenhauer et Cioran. Sans oublier la philosophie antique. C'est la partie métaphysique de cette aventure qui me paraît déterminante. (Je reste assez insensible à l'épistémologie, sans doute parce que mon côté pyrrhonien m'inspire une confiance modérée dans le résultat.) Pour le style : Saint-Simon, Chateaubriand, Rousseau, Mérimée, Barrès, Montherlant. Bien que lisant peu de romans, des auteurs comme Giono, Hamsun ou Lawrence me touchent. J'affectionne aussi l'oeuvre où l'auteur se met à nu ; Henry Miller, Jack Kerouac, Blaise Cendrars, Gabriel Matzneff, furent pour moi de véritables révélations en la matière. Il me semble en effet important de rester plongé dans le réel. Mais un réel qui sait s'accommoder de la métaphysique et des mythes, eux-mêmes à considérer comme une réalité conceptualisée. Je peux citer également Alain Daniélou, Mircea Eliade, Fernando Pessoa, Hermann de Keyserling, Joseph Conrad.
Les grandes rencontres ?
Cette question renvoie pour moi à la précédente : qu'importe que les auteurs que nous relisons aient ''disparus'', leur talent demeure face à la grande majorité de nos contemporains qui excellent en mondanités et courent après les prix. Un livre et la confrontation peut avoir lieu. Mes plus grandes rencontres, je les ai faites aussi dans la fréquentation de sites préservés comme en Irlande, en Laponie, sur les grands causses ou les pentes des Alpes. J'aime la magie des lieux. J'aime voir où ont vécu, où ont écrit ceux qui m'ont marqué. L'Engadine d'Ainsi parlait Zarathoustra, le Valais de Derborence, le Montmartre de Jours tranquilles à Clichy, le quartier latin qui a vu naître Nous n'irons plus au Luxembourg et De l'inconvénient d'être né, la Bourgogne des Etoiles de Compostelle, les Calanques de Bourlinguer, le Vercors d'Un roi sans divertissement, le Montserrat d'Un Voyageur solitaire est un diable.
Après un essai sur Nietzsche et une synthèse sur le vitalisme, vous publiez un recueil de nouvelles dont le personnage principal est la montagne. Vous inscrivez-vous dans la lignée d’un Frison-Roche ou d’autres écrivains de la montagne ? D’où vous est venue cette passion ?
J'ai lu Frison-Roche, mais des écrivains comme Saint-Loup, Ramuz ou Buzzati me paraissent bien plus indispensables. Et un Reinhold Messner, même s'il n'a pas un style inoubliable, est à lire parce qu'il décrit dans ses livres une expérience personnelle réellement nietzschéenne. De là à dire que je m'inscris dans cette lignée d'écrivains, nous dirons que je m'efforce de m'y inscrire, conscient de mes faiblesses. Sur ce point, je me qualifierai plus convenablement de questeur qui s'essaye à l'écriture sans y consacrer tout le temps qu'il faudrait...
Quant à ma passion pour la montagne, elle est née d'une ascension en falaise, dans laquelle m'avaient entraîné deux amis, et d'un séjour estival dans les Alpes suisses où j'ai découvert que ce qui pouvait se faire sur le calcaire à 120 mètres de hauteur se trouvait démultiplié en terme de sensations sur le granit à 3000. J'ai vite ressenti le besoin de ne me détacher jamais longtemps des verticalités et de garder le spectacle de ces virginités ''à portée de main''. Je suis devenu, comme on dit aujourd'hui, un addict. L'escalade et l'alpinisme constituent un moyen idéal de trouver l'air pur, la beauté et de tester sa détermination. Cette nécessité n'a pas été exposée uniquement dans Ceux d'en haut qui a eu un précédent. Les Nouvelles des dieux et des montagnes, parues en 2004, rendaient déjà hommage à l'altitude. J'ai tenté d'y montrer qu'elle est aussi un moyen de fréquenter la divinité.
Les hommes et les femmes que le lecteur croise dans votre livre ont tous en commun de manifester une forme plus ou moins ouverte de rébellion contre le monde moderne.
Pour ce qui est de mon époque, ce n'est pas tant qu'elle me désespère – chacun trouve midi à sa porte – ; je souhaite seulement être le moins possible corrompu par elle. Du moins tenté-je de ne pas céder à ses triviales injonctions. Pas de propriété, pas de stock-options, pas d'idées arrêtées sur les vices ou les vertus (d'autant plus que je crois en la relativité des valeurs). Comme dit Marcel Conche, un des rares philosophes actuels remarquables : « Il faut se retirer de tout ce qui a une signification maintenant, mais n’en aura plus demain. » Cela est vrai pour l'action comme pour la connaissance. Mes personnages me ressemblent parce que je les ai fréquentés ou qu'ils sont un peu de moi-même. Je m'inspire de la réalité pour les mettre en scène. La ''révolte contre le monde moderne'' n'est pas qu'une forme de littérature. Bien qu'ils se fassent, hélas ! rares, il y a encore des corps et des esprits vitalisés en ce bas monde.
Ce qui frappe aussi à la lecture de votre recueil, c’est votre proximité avec la Grèce ancienne, celle d’Héraclite. Comment expliquez-vous ce trait plus qu’original ?
Héraclite ! Il est présent dans la nouvelle ''La Voie hérakléenne'', mais aussi dans Vitalisme et vitalité. Tout ce qui nous reste de lui est constitué de fragments que les doxographes et les philosophes ont sauvé de l'oubli, ''dégraissant'' au passage sa pensée. Cela donne du coup à ses écrits une dimension exceptionnelle. Un présent inestimable pour un âge perclus de discours et de circonlocutions où nul ne ressent plus le besoin de lutter contre l'encombrement et la superfluité. Le vieux sage païen a influencé Platon mais aussi Char et Heidegger, ce qui n'est pas rien. Autant de richesse dans une petite centaine d'aphorismes, il n'y avait que de la Grèce antique qu'un tel héritage pouvait nous venir.
Vos projets ?
Beaucoup trop. J'avance toujours sur plusieurs fronts au gré de mon inspiration... et de mes dispositions à l'éparpillement ! Selon le vieux précepte antique, je pars du principe que naviguer est nécessaire si l'on veut aborder de nouveaux rivages et ne pas s'émousser dans les béatitudes que ces temps encouragent. Alors cinglons au large et tentons de nouvelles expériences. En ce moment, je me consacre plus particulièrement à la composition d'aphorismes. Un travail en chantier depuis des années qui impose des choix; polir, élaguer, supprimer. Encore et toujours la tentation d'une forme d'allégement.
Quelques projets aussi de grandes voies où je puisse me perdre pour me trouver. Tant que les dieux me donnent l'énergie d'aller par ce moyen à leur rencontre, je n'y renonce pas.
Avignon, printemps 2008
00:10 Publié dans Alpinisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, montagnes, traditions, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 23 octobre 2008
Fosco Maraini
Fosco Maraini est né à Florence, le 15 novembre 1912. C'est un ethnologue, orientaliste, alpiniste et écrivain italien. Il est le fils du sculpteur Antonio Maraini et de l’écrivain Yoi Crosse. L’une de ses filles, Dacia Maraini, est devenue écrivain.
Poussé par une immense curiosité pour l’Orient, il embarque en 1934 comme professeur d’anglais sur l’Amerigo Vespucci, navire école de la marine italienne. Il découvre l’Égypte, le Liban, la Syrie et la Turquie. En 1937, diplômé en sciences naturelles et anthropologie à l’Université de Florence, il rejoint l’équipe de l’orientaliste Giuseppe Tucci et part au Tibet. Il se consacrera désormais à l’ethnologique et à l’étude des cultures orientales.
Juste avant la Seconde Guerre mondiale, il s’installe au Japon pour enseigner l’anglais à l’Université de Kyōto. Mais le 11 septembre 1943, après l'armistice signée par l'Italie, le Japon oblige les ressortissants italiens à prêter serment à la République de Salo. Enfant du fascisme, il s’oppose à cette république fantoche et est alors interné avec toute sa famille dans un camp d’internement à Nagoya. Quand la guerre prend fin il revient en Italie, puis repart vers ses destinations de prédilection : Tibet, Japon, Corée...
Il enseigne le japonais à l’Université de Florence. Il est considéré comme l’un des plus grands experts de la culture aïnoue, peuple du nord du Japon. En 1958, Maraini, alpiniste accompli, est invité par le Club alpin italien à participer à l’ascension du Gasherbrum IV (7 980 m) dans le massif du Karakoram.
Il décède dans sa ville natale de Florence le 8 juin 2004 à l'age de 91 ans.
Il est l’auteur de nombreuses photographies prises en Asie centrale, au Japon et au Tibet, ainsi que dans les massifs du Karakoram et de l’Hindou Kouch. Sa production photographique fera l’objet de nombreuses expositions en Europe et au Japon. Il est l’auteur d’ouvrages ethnologiques, ainsi que d’œuvres littéraires (romans et poésie). En voici 3 publiés en Français :
- Tibet secret (Segreto Tibet), préface de Bernard Berenson, traduction de Juliette Bertrand (ouvrage orné de 68 héliogravures d’après les photographies de l’auteur), Arthaud, Grenoble, 1954.
- Japon (Ore giapponesi), traduction de Angélique Lévi (ouvrage orné de 79 photographies de l’auteur), Arthaud, Paris, 1969.
- Le Nuvolaire. Principes de nubignose, Rome 1995, Clémence Hiver éditeur, Sauve (Gard) 1999
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditionalisme, orientalisme, asie, anthropologie, ethnologie, traditions, religions |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 19 octobre 2008
De l'Irlande païenne à l'Irlande chrétienne
Historique , de l’Irlande païenne à l’Irlande chrétienne
Trouvé sur: http://scenehurlante.hautetfort.com
La conversion des îles britanniques
A l'aube de l'ère chrétienne, toutes les zones anciennement celtisées ont été conquises ou sont en passe de l'être, que ce soit par les romains ou par d'autres. La Gaule se latinise à grande vitesse, et la Bretagne a déjà vu les premières incursions romaines. Au même moment, à plusieurs centaines de kilomètres de là, un petit juif barbu s'apprête à changer la face du monde. .
Traditionnellement, le 17 mars, jour de la saint Patrick, est fête nationale en Irlande. On attribue à ce fils de fonctionnaire romain (né vers 385, mort vers 461) la conversion au christianisme des Irlandais. Une conversion qui ne s'est pas fait sans difficultés. En effet, après avoir vécu jusqu'à l'âge de seize ans dans un petit village du pays de Galles, saint Patrick est enlevé par des pirates Irlandais qui l'emmènent chez eux où ils le gardent prisonnier pendant six ans. Une fois libéré, saint Patrick regagne l'Angleterre. C'est alors qu'il a des visions dans lesquelles les Irlandais l'implorent de revenir. Dans un premier temps, il passe en Gaule et est ordonné diacre à Auxerre. Après cette première mission, il fait un voyage à Rome, entre 441 et 443, et, de retour en Irlande, établit son siège épiscopal à Armagh - il aurait installé son église dans la grange de son premier fidèle converti. Divisant l'Irlande en diocèses - qui correspondent aux royaumes des rois celtiques -, il fixe les structures de I'Eglise irlandaise. Son histoire s'entremêle avec les légendes irlandaises.
Quoi qu'il en soit sur la réalité historique du personnage, et bien que certains doutent de son existence, la réalité de la conversion - plutôt rapide - de l'Irlande reste indiscutable. Au tournant du Ve siècle, toute l'élite de la vieille Erinn est dévouée au Christ. Comme en Gaule, les masses paysannes mettront plus longtemps à se tourner vers le Dieu d'Abraham. En France, au bas Moyen-Âge, certain adoraient encore sources ou arbres, pierres ou collines, et l'on trouve encore parfois des bas relief d'inspiration païenne, notamment celtique dans certaines constructions des XIe-XIIe siècle, y compris dans des édifices religieux (on peut en voir quelques-uns sur les façades des églises irlandaises, ou en France, dans la chapelle de la nécropole de Saint Floret, dans le Puy de Dome).

Le monachisme irlandais
Dès les origines, le clergé Irlandais adopta des rites et des pratiques assez librement inspirées du rite romain, et de manière générale afficha une certaine émancipation par rapport à la puissance tutélaire romaine. Cela lui valu de nombreux rappels à l'ordre qui ne restèrent pas éternellement sans conséquences, puisqu'au XIIe siècle, c'est avec la bénédiction du Pape que les franco-normands (devenus les anglo-normands) prirent pied en terre d'Irlande, avec pour mission - entre autres - de remettre l'Eglise d'Irlande au pas.
On peut peut-être attribuer l'extraordinaire réussite du christianisme dans les pays celtes à la profonde spiritualité de ces peuples, qui les a fait recevoir le dogme chrétien comme conforme à une certaines vision de leurs conceptions métaphysisques. On peut pour mémoire rappeler que le paganisme celtique croyait à l'immortalité des âmes, comme le christianisme. Certes, de nombreux peuples y croyaient, mais sans que cela recouvre la même importance. De même, les celtes partageaient avec le monothéisme juif, et par conséquent chrétien, l'interdiction de la représentation anthropomorphique des Dieux. Et de manière plus concrète, la figure du Druide celte ressemble de près par son importance sociologique à la figure du prêtre chrétien. Dans peu d'autres peuples on ne retrouve une telle prééminence de la fonction religieuse, prééminence qui se prolonge à l'époque chrétienne dans les ministres du culte. Si la conversion de l'île d'Irlande a pu être aussi rapide, c'est que Saint Patrick - ou les séides de l'Eglise, s'il n'a pas existé - a su à qui s'adresser en premier lieu : c'est vers les druides qu'il a tourné ses premiers efforts, entraînant avec eux l'élite aristocratique.
L'exubérance de l'art chrétien irlandais
En outre, l'apparition du christianisme en Irlande coïncide peu ou prou avec le développement d'une certaine forme d'art sacré, qui trouvera son apothéose dans les magnifiques manuscrits des VIIIe-IXe siècles, comme le Livre de Kells (photos à droite et ci dessous), qui reste aux yeux de tous le plus bel exemple de l'enluminure chrétienne, et qui constitue dans l'absolu une oeuvre d'art unique. Cet ouvrage est actuellement détenu par le Trinity College à Dublin. De manière globale, les " siècles obscurs " de l'Europe continentale furent en Irlande ceux d'une apothéose spirituelle qui amena les monastères irlandais à devenir des centres religieux de première importance, parmi lesquels le plus célèbre reste celui de Clonmacnoise (près d'Athlone, en République d'Irlande), dont la réputation et l'influence dépassa de loin les limites étroites de leur île. Nombreux furent les moines irlandais qui se répandirent sur le continent pour fonder ordres monastiques, missions évangélisatrices,... Les magnifiques enluminures des moines irlandais eurent elles aussi une influence artistique que l'on imagine pas : certains chercheurs font des rapprochements entre celles ci et celles des chrétiens d'Egypte, les coptes.
De plus, alors qu'ils enluminaient les plus beaux exemplaires de la Bible, les moines irlandais eurent aussi l'excellente idée de coucher par écrit les légendes et la mythologie irlandaise avant qu'elle ne se transforme en simple conte pour enfant. Ce travail a permis de sauver la trace précise d'une mythologie indo-européenne riche et grandiose. A titre de comparaison, on ne sait rien ou presque des Dieux Gaulois, à l'exception de quelques noms ou de grandes figures. A ce titre, les moines irlandais méritent la reconnaissance, car plus que leurs homologues du continent, ils ont eu à coeur de respecter et de préserver une structure sociale et une civilisation ancienne.
Christianisme et spiritualité celte
Mais ce qui a provoqué une certaine renaissance des nations celtes dans les îles, c'est aussi le départ des légions romaines. Leur départ de l'île de Bretagne, notamment, vit l'apparition des épopées arthuriennes, que l'on ne présente plus. Au même moment, le royaume de Bretagne s'étendait au continent, lorsque les iliens retournèrent en nombre s'installer dans la péninsule armoriquaine, donnant ainsi naissance à la Bretagne continentale.

En outre, il ne faut pas se leurrer non plus : si l'apparition du christianisme a pu redonner une certaine vigueur à la société irlandaise, il ne faut pas oublier que ce fut au prix de la disparition de l'antique paganisme celtique, qui avait ses vertus, tout autant -voire plus- que le christianisme. Nous ne reviendrons pas sur les remarques que nous avons déjà formulé sur la nature intrinsèquement exclusive et close du discours monothéiste, en ce sens que le monothéisme ne tolère pas la diversité, quoi que nombreux soient ceux qui l'en défendent. Sur le caractère totalitaire du christianisme, et du monothéisme de manière générale, l'Histoire a été assez éloquente, et il n'est pas nécessaire de multiplier les exemples. Qui plus est, le mode de pensée binaire et manichéen du christianisme (bien/mal ; juste/injuste ; vrai/faux ; ...), qui l'est plus encore sans doute que dans le judaïsme ou l'islam, a aboli un mode de pensée sans doute plus riche et plus subtil sur bien des points. Certes, rien ne dit que la société aurait été meilleure, surtout si l'on considère que la religion elle même n'est qu'une superstructure, et que la forme de la société est essentiellement dictée par le mode de production. Mais en tout cas, on se serait peut être un peu plus amusé...
Ces motifs, pour la plupart sculptés sur des plaques de chancel, sont de pures abstractions. Ils ont un parallèle dans l’enluminure avec ce qu’on appelle les tapis d’ornement. La discussion a été vive pendant longtemps sur la signification implicite de ces panneaux. Leur datation a rejeté l’argument de la crise iconoclaste car bien trop tardive pour en constituer une explication. Bien que ce rejet de l’image figurative ait été latent durant de longues périodes puisque celui-ci existait dans la culture antique perse et se propageait avec les armées arabes islamisées, il ne saurait constituer une réponse suffisante car il a été démontré précédemment que l’entrelacs n’était particulier à aucun pays ni aucune civilisation et qu’on le retrouvait sous différentes formes sur les quatre coins du globe. En fait, tous les arts abstraits fondés sur la géométrie reflètent la science primitive de l’homme en lien avec l’observation des astres. L’astronomie ou la prévision des phénomènes de l’univers a mis en évidence la notion de cycles. Toutes les grandes civilisations se sont penchées sur cette science qui ne se comprenait que par la logique mathématique et son expression schématique : la géométrie. Dans l’art, reflet de l’esprit humain utilisant le schéma de la symbolique, l’astronomie pouvait se résumer dans ces figures religieuses qu’étaient les svastikas, yin et yang, triskels, roues solaires et entrelacs. Toutes mettent en place une idée de mouvement, de cycles et les civilisations qui les ont générées procèdent d’une expérience commune.
00:09 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : traditions, paganisme, traditionalisme, irlande, iles britanniques, christianisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 03 octobre 2008
Histoire des Sikhs
 |
Synergies Européennes - Ecole des cadres - Wallonie/Lorraine - Octobre 2008 - Ouvrages à lire
DU NANAK PANTH AU KHALSA
Le Panjab : région, histoire et cultures
Les débuts du Panth (vers 1500-1606)
La transformation du Panth et la formation du Khâlsâ (1606-1708)
DE LA CONQUETE DU PANJAB A LA PARTITION
Des révoltes paysannes au royaume du Panjab et aux guerres anglo-sikhes (1708-1849)
De l'annexion du Panjab aux lendemains de la Grande Guerre (1849-1919)
Dans la lutte pour l'interdépendance (1920-1947)
DE L'INDEPENDANCE A NOS JOURS
Les sikhs dans l'Inde indépendante
Les sikhs dans la société indienne et dans le monde
Pratiques religieuses et culture
00:06 Publié dans Eurasisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eurasie, inde, religion, traditions, traditionalisme, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 15 septembre 2008
Klages e la mistica del primordiale
La mistica del primordiale
 Credeva che l’Amore, forza cosmica ancestrale, fosse impersonale e assoluto. Che vagasse nell’etere, come un’energia che proveniva dai mondi della creazione. Klages non era un visionario. O almeno, non solo. Era un filosofo-poeta contro l’epoca moderna. Nella società della tecnica vedeva la negazione della vera identità dell’uomo, che secondo lui proveniva dalle leggi primitive dell’esistenza, da ciò che lui chiamava anima. Anima è l’origine, è il segreto della vita, è il sigillo che ogni uomo e ogni popolo si porta dietro come un simbolo. Anima è la fusione con la natura, è la voce silenziosa degli avi, che non sappiamo più percepire. Tipico dell’epoca moderna è il voler andare contro l’anima, il voler costruire ideali artificiali, rapporti sociali falsi, utopie ingannatrici. Contro la purezza originaria della vita e contro l’armonia primordiale degli uomini e delle cose è sorto un giorno quel vizio assurdo che è lo spirito, cioè la ragione, l’intelletto razionalista. Energia distruttrice delle radici cosmiche dell’uomo, lo spirito ha in ogni epoca edificato imposture: tra queste, la coscienza repressiva invece dell’anima libera, la volontà tirannica invece della libertà senza limiti di spazio, la storia invece del tempo senza tempo.
Credeva che l’Amore, forza cosmica ancestrale, fosse impersonale e assoluto. Che vagasse nell’etere, come un’energia che proveniva dai mondi della creazione. Klages non era un visionario. O almeno, non solo. Era un filosofo-poeta contro l’epoca moderna. Nella società della tecnica vedeva la negazione della vera identità dell’uomo, che secondo lui proveniva dalle leggi primitive dell’esistenza, da ciò che lui chiamava anima. Anima è l’origine, è il segreto della vita, è il sigillo che ogni uomo e ogni popolo si porta dietro come un simbolo. Anima è la fusione con la natura, è la voce silenziosa degli avi, che non sappiamo più percepire. Tipico dell’epoca moderna è il voler andare contro l’anima, il voler costruire ideali artificiali, rapporti sociali falsi, utopie ingannatrici. Contro la purezza originaria della vita e contro l’armonia primordiale degli uomini e delle cose è sorto un giorno quel vizio assurdo che è lo spirito, cioè la ragione, l’intelletto razionalista. Energia distruttrice delle radici cosmiche dell’uomo, lo spirito ha in ogni epoca edificato imposture: tra queste, la coscienza repressiva invece dell’anima libera, la volontà tirannica invece della libertà senza limiti di spazio, la storia invece del tempo senza tempo.
Si capisce subito che in Klages rintoccano alcune eco di Nietzsche: la celebrazione delle origini e delle radici, la nostalgia di un’epoca mitica - quella dei “Pelasgi” - in cui gli uomini erano potenze dell’universo prive di angosce e paure, padroni di se stessi e dei propri istinti sovrani.
Nostalgia per l’epoca in cui sorsero i miti delle antiche civiltà, quando l’intuito, l’inconscio e le percezioni sensitive non erano ancora stati repressi dalle armi di distruzione della perversa intelligenza: il concetto, il giudizio, il criticismo. Quella era la vera vita: liberazione degli istinti e delle sensazioni, senza complessi, senza colpe, senza nessuna idea del “peccato”. Questo dell’uomo razionalista è invece il trionfo dell’anti-vita artificiale, che crea i mostri della tecnica e del progresso materiale.
La vita come estasi. Se l’uomo fosse in grado di tornare alla magia dell’origine, potrebbe sbarazzarsi di tutti i fardelli angosciosi che impone la schiavitù della modernità, che ha robotizzato i cervelli e isterilito le anime. La libera psiche è Eros, amore cosmico, distacco romantico dai vuoti interessi terreni. Nel suo libro famoso Dell’Eros cosmogonico, risalente al 1922, Klages celebrò l’Amore totale, il magnete che attrae magicamente due poli anche lontani tra loro, al di là della semplice sessualità, come un moto unitario di natura e un legame di sangue: “Il compimento consiste nel destarsi dell’anima, ed il destarsi dell’anima è contemplazione, ma essa contempla la realtà delle immagini originarie; le immagini originarie sono anime del passato che appaiono; per apparire esse hanno bisogno del legame con il sangue di chi è ancora vivo ed ha ancora un corpo”. In questo “mistico sposalizio” tra anima e “demone generatore” si compie, alla maniera platonica, secondo Klages, la trasformazione del semplice uomo in uomo assoluto, cosmico.
Klages amava la cultura romantica, che pensava per simboli, e che assegnava ai sentimenti il primo posto nella scala dei valori. Ma amava anche Goethe, la sua ricerca dei fenomeni originari come manifestazione del divino. Goethe era poeta, romanziere, scienziato. Ma uno scienziato che credeva ai fenomeni intuitivi, alla magia che è in natura. Ad esempio, il suo romanzo sulle Affinità elettive - in cui rappresentò il caso di una gravidanza condizionata dalla forza psichica del pensiero d’amore, al di là delle normali leggi biologiche - piacque moltissimo a Klages, che giunse a considerare Goethe come un maestro di sapienza inconscia, un poeta delle possibilità magnetiche della psiche umana. Non dunque il solare, l’olimpico genio che siamo abituati a conoscere, ma una sorta di mago indagatore dei segreti dell’anima e dei poteri occulti racchiusi nelle energie di Madre Natura.
Ritroviamo questi temi nella recente traduzione italiana di un piccolo libro di Klages del 1932, Goethe come esploratore dell’anima (editore Mimesis), in cui Goethe diventa quasi un sacerdote neo-pagano. Egli, studiando ad esempio la metamorfosi delle piante, in realtà aveva penetrato il mondo delle segrete potenze primordiali: i mutamenti, le polarità, i magnetismi. Klages, con mentalità irrazionale e religiosa, vede dunque nel genio di Goethe non semplicemente un grande poeta o un grande romanziere, ma un uomo capace di avvicinarsi al cuore divino della vita. Scienziato mistico e non razionalista, Goethe diventa agli occhi di Klages il massimo profeta di un ritorno alla natura e alle sue leggi di attrazione tra simili e di differenziazione universale. Klages amò la natura, fu un “ecologista” ante-litteram, ma non così profano e banale come i “verdi” del nostro tempo materialista. Nel suo capolavoro del 1929, Lo spirito come avversario dell’anima - un tomo di oltre mille pagine che fece epoca - Klages scrisse che “chi distrugge il volto della terra, uccide il cuore della terra e priva della loro ’sede’ le potenze che ora si sono dileguate nell’etere”.
Gli dèi sono fuggiti dal mondo perché l’uomo ha profanato la terra e desacralizzato la natura. Ma attenzione: tutto questo non era soltanto letteratura. Era molto di più. Nella rivalutazione dell’irrazionale e dell’inconscio c’era una guerra dichiarata al mondo razionalista, indifferenziato, democratico, ateo, materialista. Giampiero Moretti ha scritto che nell’idea di Klages di coniugare Goethe con Nietzsche c’era inciso il destino dell’Europa, “forse fin dai suoi primi albori, ad esempio, fin dal momento in cui le figure del guerriero e del sacerdote-poeta presero due strade diverse, spesso in lotta tra loro”.
Ora tutto è più chiaro. Molto oltre la mediocrità della new-age attuale, e con tanta profondità culturale in più, Klages fece parte di quella ribellione tradizionalista al mondo moderno che fu pensata in Europa come un’arma di difesa della terra, del sangue, dell’istinto, dell’origine mitica, del simbolo ancestrale, dell’identità mistica di popoli e gruppi umani. Una cultura politicamente vinta e dispersa. Ma non abbastanza da non lasciarci immaginare che possa presto o tardi riemergere, proprio come una di quelle occulte leggi della vita studiate da Goethe.
* * *
LUDWIG KLAGES: L’IRRAZIONALISMO INNANZI TUTTO
Nato a Hannover nel 1872, filosofo, psicologo e grafologo, Klages visse e insegnò a Monaco, dove conobbe Stefan George - il maggior poeta tedesco dell’epoca - entrando nel George-Kreis, il famoso sodalizio di cui facevano parte molti intellettuali di valore (tra gli altri, Bertram, Wolfskehl, Kantorowicz, Gundolf). Collaborò alla prestigiosa rivista di George “Blätter für die Kunst“, alla cui ideologia romantico-estetizzante si formarono intere generazioni di giovani tedeschi. Nel 1899 formò un suo gruppo culturale, i Kosmiker, vicino alle idee dell’antichista Johann Jakob Bachofen e di Alfred Schuler, il visionario studioso di Nietzsche e di Roma antica. Distaccatosi nel 1904 da George, Klages fondò il “Seminario di Psicodiagnostica”, che gli dette la notorietà. Il senso ideologico di questo ambiente consisteva nel recupero dei valori “dionisiaci” e tellurici, con una rivalutazione dell’irrazionalismo e degli aspetti esoterici della vita e della persona umana. Autore prolifico e originale, durante il Terzo Reich fu nominato Senatore dell’Accademia Tedesca di Monaco ma, a partire dal 1938, rimase appartato per l’inimicizia che gli portarono Alfred Rosenberg e i seguaci dell’ideologia volontarista e virilmente eroica, egemone all’interno della cultura nazionalsocialista. Epurato nel 1945, morì nei pressi di Zurigo nel 1956. Tra le sue opere tradotte in italiano: L’anima e lo spirito (Bompiani, Milano 1940); Dell’Eros cosmogonico (Multhipla, Milano 1979); Perizie grafologiche su casi illustri (Adelphi, Milano 1994); Stefan George, in S.George-L.Klages, L’anima e la forma (Fazi, Lucca 1995); L’uomo e la terra (Mimesis, Milano 1998). Di prossima pubblicazione è la riedizione de I Pelasgi presso le Edizioni Herrenhaus di Seregno. Si tratta di un capitolo dell’opera principale di Klages, Der Geist als Wiedersacher der Seele (Lo spirito come avversario dell’anima), mai tradotta in italiano.
Tratto da Linea del 21.III.2004.
Luca Leonello Rimbotti
00:15 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mystique, traditions, tradition, traditionalisme, allemagne, philosophie, ecologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 30 août 2008
Du symbolisme de la hache

Du symbolisme de la hache
Le terme "hache" ("ascia" en italien) existe dans nos langues de manière quasi inchangée au cours des millénaires. Il correspond effectivement au terme latin "ascia", qui dérive de la forme indo-européenne *aksi/*agwesi, que les linguistes ont reconstituée sur base de comparaisons entre le terme latin et le terme gothique "aqizi", le terme de vieil haut allemand "ackus" (en allemand moderne "Axt", en anglais "ax", "adze") et le grec "axi(on)". Il me semble nécessaire de préciser cependant que cette forme est une forme indo-européenne occidentale; les linguistes ont également reconstitué la forme orientale, soit "*peleku", cette fois sur base d'une comparaison entre certaines formes linguistiques grecques et sanskrites. C'est ainsi que le pélican, à travers un processus assez intéressant, se voit assimilé à la hache, à cause de son grand bec caractéristique.
La hache revêt une importance énorme, comme en témoigne le passé archaïque des Indo-Européens. Adams et Mallory expliquent que, durant le néolithique, les haches, en Eurasie, étaient faites de silex ébréchés ou d'autres pierres capables d'être façonnées. En outre, il s'agissait généralement de haches plates; cependant, dans certaines cultures néolithiques plus tardives, on trouve rapidement des haches munies d'une perforation permettant d'y placer un manche. Ces haches sont qualifiées de "haches de bataille"; quand on les trouve dans des sépultures, comme par exemple celles de la céramique cordée (notamment dans les régions d'Europe septentrionale, où l'on parle de la "culture des haches de combat"), elles sont de toute évidence des instruments ou des armes considérées comme "viriles". Elles sont donc les emblèmes d'une société patriarcale et guerrière, car, comme l'a écrit Adriano Romualdi, "la culture nordique ne présente aucune trace de matriarcat: les idoles féminines sont absentes… la structure familiale est solide, les traditions de chasse et de guerre attestent d'une culture éminemment virile". Quant à E. Sprockhoff, il formule des observations extrêmement intéressantes sur la hache de guerre dans l'antique culture mégalithique; il assimile la hache primordiale au dieu du Tonnerre, qui, aux temps les plus reculés, était aussi le dieu du Ciel et du Soleil. D'après ce chercheur allemand, "on consacre à cette puissante divinité des haches d'ambre et d'argile, comme d'ailleurs des haches en miniature. Ainsi, la femme germanique a porté ultérieurement le marteau de Thor comme bijou, suspendu à une chaîne; de même, les populations nordiques de l'âge de la pierre le plus éloigné ont porté au cou cet ornement, en tant que perles d'ambre en forme de hache bipenne, symbole du dieu du Tonnerre et des jours, un dieu qui n'a plus de nom aujourd'hui pour nous. La hache de combat est tout simplement devenue le symbole de la plus haute divinité" (ex: "Die nordische Megalithkultur").
L'irruption de la hache de combat dans les régions du Sud et de l'Est, attestée par des découvertes archéologiques, montre comment se sont déroulées les différentes phases de pénétration indo-européenne; on les identifie évidemment aux pointes les plus avancées des conquêtes cimmériennes et tokhariennes: «Le témoignage concret de cette migration, écrit Romualdi, est l'arrivée subite en Chine d'une quantité d'armes occidentales, que l'on date en Europe entre 1100 et 1800 avant J. C., et qui n'avaient en Asie aucun antécédent». La hache est, en somme, le symbole du dieu céleste suprême et de l'esprit créateur de nos plus lointains ancêtres.
Alberto LOMBARDO.
(Etude parue dans La Padania, 14 octobre 2001 - http://www.lapadania.com ; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, indo-européens, symboles, mythologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 23 août 2008
Les avatars chrétiens de Wodan après la conversion des Germains
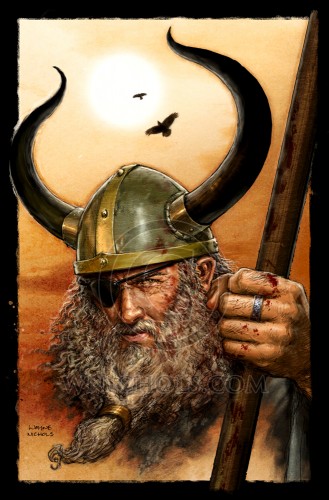
Les avatars chrétiens de Wodan après la conversion des Germains
d'après Otto Rudolf Braun
Wodan était l'une des principales figures divines au temps de la christianisation des Germains. Il était le dieu qui donnait la sagesse aux hommes. Il était aussi le dieu des guerriers et des héros tombés au combat. Son importance était grande parmi les Germains comme le prouve la formule d'abjuration que les convertis devaient prononcer avant de recevoir le baptême. En effet, les Germains, comme tous les païens, avaient d'innombrables dieux et la formule n'en reprend que trois: Donar (Thor), Ziu (dieu primordial indo-européen; Zeus et Ziu ont la même racine) et Wodan lui-même.
Précisons que, pour les premiers Chrétiens de Germanie, les dieux ancestraux n'étaient pas perçu comme des superstitions mais comme des forces ennemies, maléfiques, qu'il s'agissait de combattre. Le spécialiste de la question Erich Jung nous l'explique: «Pendant longtemps, l'Eglise germanique primitive n'a pas nié l'existence et l'action des dieux ancestraux, mais a combattu ces derniers comme des esprits maléfiques, des monstres, des démons. Donc, pour eux, Wodan gardait toute son influence sur les âmes non baptisées. Son Armée (Heer), sa horde, était principalement composée d'âmes d'enfants morts».
C'est la raison pour laquelle l'Eglise demandait aux anciens Germains d'abjurer leurs dieux ancestraux. Mais cette injonction ne fut pas immédiatement suivie d'obéissance: le peuple continuait d'honorer ces anciens dieux. L'Eglise fut donc obligée de changer de politique et de les christianiser, d'en faire des saints. Wodan est par conséquent le dieu qui a connu le plus d'avatars chrétiens.
Il a été transformé en archange Michel, que l'on représente tantôt avec l'attribut de Ziu (l'épée), tantôt avec l'attribut de Wodan (le manteau). A son propos, Cäsarius von Heisterbach (1180-124?), chroniqueur médiéval, cite une légende allemande, où Wodan, très manifestement, entre en scène. C'est la légende du Chevalier Gerhard von Holenbach. Un jour, le diable lui apparaît, déguisé en pélerin. Il frappe à la porte du Chevalier et lui demande l'aumône. Comme il faisait froid, le Chevalier le fit entrer et, pour la nuit, lui offrit son manteau en guise de couverture. Au petit matin, le pélerin avait disparu avec le manteau. Peu après, le Chevalier décide d'entreprendre un pélérinage au tombeau de St. Thomas en Inde. Avant de partir, il brise son anneau en deux morceaux et en donne un à sa femme, afin qu'elle conserve un signe de reconnaissance. S'il ne revient pas avant cinq ans, elle sera libre. Mais le Chevalier n'atteint le tombeau de St. Thomas qu'au jour où il aurait dû rentrer chez lui. C'est alors qu'apparaît le diable vêtu de son manteau qui, en un tour, le ramène d'un coup chez lui. Gerhard retrouve sa femme en train de célébrer son repas de fiançailles avant un autre Chevalier et lance son anneau dans une coupe. Sa femme le reconnaît et le Chevalier reprend sa place.
Le Diable joue ici très nettement le rôle de Wodan. Cäsarius von Heisterbach a sans doute transformé une vieille légende wotanique. Plus tard, au 15° siècle, la chronique suisse des Seigneurs von Stretlingen, de la région du Thurnersee, remplace, dans la même légende, le Diable par l'Archange Michel.
La Sainte Lance est, elle aussi, un ancien attribut de Wodan et même l'un des principaux. Avec sa lance, Wodan désignait les guerriers les plus braves, avant que les vierges-pages ne viennent les chercher pour les conduire au Walhall. Cette sainte lance fit partie, plus tard, des insignes de la cérémonie du couronnement des Empereurs du Saint-Empire, sous le nom de Lance de St. Maurice. A la bataille du Lechfeld contre les Hongrois, on apporta à l'Empereur Othon I la lance dite de St. Michel. La Sainte Lance joua encore un rôle décisif lors d'une bataille de la première croisade quand, en 1098, devant Antioche, les guerriers francs et normands, découragés, minés par la fatigue, ne se relancèrent à l'assaut qu'après l'apparition de la Sainte Lance.
Wodan était le protecteur de Siegfried, lorsque ce dernier terrassa le dragon. Dans la Saga de Wolfdietrich, c'est St. Georges qui reprend ce rôle. Plus tard, St. Georges lui-même tue le dragon, de la même façon que St. Michel. St. George (dont l'existence historique n'est pas prouvée) est devenu ultérieurement le protecteur des armuriers et des guerriers. Son amulette protégeait contre les coups de lance malencontreux.
Les anciennes églises dédiées à St. Michel se situent toutes au sommet de montagnes ou de collines, lieux de résidence privilégiés par Wodan. C'est particulièrement patent dans le cas du Michelsberg près de Kleebronn en Allemagne. Avant que l'on ne parle de Wodan, c'est-à-dire avant la germanisation, il y avait déjà là un lieu de culte celtique. Wodan a tout simplement remplacé la divinité celtique et, après la christianisation, St. Michel a pris le relais. Wodan et St. Michel sont tous deux des détenteurs de lances miraculeuses. Tous deux tuent des dragons et servent de guide aux âmes. Les paysans de la région nomment toujours le Michelsberg de son ancien nom: Gudinsberg ou Wudinsberg, selon les variations dialectales.
L'ethnologue Gößler précise: «Cette persistance des cultes païens s'observe partout où il y a des monts ou collines portant le nom de Michel, surtout s'il s'agit de hauteurs occupées depuis la nuit des temps, comme, par exemple, sur le fameux Michelsberg près de Bruchsal, où l'on a découvert des poteries typiques de la préhistoire, poteries qui ont permis de déterminer la civilisation préhistorique indo-européenne du Michelsberg. Idem pour le Michelsberg près de Gundelsheim, le Heiligenberg de Heidelberg et le Michelsberg-en-Zabergäu».
L'histoire du Heiligenberg près de Heidelberg signale effectivement un passage direct de Wodan à St. Michel. Un acte de Konrad I, d'août 912, en parle comme d'une colline sainte, dédiée à un archange "tout-puissant". Or, pour l'église chrétienne, les archanges ne sont jamais "tout-puissants". Cet adjectif trahit la transposition...
St. Martin est aussi un avatar de Wodan. Souvent on le représente flanqué d'une oie, l'oiseau dont le sacrifice plaisait à Wodan. M. Ninck écrit: «La transposition des traits wotaniques a dû être facilitée par l'étymologie même du nom de Martin, signifiant en fait «guerrier de Mars». St. Martin est en effet Chevalier servant et, plus tard, un exorciste qui parcourt les campagnes. Sous sa forme chevaleresque, il porte un manteau, comme tous les chevaliers, mais le caractère particulièrement sacré de son manteau prouve nettement les origines wotaniques de son culte».
Les légendes prouvent, elles aussi, le rapport étroit qui existe entre Wodan et St. Martin. Dans la région de Coblence, l'homme qui blesse une cigogne (dans la symbolique païenne, animal qui équivaut au cygne, oiseau dédié à Wodan), est menacé de la Lance de St. Martin. En Bavière, lors des moissons des dernières semaines de l'été, les paysans laissent une gerbe pour le cheval de St. Martin, comme jadis ils en laissaient une pour le cheval de Wodan. Au Tyrol, la «Chasse Sauvage» s'appelle la Martinsgestämpe et l'on dit aussi que, derrière la Horde Sauvage, trotte une oie difforme, animal lié à St. Martin.
St. Martin est aussi magicien et sa fête, le 11 novembre, est célébrée à une époque de l'année où, jadis, on fêtait Wodan. Cette fête a repris à son compte bon nombre de traits du culte wotanique. Elle se célèbrait de nuit, avec des feux. On tuait des oies et l'on buvait la Minne de Wodan, comme on boit aujourd'hui la Minne de St. Martin.
Lors de la bénédiction des chiens à Vienne, célébration qui remonte au 10° siècle et est également une transposition d'un vieux rite wotanique, on évoque St. Martin comme patron protecteur des chiens (car Wodan, jadis, était accompagné de loups ou de chiens). A Bierdorf dans le Westerwald, se trouvent des tumuli germaniques, autour d'une colline nommée Martinsberg, jadis vouée à Wodan.
St. Oswald est sans doute aussi un avatar de Wodan, dont l'un des surnoms était précisément Oswald. Le passage du dieu païen au saint chrétien (?) est facilement repérable: une colonne de la nef principale de l'église abbatiale d'Alpirsbach dans le Württemberg nous montre encore Wodan accompagné de ses deux corbeaux Hugin et Munin. Une gravure sur bois datant de 1500 environ, nous présente, elle, St. Oswald avec deux corbeaux...
St. Cuthbert de Durham est représenté avec la tête tranchée d'Oswald: autour de lui, des cygnes, animaux wotaniques. Rappelons-nous que Wodan, dans l'Edda, enmenait toujours avec lui la tête tranchée de Mimir. Les cygnes sont, eux, inséparables des Walkyries, les vierges-pages de Wodan.
Mais l'avatar le plus aimé de Wodan est sans conteste St. Nicolas, qui offre des cadeaux aux enfants. Sa fête, le 6 décembre, n'a pratiquement rien à voir avec le saint historique, un évêque d'Asie Mineure. St. Nicolas est un saint qui a même réussi à résister au protestantisme dans le Nord des pays germaniques. Dans certains régions, il est assimilé à la vieille figure de Knecht Rupprecht (le «Gaillard Robert»), dans lequel on reconnaît sans difficulté Wodan. St. Nicolas porte souvent, comme lui, un bonnet de fourrure, une longue barbe soyeuse et il voyage dans un traîneau tiré par des rennes. Dans les régions catholiques, il est encore habillé comme un évêque, avec une mitre et une crosse et il accompagne Krampus, avatar du Diable.
L'Eglise chrétienne a donc pratiqué deux politiques à l'égard de Wodan: d'une part, elle a conservé son souvenir sous les oripeaux d'une quantité de saints; d'autre part, elle en a fait un diable et un méchant démon. Son surnom glorieux des temps païens, der Rabenase (L'Ase aux corbeaux), est devenu une injure, Rabenaas (carogne). Wodan est devenu le meneur de la terrible chasse sauvage, le seigneurs des démons. Dans quelques régions d'Allemagne, on brûle des effigies de Wode, Gode ou Gute lors du solstice d'été, devenu, sous l'impulsion de l'Eglise, les feux de la St. Jean. Mais Wodan, dans l'âme du peuple, a résisté à toutes les tentatives de christianisation.
Otto Rudolf BRAUN.
(Source: Germanische Götter - Christliche Heilige. Über den Kampf der Christen gegen das germanische Heidentum, Verlag Hohe Warte, Pähl/Obb., 1979; adaptation française: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, scandinavie, mythologie, christianisme, germanisme, nord, nordisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 13 août 2008
Intervista a Julius Evola (La Nation européenne, 1967)
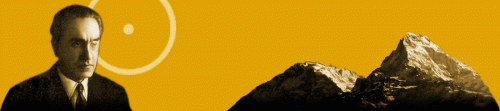 |
| Un pessimismo giustificato? Intervista a Julius Evola di Franco Rosati Lei crede che esista un rapporto tra la filosofia e la politica? Una filosofia può influire su un'impresa di ricostruzione politica nazionale o europea? Io non credo che una filosofia intesa in senso strettamente teorico possa influire sulla politica. Perché eserciti un'influenza, bisogna che essa si incarni in un'ideologia o in una concezione del mondo. E' quanto è avvenuto, per esempio, con l'illuminismo, col materialismo dialettico marxista e con certe concezioni filosofiche che erano incorporate nella concezione del mondo del nazionalsocialismo tedesco. In generale, l'epoca dei grandi sistemi filosofici è terminata; non esistono più che filosofie bastarde e mediocri. A una delle mie opere passate, del mio periodo filosofico, io avevo posto in esergo queste parole di Jules Lachelier: "La filosofia (moderna) è una riflessione che ha finito per riconoscere la propria impotenza e la necessità di un'azione che parta dall'interno" (nota 1). Il dominio proprio di un'azione di questo tipo ha un carattere metafilosofico. Di qui, la transizione che si osserva nei miei libri, i quali non parlano di "filosofia", ma di "metafisica", di visione del mondo e di dottrine tradizionali. Lei pensa che morale ed etica siano sinonimi e che debbano avere un fondamento filosofico? E' possibile stabilire una distinzione, se per "morale" si intende propriamente il costume e per "etica" una disciplina filosofica (quella che viene chiamata la "filosofia morale"). A mio parere, qualunque etica o qualunque morale voglia avere un fondamento filosofico di carattere assoluto, è illusoria. Senza riferimento a qualcosa di trascendente, la morale non può avere che una portata relativa, contingente, "sociale" e non può resistere ad una critica dell'individualismo, dell'esistenzialismo o del nichilismo. Lo ho dimostrato nel mio libro Cavalcare la tigre, nel capitolo intitolato Nel mondo dove Dio è morto. In questo capitolo ho anche affrontato la problematica posta da Nietzsche e dall'esistenzialismo. Lei crede che l'influenza del Cristianesimo sia stata positiva per la civiltà europea? Non pensa che l'aver adottato una religione d'origine semitica abbia snaturato certi valori europei tradizionali? Parlando di Cristianesimo, ho spesso usato l'espressione "la religione che è venuta a prevalere in Occidente". Infatti il più grande miracolo del Cristianesimo è di essere riuscito ad affermarsi tra i popoli europei, anche tenendo conto della decadenza in cui erano piombate numerose tradizioni di questi popoli. Tuttavia non bisogna dimenticare i casi in cui la cristianizzazione dell'Occidente è stata soltanto esteriore. Inoltre, se il Cristianesimo ha, senza alcun dubbio, alterato certi valori europei, vi sono anche dei casi in cui questi valori sono risorti dal Cristianesimo rettificandolo e modificandolo. Altrimenti il cattolicesimo sarebbe inconcepibile nei suoi diversi aspetti "romani"; allo stesso modo sarebbe inconcepibile una parte della civiltà medioevale con fenomeni quali l'apparizione dei grandi ordini cavallereschi, del tomismo, una certa mistica di alto rango (per esempio Meister Eckhart), lo spirito della Crociata ecc. Lei pensa che il conflitto tra guelfi e ghibellini nel corso della storia europea sia qualcosa di più che non un semplice episodio politico e costituisca un conflitto tra due diversi tipi di spiritualità? Ritiene possibile una recrudescenza del "ghibellinismo"? L'idea che alle origini della lotta tra l'Impero e la Chiesa non vi sia stata soltanto una rivalità politica, ma che questa lotta traducesse l'antinomia di due diversi tipi di spiritualità, questa idea costituisce il tema centrale del mio libro Il mistero del Graal e la tradizione ghibellina dell'Impero. Questo libro è stato edito in tedesco e uscirà presto anche in francese. In fondo, il "ghibellinismo" attribuiva all'autorità imperiale un fondamento di carattere soprannaturale e trascendente quanto quello che la Chiesa pretendeva di essere la sola a possedere (Dante stesso difende in parte la medesima tesi). Così certi teologi ghibellini poterono parlare di "religione regale" e, in particolare, attribuire un carattere sacro ai discendenti degli Hohenstaufen. Beninteso, l'Impero cristallizzava un tipo di spiritualità che non poteva essere identificato con la spiritualità cristiana. Ma se questi sono i dati del conflitto guelfi-ghibellini, è chiaro, allora, che una resurrezione del "ghibellinismo" alla nostra epoca e molto problematica. Dove trovare, infatti, i "riferimenti superiori" per opporsi alla Chiesa, se ciò non avviene in nome di uno Stato laico, secolarizzato, "democratico" o "sociale", sprovvisto di ogni concezione dell'autorità proveniente dall'alto? Già il "Los von Rom" e il "Kulturkampf" del tempo di Bismarck avevano soltanto un carattere politico, per non parlare delle aberrazioni e del dilettantismo di un certo neopaganesimo. Nel suo libro Il Cammino del Cinabro, dove è esposta la genesi delle sue opere, lei ammette che il principale difensore contemporaneo della concezione tradizionale, René Guénon, ha esercitato una certa influenza su di lei, al punto che la hanno definita "il Guénon italiano". Esiste una corrispondenza perfetta tra il suo pensiero e quello di Guénon? E non crede, a proposito di Guénon, che certi ambienti sopravvalutino la filosofia orientale? Il mio orientamento non differisce da quello di Guénon per quanto concerne il valore da attribuire al Mondo della Tradizione. Per Mondo della Tradizione bisogna intendere una civiltà organica e gerarchica in cui tutte le attività sono orientate dall'alto e verso l'alto e sono improntate a valori che non sono semplicemente valori umani. Come Guénon, io ho scritto diverse opere sulla sapienza tradizionale, studiandone direttamente le fonti. La prima parte della mia opera principale Rivolta contro il mondo moderno è appunto una "Morfologia del Mondo della Tradizione". Vi è anche corrispondenza tra Guénon e me per quanto concerne la critica radicale del mondo moderno. Su questo punto vi sono tuttavia delle divergenze minori tra lui e me. Data la sua "equazione personale", nella spiritualità tradizionale Guénon ha assegnato alla "conoscenza" e alla "contemplazione" il primato sull'azione; egli ha subordinato la regalità al sacerdozio. Io, invece, mi sono sforzato di presentare e di valorizzare l'eredità tradizionale dal punto di vista di una spiritualità da "casta guerriera" e di mostrare le possibilità parimenti offerte dalla "via dell'azione". Una conseguenza di questi punti di vista differenti è che, se Guénon assume come base per una eventuale ricostruzione tradizionale dell'Europa una élite intellectuelle, io, per quanto mi concerne, sono piuttosto incline a parlare di un ordine. Divergono anche i giudizi che Guénon ed io diamo del Cattolicesimo e della Massoneria. Credo tuttavia che la formula di Guénon non si situi nella linea dell'uomo occidentale, il quale è malgrado tutto, per sua natura, orientato specialmente verso l'azione. Non si può qui parlare di "filosofia orientale"; si tratta piuttosto di modalità di pensiero orientali facenti parte di un sapere tradizionale che, anche in Oriente, si è conservato più integro e più puro ed ha preso il posto della religione, ma era parimenti diffuso nell'Occidente premoderno. Se queste modalità di pensiero valorizzano ciò che ha un contenuto universale metafisico, non si può dire che vengano sopravvalutate. Quando si tratta di concezione del mondo, bisogna guardarsi dalle semplificazioni superficiali. L'Oriente non comprende solo l'India del Vêdanta, della dottrina della Mâyâ e della contemplazione distaccata dal mondo; esso comprende anche l'India che, con la Bhagavad Gîtâ, ha dato una giustificazione sacrale alla guerra e al dovere del guerriero; comprende anche la concezione dualista e combattiva della Persia antica, la concezione imperiale cosmocratica dell'antica Cina, la civiltà giapponese, la quale è così lontana dall'essere unicamente contemplativa e introversa, che in Giappone una frazione esoterica del buddhismo ha potuto dar nascita alla "filosofia dei Samurai" ecc. Sfortunatamente, ciò che caratterizza il mondo europeo moderno non è l'azione, ma la sua contraffazione, vale a dire un attivismo privo di fondamento, che si limita al dominio delle realizzazioni puramente materiali. "Si sono distaccati dal cielo col pretesto di conquistare la terra", fino a non sapere più che cosa sia veramente l'azione. Il suo giudizio sulla scienza e sulla tecnica sembra, nella sua opera, negativo. Quali sono le ragioni della sua posizione? Non crede che le conquiste materiali e l'eliminazione della fame e della miseria permetteranno di affrontare con più energia i problemi spirituali? Per quanto riguarda il secondo punto da lei sollevato, dirò che, come esiste uno stato di abbrutimento dovuto alla miseria, così esiste uno stato di abbrutimento dovuto al benessere e alla prosperità. Le "società del benessere", nelle quali non si può più parlare di fame e di miseria, sono lungi dall'ingenerare un aumento della vera spiritualità; anzi, vi si constata una forma violenta e distruttiva di rivolta delle nuove generazioni contro il sistema nel suo insieme e contro un'esistenza sprovvista di ogni significato (USA-Inghilterra-Scandinavia). Il problema consiste piuttosto nel fissare un giusto limite, frenando la frenesia di un'economia capitalista creatrice di bisogni artificiali e liberando l'individuo dalla sua crescente dipendenza dall'ingranaggio sociale e produttivo. Bisognerebbe stabilire un equilibrio. Fino a poco tempo fa, il Giappone aveva dato l'esempio di un equilibrio di questo tipo; si era modernizzato e non si era lasciato distanziare dall'Occidente nei domini scientifico e tecnico, pur salvaguardando le sue tradizioni specifiche. Ma oggi la situazione è ben diversa. C'è un altro punto fondamentale da sottolineare: è difficile adottare la scienza e la tecnica circoscrivendole entro i limiti di mezzi materiali e di strumenti di una civiltà, vale a dire mantenendo, nei lori riguardi, una certa distanza; al contrario, è praticamente inevitabile che ci si impregni della concezione del mondo su cui si basa la moderna scienza profana, concezione che viene praticamente inculcata nei nostri spiriti dai metodi di istruzione abituali e che ha, sul piano spirituale, un effetto distruttivo. Il concetto stesso della vera conoscenza viene così ad essere totalmente falsato. Si è anche parlato del suo "razzismo spirituale". Qual è il significato esatto di questa espressione? Nella mia fase precedente, ho pensato bene di formulare una dottrina della razza che avrebbe impedito al razzismo tedesco e italiano di andare a finire in una sorta di "materialismo biologico". Il mio punto di partenza è stato la concezione dell'uomo come essere costituito di corpo, di anima e di spirito, con il primato della parte spirituale sulla parte corporea. Il problema della razza doveva dunque porsi per ciascuno di questi tre elementi. Di qui la possibilità di parlare di una razza dello spirito e dell'anima, oltre alla razza biologica. L'opportunità di questa formulazione risiede nel fatto che una razza può degenerare, anche restando biologicamente pura, se la parte interiore e spirituale è morta, diminuita o obnubilata, se ha perso la propria forza (come presso certi tipi nordici attuali). Inoltre gl'incroci, di cui oggi pochissime stirpi sono esenti, possono avere come conseguenza che ad un corpo di una data razza siano legati, in un individuo, il carattere e l'orientamento spirituale propri di un'altra razza, donde una più complessa concezione del meticciato. La "razza interiore" si manifesta attraverso il modo d'essere, attraverso un comportamento specifico, attraverso il carattere, per non parlare della maniera di concepire la realtà spirituale (i diversi tipi di religioni, di etiche, di visioni del mondo ecc. possono esprimere "razze interiori" ben distinte). Questo punto di vista consente di superare molte concezioni unilaterali e di allargare il campo delle ricerche. Per esempio, il giudaismo si definisce soprattutto nei termini di una "razza dell'anima" (di una condotta) unica, osservabile in individui che, dal punto di vista della razza del corpo, sono assai diversi. D'altra parte, per dirsi "ariani" nel senso completo della parola non è necessario non avere la minima goccia di sangue ebraico o di una razza di colore; bisognerebbe innanzitutto esaminare qual è la vera "razza interiore", ossia l'insieme di qualità che in origine corrispondevano all'ideale dell'uomo ario. Ho avuto occasione di dichiarare che, ai giorni nostri, non si dovrebbe insistere troppo sul problema ebraico; infatti, le qualità che dominavano e dominano oggi in diversi tipi di ebrei sono evidentissime in tipi "ariani", senza che per questi ultimi si possa invocare come attenuante la minima circostanza ereditaria. Nella storia d'Europa, vi sono stati diversi tentativi di formare un "Impero europeo": Carlo Magno, Federico I e Federico II, Carlo V, Napoleone, Hitler, ma nessuno è riuscito a rifare, in maniera stabile, l'Impero di Roma. Quali sono state, secondo lei, le cause di questi fallimenti? Pensa che oggi la costruzione di un Impero europeo sia possibile? Se no, quali sono le ragioni del suo pessimismo? Per rispondere, sia pure in maniera sommaria, a questa domanda, bisognerebbe poter disporre di uno spazio ben più grande che non quello di un'intervista. Mi limiterò a dire che gli ostacoli principali, nel caso del Sacro Romano Impero, sono stati l'opposizione della Chiesa, gl'inizi della rivolta del Terzo Stato (come nel caso dei Comuni), la nascita di Stati nazionali centralizzati che non ammettevano alcuna autorità superiore e, infine, la politica non imperiale ma imperialista della dinastia francese. Io non attribuirei, al tentativo di Napoleone, un vero carattere imperiale. Malgrado tutto, Napoleone è stato l'esportatore delle idee della Rivoluzione Francese, idee che sono state utilizzate contro l'Europa dinastica e tradizionale. Per quanto riguarda Hitler, bisognerebbe fare delle riserve nella misura in cui la sua concezione dell'Impero era fondata sul mito del Popolo (Volk = Popolo-razza), concezione che rivestiva un aspetto di collettivizzazione e di esclusivismo nazionalista (etnocentrismo). Fu solo nell'ultimo periodo del Terzo Reich che le vedute si allargarono, da una parte grazie all'idea di un Ordine, difesa da certi ambienti della SS, dall'altra grazie all'unità internazionale delle divisioni europee di volontari che si battevano sul fronte dell'Est. Per contro, non bisognerebbe dimenticare il principio di un Ordine europeo che è esistito con la Santa Alleanza (il cui declino fu imputabile in gran parte all'Inghilterra) e anche con il progetto chiamato Drei Kaiserbund, al tempo di Bismarck: la linea difensiva dei tre imperatori che avrebbe dovuto inglobare anche l'Italia (con la Triplice Alleanza) e il Vaticano e opporsi alle manovre antieuropee dell'Inghilterra e della stessa America. Un "Reich Europa", non una "Nazione Europa", sarebbe l'unica formula accettabile dal punto di vista tradizionale per la realizzazione di una unificazione autentica ed organica dell'Europa. Quanto alla possibilità di realizzare l'unità europea in questo modo, non posso non essere pessimista per le stesse ragioni che mi hanno indotto a dire che oggi c'è poco spazio per una rinascita del "ghibellinismo": non c'è un punto di riferimento superiore, non c'è un fondamento per dare saldezza e legittimità a un principio d'autorità sopranazionale. Non si può infatti trascurare questo punto fondamentale e accontentarsi di fare appello alla "solidarietà attiva" degli Europei contro le potenze antieuropee, passando sopra ad ogni divergenza ideologica. Anche quando si giungesse, con questo metodo pragmatico, a fare dell'Europa una unità, ci sarebbe sempre il pericolo di veder nascere, in questa Europa, nuove contraddizioni disgregatrici, in particolare per quanto concerne le divergenze ideologiche e per effetto della mancanza di un principio, posto come primordiale, di un'autorità superiore. "Comunità di destino" ha valore solo come parola d'ordine di carattere pratico. Oggi è difficile parlare di "comune cultura europea": la cultura moderna non conosce frontiere; l'Europa importa ed esporta "beni culturali"; non solo nel dominio della cultura, ma anche nel dominio del gusto, nel modo di vivere, si manifesta sempre più un livellamento generale che, coniugato con il livellamento prodotto dalla scienza e dalla tecnica, fornisce argomenti non a coloro che vogliono un'Europa unitaria, ma piuttosto a coloro che vorrebbero edificare uno Stato mondiale. Di nuovo, ci scontriamo con l'ostacolo costituito dall'inesistenza di una vera idea superiore differenziatrice, che dovrebbe essere il nucleo dell'Impero europeo. Al di là di tutto, il clima generale è sfavorevole: lo stato spirituale di devozione, di eroismo, di fedeltà, di onore nell'unità, che dovrebbe servire da cemento al sistema organico di un Ordine europeo imperiale è oggi, per così dire, inesistente. Il primo compito da eseguire dovrebbe essere una purificazione sistematica degli spiriti, antidemocratica e antimarxista, nelle nazioni europee. In seguito, bisognerebbe potere scuotere le grandi masse dei nostri popoli con mezzi diversi, sia facendo appello agli interessi materiali, sia con un'azione a carattere demagogico e fanatico che, necessariamente, solleciterebbe lo strato subpersonale e irrazionale dell'uomo. Questi mezzi implicherebbero fatalmente certi rischi. Ma tutti questi problemi non possono essere tratti in poche parole; d'altronde, ho avuto modo di parlarne in uno dei miei libri, Gli uomini e le rovine. Note 1. Per una svista, Evola attribuisce a Jules Lachelier la frase di Lagneau che egli aveva preposta a mo' di epigrafe al primo dei suoi Saggi sull'Idealismo Magico (Atanòr, Todi-Roma 1925): "La philosophie, c'est la réflexion aboutissant à reconnaître sa propre insuffisance et la nécessité d'une action absolue partant du dedans" (J. Lagneau, Rev. de Mét. et de Mor., mars 1898, p. 127). L'intervista che traduciamo qui di seguito apparve originariamente in francese, sui nn. 13 (15 dicembre 1966 - 15 gennaio 1967) e 14 (15 febbraio - 15 marzo 1967) del mensile "La Nation Européenne" (Parigi). Il periodico, diretto da Gérard Bordes, aveva come "conseiller politique" Jean Thiriart, che l'aveva fondato tra il 1965 e il 1966, e contava su una rete paneuropea di collaboratori. L'intervista, realizzata da Franco Rosati, era accompagnata da una foto e da una bibliografia francese della produzione evoliana ed era preceduta da una breve presentazione in cui, nonostante Evola venisse definito "uno dei più grandi pensatori europei (...) un caposcuola, un maestro", si prendevano le distanze nei confronti della sua "sfiducia verso l'avvenire unitario dell'Europa". Al testo dell'intervista seguiva, sul n. 14, una nota redazionale che esprimeva in termini chiarissimi la divergenza esistente fra il tradizionalismo di Evola e il pragmatismo di Thiriart. Infatti vi si leggeva tra l'altro: "La 'Tradizione', certo, è rispettabile. Vogliamo anzi ammettere che noi attingiamo da essa un certo modo di vedere il mondo e un certo metodo di azione. Ma non possiamo accettare di fare di questa 'Tradizione' un nuovo 'senso della storia' e ancor meno una Bibbia in cui è racchiuso tutto. Per noi, la verità si costruisce ogni giorno attraverso metodi e vie diverse. (...) La verità non è posta fin da principio come un faro che rischiara la via. Noi pensiamo piuttosto che, alla fine, la lenta e difficile scoperta della verità nasca, il più delle volte, dall'azione e grazie all'azione". Claudio Mutti |
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretiens, italie, europe, julius evola, traditions, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 10 août 2008
Il simbolismo degli scacchi
Il simbolismo degli scacchi
di Titus Burckhardt
Il simbolismo degli scacchi
Il gioco degli scacchi, come è noto, è originario dell’India. L’Occidente medievale lo ha conosciuto grazie alla mediazione dei Persiani e degli Arabi, come testimonia fra l’altro l’espressione “scacco matto” (in tedesco: Schachmatt) derivante dal persiano shah (re) e dall’arabo mat (è morto). Nel Rinascimento furono cambiate alcune regole del gioco: la regina e i due alfieri (erano in origine elefanti che trasportavano una torre fortificata) acquistarono maggiore mobilità; il gioco divenne più astratto e matematico, e si allontanò dal suo modello concreto (la strategia) senza comunque perdere i tratti essenziali del suo simbolismo.
Nella posizione iniziale dei pezzi, l’antico modello strategico resta evidente; vi si riconoscono le due armate disposte nell’ordine di battaglia in uso presso gli eserciti dell’antico Oriente: le truppe leggere, rappresentate dai pedoni, formano la prima linea, mentre il grosso dell’armata è costituito dalle truppe pesanti, i carri da guerra (le torri), i cavalieri (i cavalli) e gli elefanti da combattimento (gli alfieri); il re e la sua dama - o il suo “consigliere” - si tengono al centro delle truppe. La forma della scacchiera corrisponde al tipo “classico” del Vastu-mandala, il diagramma che costituisce anche il tracciato fondamentale di un tempio o di una città. Tale diagramma è simbolo dell’esistenza, concepita come un “campo d’azione” delle potenze divine. Il combattimento rappresentato dal gioco degli scacchi è dunque figura, nel suo significato più universale, del combattimento dei devas con gli asuras, degli “dei” con i “titani”, o degli “angeli” (i devas della mitologia indù sono infatti analoghi agli angeli delle tradizioni monoteiste) coi “demoni”: tutti gli altri significati del gioco derivano da questo.
La più antica descrizione del gioco degli scacchi che sia giunta fino a noi si trova nelle “Praterie d’Oro” dello storico arabo al-Mas’udi, vissuto a Baghdad nel IX secolo. Al-Mas’udi attribuisce l’invenzione, o la codificazione, del gioco ad un re indù chiamato “Balhit”, discendente di “Barahman”. Vi è qui una confusione evidente fra una casta, quella dei Brahmani, ed una dinastia; ma l’origine brahmanica del gioco degli scacchi è dimostrata dal carattere eminentemente sacerdotale del diagramma a 8 x 8 quadrati (ashtapada). D’altronde, il simbolismo guerriero del gioco si rivolge agli Kshatriyas, la casta dei principi e dei nobili, come del resto è indicato da al-Mas’udi quando egli scrive che gli Indù consideravano il gioco degli scacchi (shatranj) come una “scuola di governo e di difesa”. Il re Balhit avrebbe scritto un libro su questo gioco, di cui “fece una sorta di allegoria dei corpi celesti, come i pianeti e i dodici segni zodiacali, dedicando ogni pedina ad un astro.”. Notiamo che gli Indù contano otto pianeti: il sole, la luna, i cinque pianeti visibili ad occhio nudo e Rahu, l’”astro oscuro” delle eclissi; ognuno di questi “pianeti” domina una delle otto direzioni dello spazio. Continua al-Mas’udi: “Gli Indiani attribuiscono un misterioso significato alla progressione geometrica effettuata sulle caselle della scacchiera; essi stabiliscono un rapporto fra la causa prima, che domina tutte le sfere ed a cui tutto fa capo, e la somma del quadrato delle caselle della scacchiera.”. Qui, l’autore confonde probabilmente il simbolismo ciclico implicito nell’ashtapada con la famosa leggenda secondo la quale l’inventore del gioco chiese al monarca di riempire le caselle della sua scacchiera con dei chicchi di grano, ponendo un solo chicco sulla prima casella, due sulla casella successiva, quattro sulla terza e così via, fino alla 64° casella, ottenendo così un totale di 18446744073709551616 chicchi. Il simbolismo ciclico della scacchiera consiste nel fatto che essa esprime lo sviluppo dello spazio secondo il quaternario e l’ottonario delle direzioni principali (4×4x4=8×8), e che sintetizza, sotto forma “cristallina”, i due grandi cicli complementari del sole e della luna: il duodenario dello Zodiaco e le 28 case lunari; d’altra parte, il numero 64, somma delle caselle della scacchiera, è un sottomultiplo del numero ciclico fondamentale 25920, che misura la processione degli equinozi. Abbiamo visto che ciascuna fase di un ciclo, “fissata” nello schema di 8×8 quadrati, è dominata da un astro e simboleggia al contempo un aspetto divino personificato da un deva (certi testi buddhisti descrivono l’universo come una tavola di 8×8 riquadri, fissati per mezzo di corde d’oro; questi riquadri corrispondono ai 64 kalpas del Buddhismo. Nel Ramayana, la città inespugnabile degli dei, Ayodhya, è descritta come un quadrante avente otto comparti su ciascun lato. Nelle Tradizione cinese, i 64 segni derivanti dagli 8 trigrammi commentati nell’I-King. Questi 64 segni sono generalmente disposti in maniera tale che corrispondono alle otto regioni dello spazio). In tal modo questo mandala rappresenta contemporaneamente il cosmo visibile, il mondo dello Spirito e la Divinità nei suoi molteplici aspetti.
Al-Mas’udi afferma dunque con ragione che gli Indiani spiegano “con dei calcoli” basati sulla scacchiera “il cammino del tempo ed i cicli, le influenze superiori che agiscono su questo mondo ed i legami che le collegano con l’anima umana.”. Il simbolismo ciclico della scacchiera era noto ad Alfonso il Saggio, il celebre trovatore di Castiglia che compose nel 1283 i suoi Libros de Acedrex, opera che s’ispira in gran parte alle fonti orientali. Alfonso il Saggio descrive anche un’antichissima variante del gioco degli scacchi (il “gioco delle quattro stagioni”) che richiede quattro giocatori, così che le pedine, disposte ai quattro angoli della scacchiera, avanzino in un senso rotatorio analogo al movimento del sole. Le 4×8 pedine devono essere di colore verde, rosso, nero e bianco; esse corrispondono ai quattro elementi: aria, fuoco, terra ed acqua, ed ai quattro “umori” organici. Il movimento dei quattro gruppi simboleggia la trasformazione ciclica.
Questo gioco, che richiama stranamente certi riti e certe danze “solari” degli Indiani dell’America settentrionale, mette in evidenza il principio fondamentale della scacchiera. La scacchiera può essere considerata come uno sviluppo di uno schema composto da quattro quadrati alternativamente neri e bianchi, e costituisce di per sé un mandala di Shiva, Dio nel suo aspetto di “trasformatore”: il ritmo quaternario, di cui questo mandala è come la “cristallizzazione” spaziale, esprime il principio del tempo. I quattro quadrati, disposti intorno ad un centro non manifestato, simboleggiano le fasi cardinali di ogni ciclo. L’alternanza delle caselle bianche e nere, in questo schema elementare della scacchiera, ne evidenzia il significato ciclico e ne fa l’equivalente rettangolare del simbolo estremo orientale del yin-yang; essa è un’immagine del mondo visto sotto l’aspetto del suo dualismo intrinseco. Se il mondo sensibile, nel suo dispiegamento integrale, risulta in qualche modo dalla moltiplicazione delle qualità inerenti allo spazio e di quelle del tempo , il Vastu-mandala, dal canto suo, deriva dalla divisione del tempo secondo lo spazio: ricordiamo a questo proposito la genesi del Vastu-mandala a partire dal ciclo celeste indefinito, ciclo diviso dagli assi cardinali e poi “cristallizzato” in una forma rettangolare. Il mandala è dunque il riflesso inverso della sintesi principale dello spazio e del tempo, ed è in ciò che risiede la sua portata ontologica.
D’altra parte, il mondo è “intessuto” delle tre qualità fondamentali o gunas, e il mandala rappresenta questa “tessitura” in modo schematico, conformemente alle direzioni cardinali dello spazio. L’analogia tra il Vastu-mandala e la tessitura è evidenziata dall’alternanza dei colori, che ricorda un tessuto il cui ordito e la cui trama sono alternativamente apparenti o nascosti. L’alternanza del bianco e del nero corrisponde d’altro canto ai due aspetti, in linea di principio complementari ma in pratica opposti, del mandala: questo è da una parte un Purusha-mandala, cioè un simbolo dello Spirito universale (Purusha) in quanto sintesi immutabile e trascendente del cosmo; d’altra parte, esso è un simbolo dell’esistenza (Vastu) considerata come il supporto passivo delle manifestazioni divine. La qualità geometrica del simbolo esprime lo Spirito; la sua estensione puramente quantitativa esprime l’esistenza. Del pari, la sua immutabilità ideale è “spirito”, la sua fissazione limitativa è “esistenza” o materia; nella polarità considerata, quest’ultima non è la materia prima, vergine e generosa, ma la materia secunda tenebrosa e caotica, radice del dualismo esistenziale. Ricordiamo a questo proposito il mito secondo cui il Vastu-mandala rappresenterebbe un asura, personificazione dell’esistenza bruta: i devas hanno sconfitto questo demone, stabilendo le loro “dimore” sul corpo disteso della loro vittima; essi gli imprimono così la loro “forma”, ma è lui che li manifesta (il mandala di 8×8 quadrati è anche detto Manduka, la “rana”, per allusione alla Grande Rana che sostiene tutto l’universo ed è il simbolo della materia indifferenziata e oscura).
Questo doppio senso che caratterizza il Vastu-Purusha-mandala, e che si ritrova, d’altronde, in modo più o meno esplicito, in ogni simbolo, verrà per così dire “attualizzato” dal combattimento che il gioco degli scacchi rappresenta. Questo combattimento, dicevamo, è essenzialmente il conflitto fra devas e asuras, che si disputano la scacchiera del mondo. E’ qui che il simbolismo del bianco e del nero, già contenuto nell’alternanza delle caselle della scacchiera, acquista tutto il suo valore: l’armata bianca è quella della Luce, l’armata nera è quella delle tenebre. Da un punto di vista relativo, la battaglia raffigurata sulla scacchiera rappresenta sia quella di due veri e propri eserciti terreni, ciascuno dei quali combatte in nome di un principio, sia quella dello spirito e delle tenebre nell’uomo (in una guerra santa, è possibile che ciascuno dei due avversari possa legittimamente considerarsi il protagonista della lotta della Luce contro le tenebre. E’ questa un’altra conseguenza del duplice senso di ogni simbolo: quello che per l’uno è espressione dello Spirito, può essere l’immagine della materia tenebrosa agli occhi dell’altro). Sono, queste, le due “guerre sante”: la “piccola guerra santa” e la “grande guerra santa”, secondo un’espressione del Profeta. E’ da notare l’affinità fra il simbolismo del gioco degli scacchi ed il tema della Bhagavad-Gita, il libro parimenti rivolto agli Kshatriyas. Se si traspone il significato dei diversi pezzi del gioco nell’ordine spirituale, il re sarà il cuore o lo spirito e le altre figure saranno le diverse facoltà dell’anima. Le loro mosse corrispondono d’altronde a differenti modalità di realizzazione delle possibilità cosmiche rappresentate dalla scacchiera: vi è il movimento assiale delle “torri” o carri da guerra, il movimento diagonale degli “alfieri” o elefanti, che si spostano su caselle di uno stesso colore, ed il complesso movimento dei cavalieri. Il movimento assiale, che “taglia” attraverso i diversi “colori”, è logico e virile, mentre il movimento diagonale corrisponde ad una continuità “esistenziale”, perciò femminile. Il salto dei cavalieri corrisponde all’intuizione.
Ciò che più affascina l’uomo di casta nobile e guerriera, è la relazione fra volontà e destino. Ora, il gioco degli scacchi illustra proprio questa relazione, in quanto i suoi concatenamenti restano sempre intelligibili senza essere limitati nella loro varietà. Alfonso il Saggio, nel suo libro sul gioco degli scacchi, racconta che un re dell’India volle sapere se il mondo obbedisce all’intelligenza o al caso. Due saggi, suoi consiglieri, fornirono risposte contrastanti e, per provare le rispettive tesi, uno di loro prese come esempio il gioco degli scacchi, in cui l’intelligenza prevale sul caso, mentre l’altro portò dei dadi, immagine della fatalità. Del pari, al Mas’udi scrive che il re “Balhit”, il quale avrebbe codificato il gioco degli scacchi, preferì quest’ultimo al nerd, un gioco d’azzardo, poiché nel primo “l’intelligenza trionfa sempre sull’ignoranza”. Ad ogni fase del gioco, il giocatore è libero di scegliere fra varie possibilità; ma ogni mossa comporterà una serie di conseguenze ineluttabili: la necessità delimiterà vieppiù la libera scelta, facendo sì che il termine del gioco non rappresenti il frutto del caso, bensì il risultato di leggi rigorose. E’ qui che si rivela non soltanto la relazione fra volontà e destino, ma anche fra libertà e conoscenza: prescindendo da eventuali inaccortezze dell’avversario, il giocatore manterrà la propria libertà d’azione nella misura in cui le sue dimensioni coincideranno con la natura stessa del gioco, ovvero con le possibilità che questo implica. In altri termini, la libertà d’azione va in questo caso di pari passo con la preveggenza e con la conoscenza delle possibilità; l’impulso cieco, di contro, per quanto possa apparire libero e spontaneo in un primo momento, si rivela a conti fatti come una non-libertà. L’ “arte regia” sta nel governare il mondo (esteriore o interiore) in conformità con le leggi che gli sono proprie. Questa arte presuppone la sapienza, che è conoscenza delle possibilità; ora, tutte le possibilità sono contenute in sintesi nello Spirito universale e divino. La vera sapienza è l’identificazione più o meno perfetta con lo Spirito (Purusha), simboleggiato dalla qualità geometrica della scacchiera (lo Spirito o il Verbo è la “forma delle forme”, vale a dire il principio formale dell’universo), “sigillo” dell’unità essenziale delle possibilità cosmiche. Lo Spirito è la Verità: nella Verità l’uomo è libero, fuori di essa è schiavo del destino. Questo è l’insegnamento del gioco degli scacchi. Lo Kshatriya che ad esso si dedica non vi trova solo un passatempo, un modo di sublimare la sua passione guerriera e la sua sete d’avventura, ma anche (in proporzione alla sua capacità intellettuale) un supporto speculativo, una via che dall’azione porta verso la contemplazione.
Titus Burckhardt
00:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, symbolisme, échecs |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 08 août 2008
Le Livre celtique des jours...
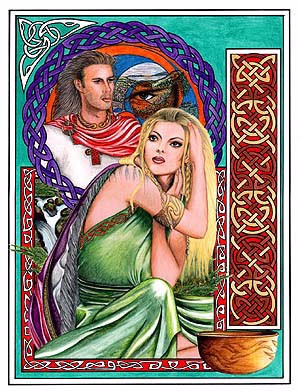
Le Livre celtique des jours...
Analyse: Caitlín MATTHEWS, The Celtic Book of Days. A Celebration of Celtic Wisdom, Godsfield Press Ltd, New Alresford, 1995, 128 p. (format: 233 mm x 210 mm), nombreuses ill., ISBN 1-899434-10-0.
Dans cet ouvrage richement illustré, Caitlín Matthews nous offre un livre familial, destiné à être lu jour après jour, à accompagner la maisonnée tout au long du cycle cosmique qui se répète chaque année. Elle explique la fascination récente pour l'héritage mythologique et cosmogonique celtique par la présence dans ces traditions d'un cycle annuel bien clair. La succession des rythmes saisonniers (samhain, imbolc, beltane et lughnasadh) est ponctuée par des fêtes et des célébrations qui sont autant de moyens de découvrir et sa propre personnalité et une spiritualité transpersonnelle, indiquant à la personne sa localisation transindividuelle.
Nous sommes hommes et personnes, nous avons notre spécificité inaliénable, certes, mais nous n'en sommes pas moins imbriqués dans les cycles de la planète Terre qui échappent à notre contrôle, nous sommes nourris par ses éléments, par les végétaux et les animaux qui y poussent, y croissent ou y gambadent. Suivre un cycle cosmique à travers le jeu de célébrations cultuelles, c'est apprendre chaque jour une leçon, entrevoir directement ce que sont les rythmes de la Terre , découvrir l'immense et inextricable réseau qu'est la vie, avec sa multiplicité inépuisable, irréductible à des schémas unitaires ou simplificateurs. Chacune des grandes fêtes celtiques (samhain, imbolc, beltane et lughnasadh) sont des “portes” initiatiques qui introduisent à une même réalité tout à la fois identique et mouvante, affichant des facettes changeantes de couleurs, de lumières et d'obscurité, qui finiront par retrouver les tons et tonalités qu'elles viennent de perdre, par l'effet d'un éternel retour, d'un cycle cosmique, fondement inamovible du réel.
Ainsi, la fête du samhain est une période qui débute quand les travaux agricoles ont cessé, que les mesures pratiques de la communauté pour affronter l'hiver ont été prises: c'est alors que cette communauté recommunique avec ses ancêtres disparus et s'adonne à l'introspection; la fête d'imbolc célèbre les émergences, les bourgeonnements, l'innocence primale; la fête de beltane inaugure la période de créativité et de forte expression; la fête de la lughnasadh exprime la maturité et la consolidation des acquis. Numineusement parlant, chacune de ses facettes du réel tellurique n'est-elle pas marquée par des rythmes et des forces différentes, que l'on honore par des fêtes et cultes différents, rendant hommage à des forces, tantôt ascendantes tantôt déclinantes? Vouloir ne célébrer que telle ou telle fête, la maturité plutôt que l'introspection, le bourgeonnement plutôt que la forte expression, etc. est une mutilation de la personnalité qui, quoi qu'on fasse, a toujours été et l'une et l'autre à un moment de son existence et deviendra et l'une ou l'autre dans le futur.
Caitlín Matthews explique les raisons qui l'ont poussée à rédiger et à recomposer cet almanach celtique (plutôt celtique-insulaire) des jours et des semaines: «Les facteurs [naturels] qui nous relient à nos ancêtres celtiques sont les territoires sur lesquels ils ont vécu et qui nous donnent notre sens du lieu; ce sont les traditions qu'ils ont pratiquées qui nous donnent aussi notre sens du lieu; et puis, il y a les saisons qui nous relient à eux au-delà de fort nombreuses strates temporelles. Pour beaucoup de gens qui liront notre livre dans d'autres parties du monde, seuls le sens de l'espace et le sens du temps seront pertinents, car ils habitent un site différent qui possède sa propre sagesse». Caitlín Matthews jette les bases les plus simples et les plus solides d'une religion qui relie vraiment parce qu'elle lie au sol, à un sol particulier. Et l'instrument le plus commode pour restaurer cette religiosité immémoriale —dans un monde marqué par les fausses religions de l'éradication obsessionnelle et de l'acharnement “linéariste” contre toutes les expressions cycliques— est l'almanach, compagnon de tous nos ancêtres depuis la disparition de la tradition orale. Caitlín Matthews nous en a composé un très beau. Il faut la remercier.
Kevin McCearnnok.
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, celtisme, celtes, irlande, bretagne, europe, religion |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 14 mars 2008
K. K. F. W. Lachmann, érudit latiniste

14 mars 1793: Naissance à Brunswick du philologue classique allemand Karl Konrad Friedrich Wilhelm Lachmann, auteur de commentaires sur le De Rerum Natura de Lucrèce, ouvrage pionnier et innovateur en érudition latine. Lachmann établira les règles de la métrique et de la prosodie de l’ancien et du moyen haut allemand médiéval. En 1829, il publie des éditions de la poésie de Catulle et de Tibulle. En 1847, il inaugure les études homériques, en publiant un ouvrage remarqué (bien que dépassé aujourd’hui) sur l’Iliade. Véritable héros des études sur la longue mémoire européenne, Lachmann a uni, en sa personne, le passé latin, grec et germanique de l’Europe.
00:29 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, traditions |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook