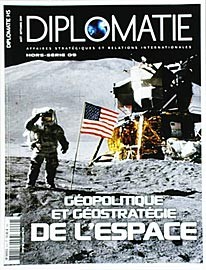| di K. Gajendra Singh* - http://www.eurasia-rivista.org/
La storia è dominata da un inesorabile determinismo
in cui la libera scelta delle grandi figure storiche gioca un ruolo infimo
Lev Tolstoj
A quel che si dice, quando nel mese di novembre il potente vicepresidente statunitense Dick Cheney si scomodò per un viaggio insolitamente lungo che lo portò a Riyad, lo fece per creare contro Iran, Siria ed Hezbollah libanese una nuova alleanza sunnita nella regione, capitanata dagli USA e composta dai sei Stati del Consiglio per la Cooperazione del Golfo, dai governi arabi filoamericani del Cairo e di Amman e da volenterosi alleati della NATO - il tutto col discreto sostegno di Israele. Il 12 dicembre il "New York Times" citava fonti diplomatiche statunitensi ed arabe per rivelare quanto assicurato a Cheney, e cioè che, nel caso d'un ritiro delle truppe statunitensi, Riyad sosterrebbe finanziariamente gl'Iracheni sunniti in qualsiasi guerra contro gl'Iracheni sciiti. Il re saudita Abdullah espresse inoltre una ferma opposizione a qualsiasi negoziato diplomatico tra Stati Uniti e Iran, e chiese a Washington d'incoraggiare la ripresa dei colloqui di pace tra Israele ed i Palestinesi.
La posizione saudita riflette la paura degli alleati arabo-sunniti degli USA di fronte alla crescente influenza esercitata in Iraq ed in Libano da Tehran, dove i suoi sodali di Hezbollah hanno avuto la meglio sulle forze di terra israeliane; il tutto con sullo sfondo le ambizioni nucleari dell'Iran. Il re Abdullah II di Giordania era stato tra i primi a mettere in guardia dall'ascesa dell'influenza sciita, e soprattutto dalla mezzaluna sciita che dall'Iran giunge in Libano via Iraq e Siria. Riyad ammonì inoltre che un governo iracheno egemonizzato dalla Shi‘a avrebbe utilizzato le sue truppe contro la popolazione sunnita; infatti, l'Arabia Saudita sostiene l'instaurazione d'un governo d'unità nazionale a Baghdad. Il "New York Times" riportava inoltre queste parole, rivolte dal sovrano saudita a Cheney: «Se vi doveste ritirare e cominciasse una pulizia etnica contro i sunniti, ci sentiremmo trascinati in guerra».
Sia i funzionari sauditi sia la Casa Bianca hanno sconfessato questo resoconto. «Questa non è la politica del governo saudita», ha dichiarato ai cronisti l'addetto stampa della Casa Bianca, Tony Snow; «i Sauditi hanno chiarito di condividere i nostri stessi obiettivi, cioè la nascita d'un Iraq autosufficiente che possa sostenersi, governarsi e difendersi da solo, che riconoscerà e proteggerà i diritti d'ognuno a prescindere dalla sua setta o religione. E, oltretutto, condividono anche le nostre preoccupazioni per il ruolo che gl’Iraniani stanno giocando nella regione».
Invece Kenneth Pollack, di Brookings Institution, ha sostenuto alla CNN che l'Arabia Saudita è fortemente motivata a prendere parte ad una eventuale guerra civile: «I Sauditi temono terribilmente che una guerra civile potrebbe allargarsi anche al loro paese. Ma sono inoltre terrorizzati dalla prospettiva che gl'Iraniani, spalleggiando le varie milizie sciite in Iraq, ne possano trarre grande vantaggio».
Un ruolo saudita più muscolare per contrastare l'Iran?
Scrivendo sul "Washington Post" il 29 novembre, poco dopo il viaggio di Cheney, Nawaf Obaid, alto consigliere alla sicurezza nazionale dell'ambasciatore saudita negli USA, principe Turki al-Faisal, citava una lettera del febbraio 2003 indirizzata dal ministro degli esteri saudita, principe Saud al-Faisal, al presidente George Bush, per metterlo in guardia dal «risolvere un problema creandone altri cinque», con la deposizione forzata di Saddam Hussein; nell'articolo si faceva inoltre riferimento ad una recente dichiarazione dell'ambasciatore al-Faisal, secondo cui «dal momento che gli Americani sono andati in Iraq senza invito, ora non dovrebbero neppure lasciarlo senza essere stati invitati a farlo». Obaid argomentava che una tale visione delle cose si basa sulle richieste giunte alla dirigenza saudita da parte d'importanti figure tribali e religiose irachene, ma anche dai governanti d'Egitto, Giordania e d'altri paesi arabi e musulmani (sunniti), affinché il Regno fornisca armi e sostegno finanziario agl'Iracheni sunniti ed assuma un ruolo più muscolare nella regione: «Essendo il motore economico del Vicino Oriente, il luogo di nascita dell'Islam e la paladina de facto della comunità sunnita mondiale (che comprende l'85% di tutti i musulmani), l'Arabia Saudita ha sia i mezzi sia la responsabilità religiosa per intervenire». Tra le opzioni prese in considerazione c'è l'istituzione di nuove brigate sunnite e la fornitura ai comandanti militari sunniti (in primo luogo ex baathisti membri del disciolto corpo ufficiali iracheno, la spina dorsale dell'insorgenza) di denaro, armi e appoggio logistico - cioè quello che l'Iran sta dando ai gruppi armati sciiti già da anni. L'Arabia Saudita potrebbe strozzare i finanziamenti iraniani alle milizie incrementando la produzione petrolifera e dimezzando il prezzo del greggio, cosa che avrebbe effetti devastanti sull'Iran e sulla sua capacità di finanziare le milizie sciite in Iraq e altrove. (Nel 1990 il Kuwait, inondando di petrolio il mercato - su richiesta dell'Occidente - e così soffocando le entrate irachene, spinse Saddam Hussein ad invaderlo. Il Kuwait e l'Arabia Saudita pagarono un duro scotto, sul piano finanziario, politico e non solo. Questa volta, con gli USA impantanati in Iraq, il giochetto potrebbe risultare fatale. L'opinione pubblica statunitense non ha digerito la guerra irachena, e numerosi generali hanno affermato che la US Army è quasi disfatta). «Rimanere ai margini sarebbe inaccettabile per l'Arabia Saudita», proseguiva Obaid; «chiudere un occhio sul massacro degl'Iracheni sunniti significherebbe abbandonare i princìpi su cui nacque il Regno, minerebbe la credibilità dell'Arabia Saudita nel mondo sunnita e costituirebbe una capitolazione di fronte al militarismo iraniano nella regione. Senza dubbio il coinvolgimento saudita in Iraq comporta grandi rischi: può scatenare una guerra regionale. Così sia. Le conseguenze dell'inazione sarebbero ben peggiori». Secondo la migliore tradizione saudita, il Regno ha sconfessato le dichiarazioni di Obaid sul "Washington Post" e l'ha esonerato. In breve volgere di tempo anche l'ambasciatore Turki al-Faisal, ex capo della sicurezza nel suo paese, è rimpatriato dopo appena quindici mesi di permanenza, quando il suo predecessore aveva invece servito per vent'anni. L'Ambasciatore non era presente a Riyad durante la visita di Cheney. Mantenere il basso profilo e negare l'evidenza rientra nella comune strategia saudita. Gli esponenti degli oltre 7.000 prìncipi che regnano sull'Arabia Saudita per anzianità e consenso potranno pur avere qualche divergenza politica, specialmente tra la vecchia guardia conservatrice ed attempata ed i prìncipi più giovani, ma la dinastia è attualmente nei pasticci e sta affrontando la più grande sfida di sempre nella sua storia.
Altre mosse
In generale, dopo l'11 settembre e le tirate anti-saudite negli USA, il Regno s'è guardato attorno in cerca d'altri approdi. Le relazioni saudite con Pechino, cominciate nel 1989 con l'acquisto dei missili CSS-2, si sono sviluppate gradualmente grazie all'identificazione della Cina quale futuro grande mercato per il petrolio saudita. Anche i rapporti con Mosca sono migliorati. Re Abdullah ha inoltre visitato Nuova Delhi, cosa mai successa prima. Sia Tehran sia Riyad hanno cercato di migliorare i rapporti, ma le ricadute del pantano iracheno provocato dall'invasione statunitense hanno complicato di molto la situazione, tanto che non si può più cavarsela alla meno peggio con i vecchi metodi della diplomazia "della pazienza" o "del libretto degli assegni".
Riconoscendo l'importanza regionale della Turchia, il sovrano saudita Abdullah ha visitato Ankara a fine novembre, prima visita in quattro decenni. La Turchia, dotata d'una costituzione laica e popolata per lo più da sunniti (mentre il 15% sono sciiti alauiti), è a sua volta profondamente preoccupata dall'ipotetica disgregazione dell'Iraq e dal crescente profilo dell'Iran, suo nemico storico. Mentre confronta le proprie idee con Giordania, Siria, Iraq, Qatar, Bahrein, Pakistan e Russia, Ankara condivide con Tehran la preoccupazione per un'indipendenza dell'Iraq settentrionale a maggioranza curda. Ankara e Washington, pur alleati nella NATO, hanno visioni piuttosto divergenti sul Vicino Oriente. All'inizio di dicembre il primo ministro turco Recep Erdogan ha espresso la propria opposizione al dispiegamento di truppe statunitensi nell'Iraq settentrionale: «Personalmente, trovo sbagliato il posizionamento di truppe nordamericane nel settentrione dell'Iraq, dal momento che non v'è alcun problema legato alla sicurezza in quella zona. Gli USA dovrebbero mantenere i loro soldati nelle aree problematiche del paese». Queste dichiarazioni sono state rilasciate ai giornalisti mentre si dirigeva a Tehran. Sia Ankara sia Tehran hanno relazioni problematiche con le loro minoranze curde. Ankara, con gran disappunto degli USA, ha ricevuto anche una delegazione di Hamas. Erdogan ha usato termini molti forti ed appassionati per condannare gli attacchi israeliani contro il Libano. Di lì a poco avrebbe portato il suo paese, per la prima volta nella storia, ad un colloquio con la Lega Araba, al Cairo.
La situazione dell'Iran ricorda la favola del cammello e dell'arabo: eccetto le zampe anteriori, è fermamente piantato nella tenda irachena, tramite i partiti sciiti SCIRI e Dawa ed anche alcune fazioni interne all'Esercito del Mahdi. Hezbollah, finanziato, addestrato e armato da Tehran, durante gli scontri terrestri dell'ultima estate nel Libano meridionale ha inflitto una sanguinosa sconfitta ai rinomati reparti d'assalto israeliani, sfatando per sempre la cosiddetta "aura d'invincibilità" che Israele si costruì sconfiggendo gli Arabi nella Guerra dei Sei Giorni (1967), e che in seguito rafforzò con la minaccia nucleare e coll'incondizionato sostegno occidentale (ed in particolare statunitense). Israele, infatti, possiede centinaia di bombe nucleari ed ha i mezzi necessari per lanciarle. Il primo ministro sionista Ehud Olmert, sebbene inavvertitamente, l'ha anche ammesso in pubblico. Anche il nuovo segretario alla difesa statunitense, Robert Gates, durante la sua audizione al Congresso ha fatto riferimento alle bombe israeliane. Anche per questo l'opposizione israeliana (e statunitense) all'arricchimento dell'uranio, persino a scopo pacifico, da parte dell'Iran è al limite del fanatismo. Stando alla propaganda di Tel Aviv, è solo questione di tempo e l'Iran svilupperà la bomba; gli USA ritengono che siano necessari tra i cinque ed i dieci anni.
Tehran sta nella bambagia. I dirigenti iraniani gongolano di fronte alla trappola irachena in cui sono caduti gli USA. Mohsen Rezai, segretario generale del potente Consiglio degli Esperti che coadiuva la guida suprema ayatollah Khamenei, s'è recentemente vantato alla televisione pubblica: «Il genere di servizio fattoci dai Nordamericani, pur con tutto il loro odio, non ha precedenti: nessuna superpotenza aveva mai fatto qualcosa di simile. Gli USA hanno distrutto tutti i nostri nemici nella regione. Hanno distrutto i Talebani. Hanno distrutto Saddam Hussein. (...) Gli Statunitensi sono così piantati in Iraq e in Afghanistan che, se anche dovessero riuscire a saltarne fuori sani e salvi, avrebbero davvero di che ringraziare Dio. Gli USA si presentano a noi più come un'opportunità che come una minaccia - non certo perché essi lo vogliano, ma perché hanno sbagliato i calcoli. Molti sono gli errori che hanno commessi».
Gli USA e l'Occidente hanno persuaso la Russia e la Cina a varare sanzioni, sia pur blande, contro l'Iran, tramite la risoluzione dell'ONU del 23 dicembre rigettata da Tehran. Ma sono state proprio le cinque potenze nucleari riconosciute, aderenti al Trattato di non proliferazione nucleare (TnPN) e dotate del diritto di veto al Consiglio di Sicurezza, che hanno ucciso il trattato: infatti, esse non si sono mai mosse verso il disarmo - il primo degli obiettivi del TnPN - ed hanno costantemente violato altri suoi articoli, in spregio delle risoluzioni adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e dell'opinione espressa dalla Corte Internazionale dell'Aja. Addirittura, hanno preso a costruire una nuova generazione di bombe per uso "convenzionale". La bomba nucleare nordcoreana prova semplicemente il disordine in cui versa la materia regolata dal TnPN, nonché l'irrilevanza di quest'ultimo. L'anziano statista nordamericano Jimmy Carter ha, con grande franchezza, denunciato le responsabilità degli USA per la situazione attuale. Ormai anche i membri del Consiglio del Golfo, o altri paesi arabi come Egitto e Algeria, vogliono seguire l'esempio dell'Iran ed imbarcarsi nel ciclo d'arricchimento dell'uranio. Le loro paure di lunga data e l’ormai pluridecennale opposizione all'atomica israeliana - sviluppata con l'aiuto franco-britannico e l'acquiescenza (se non il supporto) statunitense – si sono sempre scontrate col veto nordamericano, sia a New York sia a Vienna. I bulli dominano il mondo, in questo pianeta sempre più senza legge.
La lunga e sanguinosa guerra tra Iraq e Iran (1980-‘88) fu, in ultima analisi, un conflitto tra Sunna e Shi'a, nel corso del quale Saddam Hussein venne incoraggiato, sostenuto e finanziato da tutti i governi arabi sunniti (eccetto quello siriano) - in particolare da Arabia Saudita, Kuwait, Emirati - e dalle potenze occidentali, allo scopo di neutralizzare la grandiosa ascesa della potenza sciita e l'istanza di rinnovamento del mondo islamico rappresentata dalla rivoluzione khomeinista del 1979. Milioni di musulmani, iracheni ed iraniani, furono uccisi nel corso di quella guerra. Ma se paragonata con quel conflitto, la prossima conflagrazione intermusulmana - che potrebbe essere incoraggiata da un Occidente disperato - rappresenterebbe un vero e proprio olocausto per la regione e per l'Islam. Washington potrebbe pure riuscirci, ma il risultato sarebbe una catastrofe per il mondo intero - in primis per l'Occidente, fortemente dipendente dal punto di vista energetico.
La frattura sciita-sunnita è troppo profondamente marcata e radicata nel quotidiano in molti paesi musulmani. In numerosi Stati di tradizione sunnita gli sciiti vanno a costituire una classe subalterna; ma dopo il 1979, ispirati ed aiutati dall'Iran, hanno cominciato a guadagnare terreno in Libano e non solo. La parte occidentale dell'Arabia Saudita, molto ricca di petrolio e adiacente all'Iraq meridionale, è al pari di quest'ultimo popolata da sciiti, finora vissuti in un pesante clima di repressione. Il conflitto sciita-sunnita non può essere fermato da nessuna fatwa. Una è stata emessa lo scorso ottobre a la Mecca: ventinove chierici iracheni, appartenenti ad entrambe le confessioni, radunati durante il Ramadan per iniziativa dell'Organizzazione della Conferenza Islamica (OCI), hanno pubblicato un Documento Makkah in dieci punti. Ricorrendo alla citazione di versetti del Corano e a detti tradizionali del Profeta Mohammed, la fatwa afferma che «è proibito versare sangue musulmano». Invita inoltre a salvaguardare i luoghi santi delle due comunità, difendendo l'unità e l'integrità territoriale dell'Iraq; infine, richiede il rilascio di «tutti i detenuti innocenti».
Tuttavia, ancora la maggior parte degli esperti, inclusi quelli musulmani, ostentano pessimismo circa l'efficacia di simili proclami. Secondo Abdel Bari Atwan, direttore in capo del giornale arabo londinese "Al-Quds al-Arabi", gli appelli delle guide religiose all'interruzione degli spargimenti di sangue sono destinati a rimanere inascoltati. Lo si può verificare nei quotidiani bagni di sangue che si verificano in Iraq, nel mondo islamico, e che si sono verificati per tutta la loro storia.
Storia petrolifera del Vicino Oriente
Lo studio dell'imperialismo occidentale dalla fine del XIX secolo ad oggi mostrerà l'importanza del petrolio e delle guerre condotte per acquisire e proteggere questi pozzi di potere. L'accordo segreto Sykes-Picot (1916) tra Inghilterra e Francia spartiva i resti dell'Impero Ottomano nel Vicino Oriente: i Britannici, astutamente, s'accaparrarono i territori produttori di petrolio e giunsero persino a creare uno Stato artificiale come il Kuwait. Nel 1945, prima che una declinante Inghilterra fosse spogliata delle sue colonie, gli USA siglarono un memorandum con i Britannici: «La nostra politica petrolifera, in relazione al Regno Unito, è informata al mutuo riconoscimento della grande comunanza d'interessi, ed incentrata sul controllo, almeno per il momento, della gran parte delle risorse petrolifere disponibili al mondo». Il governo inglese notava come il Vicino Oriente fosse «un tesoro inestimabile per qualsiasi potenza interessata all'influenza ed al dominio mondiale», dacché il controllo delle riserve petrolifere globali corrispondeva a controllare l'economia mondiale. Dopo il declino del Regno Unito e della Francia, sono intervenuti gli USA in qualità di potenza neocoloniale dominante in quella ed in altre regioni.
«Un tassello fondamentale della politica degli Stati Uniti nel Vicino Oriente dev'essere l'incondizionato sostegno all'integrità territoriale ed all'indipendenza politica dell'Arabia Saudita». I suoi obiettivi erano chiariti in un documento interno del 1953: «La politica statunitense consiste nel mantenere le fonti petrolifere vicino-orientali in mano nordamericana» (cit. da: Mohammed Heikal, Cutting the lion's tail). Nel 1958, un documento segreto britannico descriveva i principali obiettivi della politica occidentale nel Vicino Oriente: «1. Assicurare all'Inghilterra ed agli altri paesi occidentali il libero accesso al petrolio prodotto negli Stati affacciati sul Golfo; 2. assicurare la continua disponibilità di tale petrolio a condizioni favorevoli e per le maggiori entrate del Kuwait; 3. sbarrare la strada alla diffusione di comunismo e pseudo-comunismo nell'area, e conseguentemente difenderla dal marchio del nazionalismo arabo».
Chomsky sostiene che le compagnie energetiche occidentali hanno prosperato grazie a «profitti eccedenti i sogni più avidi», con «il Vicino Oriente quale loro principale vacca da mungere». Si trattava di una parte della grande strategia statunitense, fondata sul controllo di quello che il Dipartimento di Stato, sessant'anni fa, descrisse come «la stupenda fonte di potere strategico» del petrolio vicino-orientale, e sull'immenso beneficio derivante da questo «tesoro materiale» senza precedenti? Gli USA hanno sostanzialmente mantenuto questo controllo - ma gli straordinari successi conseguiti sono derivati dal superamento d'innumerevoli barriere: quelle che, ovunque nel mondo, i documenti interni statunitensi definiscono «nazionalismo radicale»; ma che significa solo desiderio d'indipendenza.
Il collegamento tra USA, famiglia ibn Saud e wahhabismo
Lo Stato saudita, proclamato nel 1932 da Abdul Aziz, fu di fatto il terzo reame degli al-Saud. Il primo "Stato" saudita nacque nel 1744, ad opera del primo grande esponente della famiglia, Muhammad ibn Saud, che concluse la storica alleanza col riformatore religioso Muhammad ibn Abdul Wahhab (fondatore del "wahhabismo"). Dopo la sconfitta patita nel 1818 ad opera delle forze egiziane, il Regno risorse nel 1822 per affermarsi quale potenza dominante nell'Arabia Centrale. Delle quattordici successioni interne alla dinastia al-Saud tra il 1744 ed il 1891, appena tre avvennero pacificamente. Oggigiorno, il trasferimento del potere è più tranquillo. Abdul Aziz fu incoraggiato dagl'Inglesi ad assumere il controllo della Mecca e di Medina, poiché lo sceriffo Hussain, signore della Mecca e bisnonno di re Abdullah II del Regno hashemita di Giordania, s'era mostrato poco docile e malleabile. Ricordiamo che lo sceriffo Hussain ed i suoi figli, gli emiri Faisal e Abdullah, avevano guidato la rivolta araba descritta nella pellicola Lawrence d'Arabia, aiutando le forze britanniche del gen. Allenby a sconfiggere l'esercito ottomano nella regione: bella gratitudine da parte degl'Inglesi! Il problema è che, quando Kemal Atatürk abolì il Califfato, lo sceriffo Hussain si candidò subito ad assumerne il manto regale.
Abdul Aziz prese molte mogli, al fine di cooptare questa o quella tribù, o di ricucire quando necessario buoni rapporti; essendo però un musulmano profondamente devoto, non ebbe mai più di quattro spose contemporaneamente. Il patto tra la setta wahhabita e la casa di Saud fu sancita da numerosi matrimoni. I legami tra la famiglia saudita ed i seguaci wahhabiti non si sono sciolti ancora oggi. Il ministro saudita della religione è sempre un membro della famiglia al-Sheikh, che discende da Ibn Abdul Wahhab. L'influsso wahhabita sulle moschee è indubbio, dato che la setta dispone d'una propria polizia religiosa. Inoltre, essa ha esteso la propria portata attraverso la rete di madrasse e moschee sorte in tutto il mondo musulmano.
Il wahhabismo è estremamente rigido ed austero. Non tollera molto il dialogo ed ancor meno l'interpretazione; disapprova l'idolatria, i monumenti funebri e la venerazione di statue o immagini artistiche. I seguaci preferiscono definirsi muwahhidun, cioè "unitari". I wahhabiti proibiscono il fumo, il taglio della barba, il linguaggio volgare ed i rosari, nonché molti diritti femminili. Considerano tutti coloro che non praticano la loro forma di Islam, inclusi gli altri musulmani, alla stregua di pagani e nemici.
Il legame wahhabita-saudita era semplice quando il Regno era povero. Ho visto alcuni vecchi archivi degli anni '20 e '30, conservati al Ministero degli Affari Esteri di Nuova Delhi e risalenti all'era pre-petrolifera, quando insignificanti nababbi musulmani dell'India, da Pataudi, Loharu e Chhatari, versavano piccole somme alle principali cariche di Gedda, Mecca, Medina e Riyad. Le entrate derivanti dagli annuali pellegrinaggi del Hajj costituivano forse la maggior risorsa per i cittadini ed i governanti del Regno. Alcuni arabi provenienti dai regni del Golfo lavoravano come scaricatori di porto a Mumbai, ed erano coinvolti nel contrabbando di oro in India. Sono poi divenuti multimilionari col petrolio ed il commercio.
L'Arabia Saudita è un grande paese: occupa un'area di 2,14 milioni di chilometri quadrati. La sua popolazione s'avvicina ai 22 milioni di persone, con un tasso di crescita del 3,49% ed un'aspettativa di vita pari a 71 anni. Più del 50% della popolazione ha meno di vent'anni e l'80% vive in centri urbani, consumando quantità colossali d'energia in aria condizionata. Non è più una nazione beduina. Il 75% degli adulti sono alfabetizzati, ma l'antiquato sistema educativo ha poca pertinenza col mercato del lavoro. Quasi il 30% della forza lavoro è d'origine straniera. Con la recente crescita del prezzo del petrolio, la sua situazione finanziaria è migliorata rispetto a qualche anno fa, quando aveva il maggior indebitamento del Golfo: 171 miliardi di dollari di debito interno e 35 miliardi di credito dall'estero, pari al 107% del PIL. L'antropologo saudita Mai Yamani nel 2000 sondò le opinioni, le speranze e le paure dei cittadini compresi tra i 15 ed i 30 anni: scoprì così che il tema dell'identità «finiva sempre più col dominare e permeare l'intero studio». Pur rimanendo ben radicata nella religione, nella cultura e nelle tradizioni nazionali, la maggior parte dei giovani aveva risentito della rapida trasformazione avvenuta intorno a loro, e metteva in questione diversi aspetti dello status quo. Si riscontrava un'identità di vedute circa «i difetti percepiti dello Stato» ed il desiderio della nuova generazione «di trovare spazio nella società saudita, per sviluppare i propri atteggiamenti e le opinioni personali senza la prepotente presenza dello Stato e degli ulema». Il quadro finale è quello d'un progresso discontinuo, con l'emergere di problemi complessi.
Gli Arabi sauditi, come molti altri, hanno risentito delle importazioni occidentali, che hanno trovato molti ardenti sostenitori della modernizzazione buttarsi a capofitto nei problemi dell'identità e dell'autenticità, generando così una dura reazione in grado di rafforzare gli elementi conservativi che dominano il Regno. «Il problema saudita consiste nel trovare un giusto bilanciamento», ha raccontato M. H. Ansari, ex ambasciatore indiano a Riyad, «e si tratta d'un problema reale, aggravato dal desiderio di proteggere i privilegi della famiglia reale e la loro versione delle tradizioni islamiche. In un sistema monarchico la sicurezza nazionale è sinonimo di saldezza del regime e, per la gran parte del secolo scorso, la continuità e la stabilità data dalla famiglia al-Saud fu vista benevolmente, in patria dall'opinione pubblica ed all'estero da vicini e amici. La monarchia saudita resistette all'attacco del nazionalismo e del radicalismo arabo ed aiutò la crociata anti-comunista in Afghanistan, Nicaragua, Etiopia, ecc.; inoltre, sfruttò la sua enorme influenza in seno all'OPEC per mantenere produzione e prezzo del greggio ad un livello accettabile per il mondo industrialmente sviluppato. Infine, costituì uno dei più grandi mercati per la produzione bellica del mondo occidentale, e principalmente degli Stati Uniti».
In Arabia Saudita il petrolio fu scoperto nel 1938 dalla Standard Oil of California, la quale ottenne da Abdul Aziz una concessione cinquantennale in cambio d'un pagamento immediato di 30.000 monete d'oro: senza dubbio uno dei più grandi affari della storia! Quando la sbalorditiva estensione dei giacimenti fu ormai evidente, intervennero anche altre compagnie, come Exxon, Texaco e Mobil, per costituire il potente consorzio Aramco.
Da quel momento venne a crearsi il curioso intreccio tra gli USA, la scandalosamente ricca classe dirigente saudita e, per proprietà transitiva, i puritani wahhabiti: in cambio della sicurezza della dinastia, le ricchezze e le fonti di reddito della penisola sono state cedute allo sfruttamento dell'Occidente, ed in primis agli USA. Tale intreccio ha superato la prova del tempo: ancora oggi Washington sta facendo l'impossibile per conservare quel regime feudale dalle pratiche tipicamente medievali. Il regime controlla la più grande "impresa familiare" al mondo, senza alcun mandato popolare o responsabilità verso la cittadinanza.
L'alleanza tra gli USA e la famiglia al-Saud fu consacrata dal presidente Franklin Roosevelt, che nel 1945 incontrò il Sovrano saudita a bordo d'una nave da guerra ed ebbe occasione di dichiarare: «Con questo riconosco che la difesa dell'Arabia Saudita è fondamentale per la difesa degli Stati Uniti». Jimmy Carter, che in tempi recenti ha assunto atteggiamenti da santo, nel 1980 s'esprimeva ancor più vigorosamente: «La nostra posizione è assolutamente chiara. Il tentativo di conquistare il controllo del Golfo Persico, da qualunque potenza estera venga compiuto, sarà considerato un attentato agl'interessi vitali degli Stati Uniti».
Washington ha onorato quest'impegno con alcuni trattati militari volti alla salvaguardia del Vicino Oriente. A parte NATO e CENTO, le basi militari statunitensi si distendono dall'Africa Orientale all'Oceano Indiano, passando per il Golfo, in difesa del petrolio vicino-orientale. Inoltre sono stati istituiti la Forza di Dispiegamento Rapido, il Comando Centrale e la V Flotta, che oggi ha base nel Bahrein. La Guerra del Golfo del 1991 portò ad una massiccia espansione della presenza militare statunitense nella regione: le truppe nordamericane hanno messo piede anche sul sacro suolo saudita, provocando grande angoscia e profondo risentimento tra i musulmani sauditi più conservatori, Osama bin Laden in testa. Le truppe statunitensi si sono mosse di là solo dopo l'invasione dell'Iraq nel 2003.
Il massiccio acquisto d'armi da parte saudita
Tra il 1990 ed il 2004 l'Arabia Saudita ha speso in armamenti l'enorme cifra di 268,6 miliardi di dollari; gli Emirati Arabi Uniti, che contano appena 2,6 milioni d'abitanti, hanno speso 38,6 miliardi. L'arsenale saudita comprende oltre 1.015 carri armati (tra cui 315 modernissimi M1A2s), più di 5.000 APC/AFV, oltre a 2.000 lanciamissili anticarro, 340 e passa velivoli da combattimento d'alta qualità (inclusi F15S/C/Ds e Tornado, senza contare i 48 Typhoons - noti anche come Eurofighter - che saranno consegnati nel 2008). Ciliegina sulla torta, i Sauditi possiedono anche 228 elicotteri, 160 velivoli da addestramento e collegamento e 51 aerei da trasporto. La marina saudita può contare su 27 grandi vascelli da combattimento, incluse fregate e corvette lanciamissili.
Il Kuwait (1,1 milioni d'abitanti) ha speso 73,1 miliardi di dollari, ma, come scrive il dr. Abbas Bakhtiar (consulente ed ex professore associato all'Università del Nord, in Norvegia), «quando il 2 agosto 1990 gl'Iracheni passarono il confine, i generali kuwaitiani usarono i loro telefonini per radunare tutti gli alti ufficiali militari in un convoglio diretto verso l'Arabia Saudita. I soli soldati che inscenarono una qualche resistenza furono i cadetti, che non erano stati avvertiti». Ho udito racconti analoghi quando servivo ad Amman (1989-1992). Nel 1979, allorché militanti islamici occuparono la sacra moschea della Mecca, dovette intervenire un reparto d'assalto francese per farli sloggiare.
Questi tre paesi (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Kuwait) messi assieme hanno speso, in quattordici anni, oltre 380 miliardi di dollari. Nello stesso periodo, la spesa militare iraniana è ammontata a 49,5 miliardi e quella dell'India (che ha oltre un miliardo d'abitanti e controversie di confine con Pakistan e Cina) a 156 miliardi.
Anthony H. Cordesman e Arleigh A. Burke, del Center for Strategic and International Studies (CSIS), nel 2002 scrissero una relazione sui problemi della sicurezza saudita, da cui riportiamo il seguente brano: «Non dovrebbero più esserci altri ingenti invii di armamenti dagli USA o dall'Europa, simili a quelli avvenuti durante la Guerra del Golfo, o un altro acquisto stile "al-Yamama". A meno d'una grande guerra futura, gli acquisti dovrebbero essere fatti e giustificati caso per caso, andrebbero messi al bando il baratto col petrolio e tutti gli accordi bilanciati soggetti ad un resoconto pubblico annuale, con contabile e revisore indipendenti. Inoltre l'Arabia Saudita deve compiere il massimo sforzo possibile per eliminare gli sprechi finanziari».
Nel dicembre 2005 “The Guardian” rese nota la firma d'un contratto multimiliardario di vendita dei Typhoons, o Euro-fighters. La cosa interessante è che la vendita veniva giustificata con la minaccia del terrorismo globale. Il Ministero della Difesa britannico dichiarò che l'obiettivo fondamentale dei due governi era quello di garantire la sicurezza nazionale e «combattere il terrorismo globale».
Nel 2005, dei 133,5 miliardi di dollari guadagnati con la vendita di petrolio, l'Arabia Saudita ne spese 38,5 per la difesa. Buona parte dei 57,1 miliardi di sovrappiù furono destinati al pagamento dell'enorme debito contratto dall'Arabia Saudita con l'Occidente in occasione della prima Guerra del Golfo (1991). I media riferiscono che i prìncipi assumono personalmente commissioni d'armamenti ed accordi commerciali, e che il loro denaro - stimato complessivamente in un trilione di dollari - è per lo più investito in Occidente. Secondo alcune stime, il 40% delle entrate petrolifere saudite andrebbe a finire direttamente nelle tasche della famiglia regnante. Tariq Alì parlava a tale proposito di "saccheggio istituzionalizzato" dei fondi pubblici.
L'Ufficio Grandi Frodi britannico, prima d'essere fermato, ha scoperto laute bustarelle pagate da alcuni prìncipi sauditi, intermediari negli affari di fornitura bellica intercorsi tra i due paesi, al primo ministro Tony Blair ed al suo guardasigilli Goldsmith; esse riguarderebbero un verdetto, emesso dal governo, sulla legalità dell'invasione anglosassone dell'Iraq. I Sauditi temevano la cancellazione del multimiliardario contratto "al-Yamama". Transparency International, che cataloga i casi di corruzione nei paesi poveri, spesso si dimentica dei donatori e ricevitori di grandi tangenti.
È vero che, nel 1990, gli Statunitensi giocarono sulle fotografie aree della disposizione delle truppe irachene per convincere i Sauditi che Saddam Hussein progettava d'attaccare il Regno, ma forse fu la latente sensazione d'insicurezza che pervade l'Arabia Saudita a convincerla ad accettare la presenza dei Nordamericani, con conseguenze nefaste permanenti per la regione. Successivamente, gli USA ignorarono gli sforzi sauditi per garantire una pacifica ritirata delle truppe irachene dal Kuwait. Gli Americani erano venuti per restarci a lungo.
Governi, banche e compagnie petrolifere occidentali si sono abituati a giocare con la ricchezza petrolifera araba, che hanno chiamato "riciclaggio" e fatto pagare, mentre il riciclaggio dei loro stessi fondi diventa "investimento". Un coro di proteste e lamenti s'è alzato dall'Occidente allorché la Russia, risorta sotto Vladimir Putin, ha deciso di controllare le proprie risorse petrolifere tramite Gazprom, che ha acquisito da Shell, Mitsui e Mitsubishi il 50% più un'azione del progetto gasifero Sakhalin-2 (il cui valore è stimato in 20 miliardi di dollari); forte dei suoi petrodollari, ora Mosca vuole investire anche nella fase distributiva in Europa Occidentale e forse negli USA (ai Cinesi è stato impedito di comprare la UNOCAL - cosa che avrebbero fatto con un trilione di dollari - e la compagnia di Dubai che cura la spedizione verso i porti statunitensi). Analogamente, quando la Russia ha deciso d'adottare il prezzo di mercato per il gas venduto a Ucraina e Georgia - che si sono fatte in quattro per minacciare gl'interessi russi - i liberoscambisti d'Occidente hanno intonato in coro: «Non farlo!». E perché mai?! Oppure, se ad un qualche oligarca russo filooccidentale viene richiesto di pagare le tasse, i media occidentali si sciolgono in filippiche contro la Russia, le sue carenze democratiche ed il mancato rispetto dei diritti umani. Perché?! Non si tratta d'ipocrisia, ma di puro imbroglio. La Russia rifiuta di diventare come gli USA, che non sono una repubblica del popolo, ma una grande multinazionale, dove il complesso militare-industriale dominante è avviato verso la sua bancarotta Enron-izzante.
Nel contempo, in Arabia Saudita (ed in molti altri regni del Golfo) paura e segretezza permeano tutti gli aspetti della struttura statuale. Non vi sono partiti politici, sindacati, tutele dei lavoratori, difesa dei diritti degl'immigrati, gruppi femminili, né altre organizzazioni democratiche. Vi sono poche associazioni od organizzazioni legali che assicurano un processo giudiziario equo ed indipendente. Così, gli oppositori politici e religiosi possono essere detenuti indefinitamente senza processo, oppure imprigionati in seguito a giudizi grossolanamente pilotati. La tortura è endemica ed i lavoratori stranieri, in particolare quelli non musulmani, sono i più a rischio. Anche quando sono stati suoi cittadini a subire la tortura, il governo britannico è rimasto zitto, per amore del profitto derivante dal commercio di petrolio ed armamenti, nonché dalle tangenti (che viaggiano anche attraverso l'Atlantico per raggiungere gli USA, come apertamente dichiarato dall'ultimo Ambasciatore saudita).
Minacce interne
In questo momento l’Arabia Saudita è minacciata dall’interno, come dimostrano i numerosi attentati di al-Qaeda, che gode delle simpatie di vasti segmenti d’una popolazione intimamente conservatrice. Tuttavia, i gihadisti non sono l'unica minaccia: all’interno della popolazione in genere sorgono altre cause di preoccupazione. Nel 1969, 1972 e 1979 diversi gruppi nazionali si sono ribellati alla casata dei Saud. Solo le tribù di provata fedeltà hanno accesso alla carriera militare. Fino alla fine degli anni ‘80 il Pakistan forniva un contingente di 11.000-15.000 uomini, destinati alla protezione del governo saudita. Dopo che le truppe statunitensi si sono spostate dall’Arabia Saudita ad altri paesi, come il Qatar, i regnanti - secondo quanto riferito dal “Financial Times” - sono tornati a rivolgersi al Pakistan per ricevere alcuni soldati. La cooperazione militare tra i due paesi è vasta e di vecchia data. La manutenzione degli aeroplani e degli altri equipaggiamenti militari è per lo più affidata a personale del Pakistan, paese con cui il Regno ha strettissime relazioni difensive. Molte sono le testimonianze d’una loro cooperazione nel campo della tecnologia atomica militare. Se il metallurgista pakistano sunnita A. Q. Khan ha potuto spacciare competenze nucleari di tipo bellico alla Libia ed all’Iran sciita, ci si chiede perché non possa averlo fatto anche con l’Arabia Saudita. I media tedeschi pullulano di analisi in tal senso.
Volontari e denaro sauditi sono dietro agli attacchi che gli Statunitensi subiscono dall’Iraq al Nordafrica. Cittadini sauditi sono attivi nei ranghi della resistenza irachena, coinvolti in operazioni condotte a danno delle forze coalizzate filostatunitensi, delle cenciose forze di sicurezza irachene e della maggioranza sciita nel paese. La presenza di Sauditi in Iraq preoccupa profondamente non solo Baghdad e Washington, ma anche l’Arabia Saudita stessa ed i piccoli Stati del Golfo Persico, che vedono così una possibile futura minaccia alla loro sicurezza. Il ritorno in patria dei gihadisti sauditi rivitalizzerebbe l’opposizione nel Regno. L’esperienza maturata in Iraq potrà alterare il panorama insurrezionale in Arabia Saudita, grazie all’introduzione di nuove tecniche, metodi ed operazioni. Ma i Sauditi, dopo ogni violenza siglata al-Qaeda, ripetono regolarmente che quella sarà l’ultima.
Ebbene sì: i gihadisti sauditi (o d’altri paesi arabi del Golfo Persico) sono molto richiesti in Iraq, poiché portano con sé grosse somme di denaro contante. Reclutare sauditi agiati è un buon metodo per finanziare le operazioni terroristiche. Un rapporto confidenziale statunitense identificava come sauditi oltre il 50% dei ribelli, mentre un forum telematico si “limita” alla cifra del 40% (ma gli USA ogni volta biasimano la Siria). Ciò che preoccupa più d’ogni altra cosa è che, di quei Sauditi fatti prigionieri ed interrogati al loro ritorno dall’Iraq, circa l’80% risultava sconosciuto ai servizi di sicurezza: ciò la dice lunga sull’efficienza dei servizi segreti sauditi! Contribuiranno in modo significativo ad ampliare la violenza e la sovversione domestica in Arabia Saudita. La guerra in Iraq e la presenza statunitense nella regione hanno polarizzato larghi segmenti della popolazione saudita.
L'alta marea dell'alleanza
Dopo il guizzo dei prezzi petroliferi nel 1973, l'afflusso di grandi ricchezze in Arabia Saudita e nella regione del Golfo ha fatto sì che la bilancia degli affari e delle credenze religiose, che prima pendeva dalla parte delle versioni progressiste dell'Islam (praticate in Egitto, Siria, Libano, Iraq ed Algeria), volgesse a favore delle rigide tendenze wahhabite dell'Arabia Saudita. Ricordo che durante le mie ambascerie al Cairo ed in Algeria, nella prima metà degli anni '60, incontravo società musulmane tolleranti e cosmopolite. Ma dopo la metà degli anni '70 le cose cambiarono: persino tra i loro diplomatici ritornarono ortodossia, velo e foulard. La ragione di questa regressione dei Musulmani verso il modo di vita wahhabita può essere rintracciata nella potenza saudita, e nell'uso ch'essa ha fatto della ricchezza petrolifera per assecondare i gihadisti.
L'alta marea di questa profana alleanza si ebbe quando negli anni '80, al fine di scacciare le forze sovietiche dall'Afghanistan, si aggregarono la maggior parte dei paesi musulmani e molte potenze cristiane occidentali, e persino la Cina. USA, Arabia Saudita e Stati del Golfo spesero tra i 6 ed i 10 miliardi di dollari per la fornitura di armi ed equipaggiamento (e molti altri per l'addestramento) a mujahidin, gihadisti, militanti e terroristi. (Alcuni di questi, in seguito, sarebbero stati trasferiti dagli USA in Albania e Kosovo: là, negli anni '90, conquistarono una nuova visibilità internazionale). Il presidente pakistano Zia-ul-Haq, reo d'aver rovesciato ed impiccato il primo ministro Zulfiqar Alì Bhutto, sino al 1979 fu considerato alla stregua d'un paria. Desiderando consolidare la propria posizione, Zia sfruttò l'opportunità per islamizzare la politica del Pakistan per tutti i giorni a venire. Oggi gli elementi conservatori e fondamentalisti dominano ogni aspetto del Pakistan e si sono infiltrati nelle sue Forze Armate, grazie all'esperienza ed alle relazioni maturate durante l'addestramento e l'organizzazione dei mujahidin, dei gihadisti e dei gruppi terroristi pakistani ed afghani; qui operò soprattutto l'Inter-Services Intelligence (ISI) coadiuvata dalla CIA e da altri servizi segreti musulmani ed occidentali. L'ISI, ch'è uno "Stato dentro lo Stato", stabilì solidi e profondi rapporti con i capi dei mujahidin e di al-Qaeda, e più tardi con quelli dei Talebani, che avrebbero mutato il corso della storia del Pakistan e della regione, instaurando fitte e longeve ramificazioni per il mondo. I Talebani furono forgiati dal Pakistan, con l'aiuto e l'aperto riconoscimento dell'Arabia Saudita e con l'incoraggiamento degli USA, al fine di pacificare l'Afghanistan dopo il caos originato dal ritiro delle truppe sovietiche. Gli Statunitensi erano interessati a che la UNOCAL potesse utilizzare il territorio afghano per costruirvi gasdotti ed oleodotti, i quali avrebbero trasportato gl'idrocarburi centroasiatici fino alle coste del Mare Arabico (e da qui al più vasto mondo) ed all'India in rapido sviluppo ed assetata d'energia.
Quadri e dirigenti di al-Qaeda e dei mujahidin arabi e musulmani addestrati in Pakistan e Afghanistan, tornando ai loro paesi del Vicino Oriente, diffusero quella cultura che oggi minaccia la regione e s'è infiltrata persino in Europa, dove sono ospitate decine di milioni di musulmani. L'Arabia Saudita ha sempre spedito, direttamente o attraverso donazioni per l'edificazione di moschee, denaro ed aiuti per la nascita di madrasse, dalle quali si diffonde l'odio verso i non musulmani (in particolare i cristiani) e gli sciiti. Il grande Jihad afghano fu un'ottima occasione per i wahhabiti. I gihadisti ed al-Qaeda, creata da Osama bin Laden, si convinsero d'aver sconfitto da soli l'Unione Sovietica, la superpotenza numero due, ed oggi sperano di poter fare lo stesso con gli USA, l'iperpotenza. Dopo la guerra del 1991, condotta per liberare il Kuwait dall'occupazione irachena, lo stanziamento di truppe statunitensi nella conservatrice Arabia Saudita ha agevolato il diffondersi dell'animosità contro Washington.
L’intreccio messo a dura prova
Questo intreccio così incongruente è sopravvissuto a numerose tensioni e turbamenti, come quando negli anni '70 l'OPEC (capeggiato dai Sauditi) quadruplicò il prezzo del petrolio a seguito dell'offensiva egiziana contro Israele (Guerra dello Yom Kippur, 1973). Washington, in quell'occasione, meditò persino di spedire le proprie truppe ad assumere il controllo dei pozzi petroliferi dell'Arabia Saudita. I rapporti tra gli USA ed il Regno furono davvero in bilico quando Osama bin Laden, già inviato dell'Arabia in Pakistan per condurvi il Jihad contro i Sovietici in Afghanistan, creata al-Qaeda mise in atto alcuni attentati contro ambasciate statunitensi nell'Africa orientale. La situazione, però, esplose in tutta la sua gravità sugli schermi televisivi del mondo intero, allorché quindici dirottatori, assunto il controllo di quattro aerei statunitensi, attaccarono i simboli della potenza nordamericana - le torri del World Trade Center ed il Pentagono - scalfendo così il mito dell'intangibilità del suolo nazionale degli USA. Ma persino in quell'occasione, in virtù del profondo coinvolgimento degl'interessi energetici statunitensi - rappresentati dalla famiglia Bush e da buona parte della classe dirigente nordamericana - i membri della famiglia di Osama bin Laden furono clandestinamente evacuati dagli USA nel giro di poche ore dagli attacchi dell'11 settembre.
In generale, la maggior parte dei media e dei cittadini statunitensi cominciò a rilasciare furiosi e virulenti commenti ostili al Regno saudita. Dimenticavano che le galline allevate in Pakistan e Afghanistan erano tornate a casa per appollaiarsi. Anziché imparare la lezione dell'11 settembre, l'amministrazione Bush, plasmata dalla razzista filosofia straussiana dei neo-cons, dapprima bombardò l'Afghanistan (del resto già in macerie, proprio per colpa della rivalità USA-URSS, di cui era stato un campo di battaglia) al fine di installare basi militari in quel paese così come in Pakistan, Kirghizistan e Uzbekistan, con lo scopo apparente di combattere il terrorismo. Dopo di che, USA e Regno Unito, con l'appoggio di qualche altra nazione occidentale, invasero l'Iraq per prendere il controllo delle sue risorse petrolifere, ed in particolare della ricca regione di Baghdad (oggi, tutto ciò che gli Statunitensi controllano è la sola Green Zone). Ma gli USA hanno costruito in Iraq altre basi militari destinate ad una lunga permanenza.
Tutto ciò faceva parte d'un piano neoconservatore, battezzato "The New American Century", che, come s'è scoperto dopo il suo fallimento, era stato architettato da quei classici esperti "da salotto", la maggior parte dei quali, per inciso, erano ebrei animati fondamentalmente dal desiderio di favorire gl'interessi d'Israele. Non si crucciavano certo che le vite ed i denari statunitensi fossero spesi per rendere Israele "più sicuro e protetto", come già avvenuto nel 1991 con la guerra contro l'Iraq.
Zbigniew Brzezinski, consigliere alla sicurezza nazionale del presidente Jimmy Carter (oggi tramutatosi in un angioletto), aveva gongolato sulle pagine del "Nouvel Observator" parigino, quando rivelò come gli Statunitensi avessero sostenuto gli estremisti religiosi in Afghanistan contro il governo di sinistra proprio allo scopo d'attirarvi le truppe sovietiche ed ivi assistere alla loro sconfitta, per vendicare la propria disfatta in Vietnam. Da ciò derivò il collasso dell'Unione Sovietica. All'osservazione che con quella strategia s'era prodotto qualche "fermento" tra i musulmani, Brzezinski rispondeva: «E allora?». Allora niente... almeno finché i "musulmani in fermento" non avrebbero attaccato gli USA (11 settembre) e Londra (7 luglio), per tacere degli attentati terroristici in Spagna, a Bali (contro gli Australiani) ed ancora in altre località. L'India, che pure non faceva parte dell'asse saudita-pakistano-statunitense contro Afghanistan e URSS, ancor oggi ne patisce le conseguenze. Anche molti altri, estranei ai fatti d'allora, stanno pagando il prezzo di questo intreccio profano, e così sarà per ancora molto tempo.
Washington ha sfruttato il terrore di al-Qaeda, di cui pure non v'è traccia negli USA, per ridurre la libertà e la democrazia. Perché, se è vero che i musulmani neri non andarono in Pakistan a farsi addestrare per il Jihad afghano, essi avrebbero tuttavia molte rimostranze da fare; specialmente quelli - e sono moltissimi - rinchiusi nelle carceri statunitensi. Il Pakistan ne ha risentito profondamente. Quando Omar Sheikh fu accusato dell'omicidio del giornalista statunitense Daniel Pearl (il quale era giunto troppo vicino a scoprire il legame tra gihadisti, al-Qaeda, ISI e Pakistan), suo padre lamentò che, finché i gihadisti combattevano contro l'URSS, erano considerati degli eroi, mentre ora sono diventati nemici e "terroristi". Eh, sì, perché se ti schieri a fianco di una grande potenza, allora devi eseguirne gli ordini, oppure potresti essere bombardato "fino a tornare all'età della pietra", come pubblicamente confessato dal presidente pakistano gen. Pervez Musharraf. Quella fu la minaccia che, dopo l'11 settembre, il vicesegretario di stato nordamericano Richard Armitage rivolse al Capo dell'ISI; al Pakistan non restò altra scelta che aggregarsi agli USA nella lotta contro al-Qaeda, i gihadisti ed i Talebani, sue stesse creature.
Va anche detto che, per portare l'esercito pakistano dalla loro parte e senza renitenze, gli USA rovesciarono nel paese miliardi di dollari in aiuti militari, inclusi sofisticati armamenti navali che, a quanto pare, dovevano servire a combattere i Talebani fra le montagne afghane... Visti gli USA sprofondare nel pantano iracheno, il Pakistan è sceso a patti con i suoi Talebani delle aree di confine, persino invitando la NATO a fare lo stesso. Come ripetutamente affermato dal presidente afghano Hamid Karzai, gli attacchi contro la NATO nascono in territorio pakistano. I Talebani di base in Pakistan, appoggiati dagli elementi conservatori locali, hanno assunto il controllo del Pakistan nordoccidentale, dove addestrano i terroristi di tutta la regione, inclusi quelli provenienti dall'Uzbekistan o dalla regione turcofona cinese dello Xinjiang. Questi volontari vanno ora a combattere in Afghanistan. A questo punto l'obiettivo del Pakistan è quello di recintare la "linea Durand", che divide i Pashtun tra Pakistan e Afghanistan. Ma questo confine rimane per i Pakistani il proverbiale elefante in camera, poiché i Pashtun non l'hanno mai riconosciuto. Il Pakistan è profondamente infettato dal virus gihadista, ed anche da altri malanni. La produzione d'oppio in Afghanistan ha raggiunto livelli da primato ed è smerciato via Pakistan, dove il numero dei tossicodipendenti è passato da poche migliaia a diversi milioni. La droga ha portato con sé la cultura della violenza fondata sul Kalashnikov.
Commenti conclusivi
Dalla Prima Guerra Mondiale, con la creazione di nuovi Stati da parte dei capricciosi padroni coloniali britannici e francesi, ben poco è cambiato negli arbitrari confini dei paesi del Vicino Oriente, eccezion fatta per la creazione dello Stato d'Israele, che può essere vista come un compenso elargito all'ebraismo europeo per i crimini compiuti nella maggior parte d'Europa dalla Germania nazista e dai suoi collaboratori (compenso che però, curiosamente, viene pagato dai Palestinesi!). Dopo la Guerra Arabo-Israeliana del 1949 e la Guerra dei Sei Giorni del 1967, Israele continua a tenersi stretti i Territori arabi occupati. Con l'apertura del vaso di Pandora, sulla scia dell'invasione dell'Iraq nel 2003, sono state scatenate forze epocali, etniche e religiose destinate a mutare la geografia e la storia della regione, a cominciare dall'Iraq, dove stanno ormai emergendo tre entità su base etnica o settaria. L'invasione ha già risucchiato l'Iran e probabilmente, che lo vogliano o no, altri paesi vicini rimarranno ancor più apertamente invischiati.
Ormai lontano nel tempo il ricordo della guerra tra le dune del deserto, per i Sauditi la ricchezza petrolifera è divenuta troppo allettante perché si mettano ancora a combattere: un po' come per gli Arabi abbassidi, che dal nono secolo cominciarono a godere dei frutti del loro impero e lasciarono l'esercizio delle armi agli schiavi turchi importati dall'Asia Centrale; ben presto, però, le spade turche presero il potere nelle figure dei Sultani, che s'imposero quali protettori degli sfortunati Califfi e, talvolta, proibirono loro persino di reclutare servitori turchi.
Quando nei primi anni '60, a due passi da casa, in Yemen, gli ufficiali dell'esercito (affascinati dal nazionalismo arabo e dal socialismo di Gamal Abdel Nasser) rovesciarono il Re e fecero il loro ingresso le truppe egiziane, il Regno saudita non intervenne militarmente, ma si limitò a finanziare le forze monarchiche. Più tardi, quando gli Egiziani abbandonarono lo Yemen, i Sauditi mediarono tra le fazioni belligeranti.
Quando, a seguito della disgregazione dell'Unione Sovietica, emersero le repubbliche turche dell'Asia Centrale, l'Arabia Saudita, fedele al suo stile, inviò denaro per istruire mullah, aprire madrasse, costruire moschee e distribuire milioni di Corani. Gli apparatčki, postcomunisti e laici, che avevano assunto il controllo come nuovi governanti, si scontrarono duramente con i gihadisti addestrati dentro o attorno il Pakistan. Gli estremisti ed i militanti musulmani in Asia Centrale sono chiamati "wahhabiti".
Durante la Guerra Fredda, l'Arabia Saudita ed altri regimi musulmani religiosi e conservatori furono sostenuti e strumentalizzati dall'Occidente per combattere comunismo, socialismo e nazionalismo, essenzialmente allo scopo di tutelare gl'interessi economici, politici e strategici degli USA. I Sauditi, obbedendo alle direttive statunitensi, accettarono di scambiare il greggio in petrodollari e di manipolare i prezzi del petrolio, in modo da soddisfare le esigenze occidentali. In questa maniera gli USA possono sostenere un massiccio deficit di conto corrente, grazie al quale oggi finanziano quasi per intero il loro bilancio militare, pari a quello del resto del mondo messo assieme. I wahhabiti, dal canto loro, hanno avuto mano libera nel paese, tanto ch'è ormai ridotto ad una parodia del Medio Evo, dove ai ladri vengono tagliate le mani e gli adulteri sono lapidati. Si sta cercando d'imporre questo modello anche agli altri musulmani, ovunque gli estremisti assumano il controllo: vedi i Talebani in Afghanistan o nel Pakistan nordoccidentale. Paragonato all'Arabia Saudita, il Regno hashemita di Giordania, il cui Sovrano discende direttamente dal profeta Muhammad, è quasi una nazione moderna: vi sono leggi avanzate e libertà femminile nel lavoro, nell'educazione e nell'abbigliamento.
Vale la pena chiedersi perché la grandissima ricchezza petrolifera della penisola non sia stata utilizzata per elevare il tenore di vita dell'Umma musulmana, che i Sauditi pretendono di rappresentare e guidare in virtù del loro controllo sui sacri santuari della Mecca e di Medina. Non c'è un grande "Piano Marshall", tipo quello applicato dagli USA per promuovere la crescita economica europea dopo le devastazioni della Seconda Guerra Mondiale. Certo, vi sono dei palliativi, ma sempre connessi alla promozione dell'Islam wahhabita.
La prosperità generata dal petrolio ha beneficato principalmente le potenze occidentali, che hanno protetto la famiglia Ibn Saud, cosicché migliaia di prìncipi e principesse possono sguazzare nell'oro e nel lusso. Non serve un Sofocle per concludere che la dinastia saudita ha ritardato, direttamente o indirettamente, lo sviluppo sociopolitico ed il progresso di quella stessa Umma musulmana di cui essa presume di essere, per usare le parole di Obaid, «la guida de facto», nonché di sentirsene «religiosamente responsabile».
Osservando l'ascesa e la caduta dell'Impero Ottomano - che sopravvisse cinque secoli e coprì un'area più vasta dei dominî arabi - ci si accorge che il suo declino cominciò quando il Sultano divenne guardiano della Mecca e di Medina ed assurse al Califfato. Ne risultò infatti un influsso nefasto dei chierici, degli sceicchi e dei mullah conservatori sulla classe dirigente di Istanbul, che fu condotta all'oscurantismo ed alla feroce opposizione a qualsiasi idea o tecnologia moderna, persino in campo bellico, tanto che la Turchia diventò il "malato d'Europa". La Repubblica Turca invece, fondata sull'educazione e sulle idee moderne, può stare alla pari dell'Europa per sviluppo economico e progresso. Dieci anni fa strinse un accordo doganale con l'Unione Europa ed i suoi prodotti riuscirono a tener testa ai migliori manufatti europei. Sebbene quasi del tutto priva di petrolio, il suo PIL è pari alla metà di quello di tutti gli Stati arabi messi assieme. Ma senz'altro l'Europa cosiddetta "laica" non ammetterà Ankara quale membro a pieno diritto, poiché il 99% dei Turchi è musulmano...
L'espansione ed il progresso del Califfato abbasside furono dovuti alle idee, accolte da ogni dove, ed alle nuove invenzioni scientifiche. Le idee conservatrici (ed in particolare la filosofia wahhabita), invece, hanno fatto tornare indietro l'Umma musulmana, rendendola incapace di reggere il confronto con la crescente potenza militare e scientifica dell'Occidente, e quindi inadeguata a liberarsi dalle catene che la imprigionano. Ma quel che importa è che vi sia un gran luccichio d'oro, vetro ed alluminio negli Stati del Golfo ricchi di petrolio...!
L’intreccio precedentemente descritto incanala le ricchezze verso le madrasse, dove si studia a memoria il Corano, ma poca matematica e poca scienza, e le innovazioni sono bandite; la conseguente incapacità d'affrontare i sempre più complessi problemi dei tempi moderni ha fatto rotolare all'indietro i Musulmani. Questa cultura può produrre soltanto al-Qaede, gihadisti e distruzioni, ma non una risposta assennata e scientifica al consumismo ed all'espansione dell'Occidente, che quotidianamente copre d'umiliazioni il mondo arabo e musulmano. Certo si potranno architettare nuovi spettacolari attentati, come l'11 settembre o il 7 luglio, ma questi non libereranno l'Umma dalla dominazione e dallo sfruttamento cui è stata sottoposta negli ultimi due secoli dai cristiani occidentali. C'è un insegnamento che si può trarre dall'attuale miseria e dalle sofferenze infernali che patisce lo sventurato popolo iracheno, posto sotto il tallone dell'occupazione militare statunitense (durante la quale sono morte più di mezzo milione di persone dal marzo 2003). Si prenda l'Iran, dove la politica statunitense ha soltanto rafforzato gli elementi conservatori. Eppure sono anche garantite la libertà e l’istruzione delle donne, che possono lavorare negli uffici e guidare l'automobile. L'ammodernamento promosso dal moderato presidente Khatami è stato solo interrotto dall'irruzione statunitense a due passi da casa, che ha costretto il paese a mettersi sulla difensiva. Il popolo iraniano ha imparato che tornare indietro non risolve né i vecchi problemi né quelli nuovi proposti dall'era moderna: per questo non sopporta più il giogo soffocante dei mullah.
La rottura dell’intreccio statunitense-saudita-wahhabita lascerà libere le masse musulmane, sinora tenute incatenate a idee retrive, e le avvierà verso la moderna educazione, le scienze naturali, le innovazioni ed il progresso in grado di sfidare l'Occidente. Ma lo sconvolgimento portato dalla rivoluzione khomeinista in Iran sembrerà una passeggiata, paragonata a quella che sarà la rivoluzione nell'Islam sunnita, dove l'oscurantismo e gl'interessi particolari (interni ed esterni) non s'arrenderanno facilmente. Forse i tempi tendono ad un cambiamento così cataclismatico.
Prima della Grande Guerra, i Tedeschi progettavano di raggiungere Bassora con una ferrovia, grazie all'appoggio ottomano, in modo da aggirare l'Impero Britannico in India (il gioiello più prezioso della Corona inglese). Dal canto loro gli Ottomani, influenzati dai Giovani Turchi dell'eccentrico Enver Pascià, speravano d'arginare Mosca e creare un impero panturco esteso fino al Turkestan russo. I risultati, però, non corrisposero alle aspettative, ed anzi gettarono le fondamenta per una distruttiva seconda guerra mondiale, per l'ascesa della Germania nazista, per l'olocausto degli Ebrei e degli Zingari in Europa. E pure per la decolonizzazione e la fine degl'imperi britannico, francese ed europei in genere.
(Traduzione di Daniele Scalea)
* K. Gajendra Singh, diplomatico indiano oggi in pensione, è stato ambasciatore in Turchia (e Azerbaigian) dall'agosto 1992 all'aprile 1996; in precedenza aveva ricoperto il medesimo ruolo in Giordania, Romania e Senegal. Attualmente presiede la Foundation for Indo-Turkic Studies. Ha già collaborato a "Eurasia, rivista di studi geopolitici" con diversi contributi: la redazione di quest'ultimo è stata terminata il 30 dicembre 2006.
|




 Het is duidelijk dat we ons al een tijdje in een overgangsfase bevinden, een interregnum: de oude zekerheden van vorige eeuw zijn weggevallen, de opdeling van de wereld in ‘goeden’ – de NAVO, het vrije Westen, West-Europa, Amerika – en de ‘slechten’ – de communistische staten rond de USSR en China – is ongedaan gemaakt, en in de plaats daarvan is een ingewikkelde wereld met veel en tegenstrijdige krachten. China botst met Rusland, Amerika botst met iedereen, China eist een stuk van de markt in Afrika, Rusland zoekt toenadering met Europa, dat nochtans een veilige afstand wil bewaren. De globalisering van de economie – waarvan het einde nu ook al voorspeld wordt door Chinakenner Jacques Martain in De Tijd (06.03.2010) – zorgt ervoor dat nog meer dan vroeger de controle over de energiebronnen een, zoniet dé inzet wordt van de strijd tussen de grote spelers op de wereldmarkt.
Het is duidelijk dat we ons al een tijdje in een overgangsfase bevinden, een interregnum: de oude zekerheden van vorige eeuw zijn weggevallen, de opdeling van de wereld in ‘goeden’ – de NAVO, het vrije Westen, West-Europa, Amerika – en de ‘slechten’ – de communistische staten rond de USSR en China – is ongedaan gemaakt, en in de plaats daarvan is een ingewikkelde wereld met veel en tegenstrijdige krachten. China botst met Rusland, Amerika botst met iedereen, China eist een stuk van de markt in Afrika, Rusland zoekt toenadering met Europa, dat nochtans een veilige afstand wil bewaren. De globalisering van de economie – waarvan het einde nu ook al voorspeld wordt door Chinakenner Jacques Martain in De Tijd (06.03.2010) – zorgt ervoor dat nog meer dan vroeger de controle over de energiebronnen een, zoniet dé inzet wordt van de strijd tussen de grote spelers op de wereldmarkt.

 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg Riparte all’Università di Teramo il “Master Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente”. Nel 2007 era stato chiuso per la nota vicenda Faurisson, per due anni è continuato a Roma sotto l’egida dello Iemasvo, Istituto Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente”, e adesso è di nuovo nell’Ateneo dove era stato inaugurato nel febbraio 2006 con una prolusione di Giulio Andreotti su Enrico Mattei.
Riparte all’Università di Teramo il “Master Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente”. Nel 2007 era stato chiuso per la nota vicenda Faurisson, per due anni è continuato a Roma sotto l’egida dello Iemasvo, Istituto Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente”, e adesso è di nuovo nell’Ateneo dove era stato inaugurato nel febbraio 2006 con una prolusione di Giulio Andreotti su Enrico Mattei. En el informe de mayo de 2001, titulado “Cheney Energy Task Force”, el ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney, explicó abiertamente que el objetivo de la política estadounidense en Iraq, era “[…] abrir áreas del sector energético iraquí a la inversión extranjera”. Una nueva ley del petróleo, propuesta por el gobierno estadounidense y las grandes compañías petroleras, sería el marco “legal” para la venta del petróleo iraquí.
En el informe de mayo de 2001, titulado “Cheney Energy Task Force”, el ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney, explicó abiertamente que el objetivo de la política estadounidense en Iraq, era “[…] abrir áreas del sector energético iraquí a la inversión extranjera”. Una nueva ley del petróleo, propuesta por el gobierno estadounidense y las grandes compañías petroleras, sería el marco “legal” para la venta del petróleo iraquí. Proyectado por Europa para reducir la dependencia energética de Rusia, el gasoducto Nabucco en la región del mar Caspio está lejos aún de materializarse a causa de la escasez de carburante, afirmó hoy un experto europeo.
Proyectado por Europa para reducir la dependencia energética de Rusia, el gasoducto Nabucco en la región del mar Caspio está lejos aún de materializarse a causa de la escasez de carburante, afirmó hoy un experto europeo.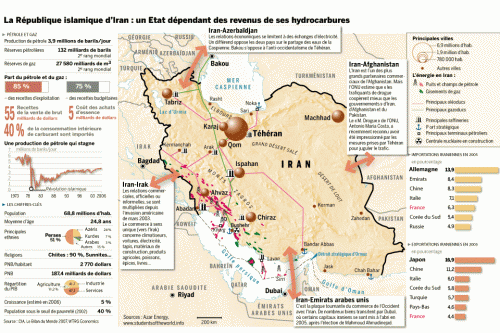
 El líder venezolano dio instrucciones a su gobierno de acelerar la realización del proyecto sobre la construcción por las compañías rusas del complejo de centrales termoeléctricas que funcionan a base de coque de petróleo. El ministro de Energía y Petróleo de Venezuela Rafael Ramírez llegará pronto a Moscú y discutirá este problema con sus colegas rusos.
El líder venezolano dio instrucciones a su gobierno de acelerar la realización del proyecto sobre la construcción por las compañías rusas del complejo de centrales termoeléctricas que funcionan a base de coque de petróleo. El ministro de Energía y Petróleo de Venezuela Rafael Ramírez llegará pronto a Moscú y discutirá este problema con sus colegas rusos. Intesa Italia-Kazakistan nello stile di Enrico Mattei
Intesa Italia-Kazakistan nello stile di Enrico Mattei Teheran, epicentro di un terremoto geostrategico
Teheran, epicentro di un terremoto geostrategico
 Nueva ‘Guerra Fría’ por petróleo del Ártico
Nueva ‘Guerra Fría’ por petróleo del Ártico