jeudi, 21 janvier 2010
L'itinéraired'Otto Strasser
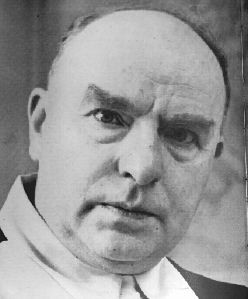 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985
L'itinéraire d'Otto Strasser
par Thierry MUDRY
Un jeune universitaire français, Patrick Moreau, a fait paraître en Allemagne en 1985, une version abrégée de sa thèse de doctorat sur la "Communauté de combat national-socialiste révolutionnaire et le Front Noir" (cette thèse de 821 pages, soutenue en 1978 devant l'Université de Paris 1, n'est malheureusement pas diffusée en France). L'ouvrage de Moreau, très documenté et objectif, comporte une biographie (qui s'arrête en 1935) d'Otto Strasser, leader du nazisme de gauche dissident, une histoire du nazisme de gauche de 1925 à 1938 et une analyse des principaux thèmes constitutifs de l'idéologie "national-socialiste révolutionnaire".
Moreau dévoile l'existence d'un courant qui, se réclamant d'une authenticité national-socialiste, a résisté à la mainmise hitlérienne sur le parti nazi, résisté à l'Etat hitlerien et combattu vainement pour une Révolution socialiste allemande. L'histoire de ce courant s'identifie au destin de son principal animateur et idéologue : Otto Strasser.
Antécédents familiaux
Otto Strasser naît le 10 septembre 1897 dans une famille de fonctionnaires bavarois. Son frère Gregor (qui sera l'un des chefs du parti nazi et un concurrent sérieux d'Hitler) est son aîné de cinq ans. L'un et l'autre bénéficient de solides antécédents familiaux: leur père Peter, qui s'intéresse à l'économie politique et à l'histoire, publie sous le pseudonyme de Paul Weger, une brochure intitulée "Das neue Wesen", dans laquelle il se prononce pour un socialisme chrétien et national. Selon Paul Strasser, frère de Gregor et d'Otto: "dans cette brochure se trouve déjà ébauché l'ensemble du programme culturel et politique de Gregor et d'Otto, à savoir un socialisme chrétien et national, qui y est désigné comme la solution aux contradictions et aux manques nés de la maladie libérale, capitaliste et internationale de notre temps". (Cité, p. 12).
Otto Strasser social-démocrate
Lorsqu'éclate la Grande Guerre, Otto Strasser interrompt ses études de droit et d'économie pour s'engager, dès le 2 août 1914 (il est le plus jeune engagé volontaire de Bavière). Sa brillante con-duite au Front lui vaudra d'être décoré de la Croix de Fer de première classe et d'être proposé pour l'Ordre Militaire de Max-Joseph. Avant sa démobilisation en avril/mai 1919, il participe, avec son frère Gregor, dans le Corps-Franc von Epp, à l'assaut contre la République soviétique de Bavière. Rendu à la vie civile, Otto re-prend ses études à Berlin en 1919 et fonde l'"Association universitaire des an-ciens combattants sociaux-démocrates". En 1920, à la tête de trois "centuries pro-létariennes", il résiste dans le quartier ouvrier berlinois de Steglitz au putsch Kapp (putsch d'extrême-droite). Il quitte peu après la SPD (parti social-démocrate) lorsque celle-ci refuse de respecter l'ac-cord de Bielefeld conclu avec les ouvriers de la Ruhr (cet accord prévoyant la non-intervention de l'armée dans la Ruhr, la répression des éléments contre-révolu-tionnaires et l'éloignement de ceux-ci de l'appareil de l'Etat, ainsi que de la natio-nalisation des grandes entreprises). Otto Strasser s'éloigne donc de la SPD sur la gauche.
Otto Strasser retourne en Bavière. Chez son frère Gregor, il rencontre Hitler et le général Ludendorff, mais refuse de se rallier au national-socialisme comme l'y invite son frère. Correspondant de la presse suisse et hollandaise, Otto "cou-vre", le 12 octobre 1920, le Congrès de l'USPD (Parti social-démocrate indépen-dant) à Halle où il rencontre Zinoviev. Il écrit dans "Das Gewissen", la revue des jeunes conservateurs Moeller van den Bruck et Heinrich von Gleichen, un long article sur sa rencontre avec Zinoviev. C'est ainsi qu'il fait la connaissance de Moeller van den Bruck qui le ralliera à ses idées.
Otto Strasser rentre peu après au ministère de l'approvisionnement, avant de travailler, à partir du printemps 1923, dans un consortium d'alcools. Entre 1920 et 1925, il s'opère dans l'esprit de Stras-ser un lent mûrissement idéologique sur fond d'expériences personnelles (expé-rience du Front et de la guerre civile, ren-contres avec Zinoviev et Moeller, expé-rience de la bureaucratie et du capita-lisme privé) et d'influences idéologiques diverses.
Otto Strasser National-Socialiste
Après le putsch manqué de 1923, l'em-prisonnement de Hitler et l'interdiction de la NSDAP qui l'ont suivi, Gregor Stras-ser s'est retrouvé en 1924 avec le général Ludendorff et le politicien völkisch von Graefe à la tête du parti nazi reconstitué. Aussitôt sorti de prison, Hitler réorga-nise la NSDAP (février 1925) et charge Gregor Strasser de la direction du Parti dans le Nord de l'Allemagne. Otto rejoint alors son frère qui l'a appelé auprès de lui. Otto sera l'idéologue, Gregor l'organi-sateur du nazisme nord-allemand.
En 1925, une "Communauté de travail des districts nord- et ouest-allemands de la NSDAP" est fondée sous la direction de Gregor Strasser, ces districts mani-festent ainsi leur volonté d'autonomie (et de démocratie interne) face à Munich. En outre, la NSDAP nord-allemande prend une orientation nettement gauchiste sous l'influence d'Otto Strasser et de Joseph Goebbels, qui exposent leurs idées dans un bimensuel destiné aux cadres du Parti, les "National-sozialistische Briefe". Dès oc-tobre 1925, Otto Strasser dote la NSDAP nord-allemande d'un programme radical.
Hitler réagit en déclarant inaltérables les vingt-cinq points du programme nazi de 1920 et en concentrant tous les pou-voirs de décision dans le Parti entre ses mains. Il rallie Goebbels en 1926, circon-vient Gregor Strasser en lui proposant le poste de chef de la propagande, puis de chef de l'organisation du Parti, exclut en-fin un certain nombre de "gauchistes" (no-tamment les Gauleiters de Silésie, Po-méranie et Saxe). Otto Strasser, isolé et en opposition totale avec la politique de plus en plus ouvertement conservatrice et pro-capitaliste de Hitler, se résoud fina-lement à quitter le Parti Nazi le 4 juillet 1930. Il fonde aussitôt la KGRNS, "Com-munauté de combat national-socialiste révolutionnaire".
Otto Strasser dissident
Mais, peu après la scission stras-serienne, deux événements entraînent la marginalisation de la KGNRS: tout d'abord la publication de la "déclaration-pro-gramme pour la libération nationale et sociale du peuple allemand" adoptée par le Parti Communiste allemand. Ce program-me exercera une attraction considérable sur les éléments nationalistes allemands anti-hitleriens et les détournera du Strasserisme (d'ailleurs dès l'automne 1930, une première crise "national-bolchévique" provoque le départ vers le Parti Communiste de trois responsables de la KGRNS : Korn, Rehm et Lorf); ensuite, le succès électoral du Parti Nazi lors des élections législatives du 14 septembre 1930 qui convainc beaucoup de nationaux-socialistes du bien fondé de la stratégie hitlerienne. La KGRNS est minée, en outre, par des dissensions internes qui opposent ses éléments les plus radicaux (natio-naux-bolchéviques) à la direction, plus modérée (Otto Strasser, Herbert Blank et le Major Buchrucker).
Otto Strasser essaie de sortir la KGRNS de son isolement en se rappro-chant, en 1931, des S.A. du nord de l'Alle-magne, qui, sous la direction de Walter Stennes, sont entrés en rébellion ouverte contre Hitler1 (mais ce rapprochement, mené sous les hospices du capitaine Ehr-hardt, dont les penchants réactionnaires sont connus, provoque le départ des na-tionaux-bolchéviques de la KGRNS). En octobre 1931, Otto Strasser fonde le "Front Noir", destiné à regrouper autour de la KGNRS un certain nombre d'organisa-tions proches d'elle, telles que le groupe paramilitaire "Wehrwolf", les "Camara-deries Oberland", les ex-S.A. de Stennes, une partie du Mouvement Paysan, le cercle constitué autour de la revue "die Tat", etc.
En 1933, décimée par la répression hitlerienne, la KGRNS se replie en Autri-che, puis, en 1934, en Tchécoslovaquie. En Allemagne, des groupes strasseriens clandestins subsisteront jusqu'en 1937, avant d'être démantelés et leurs membres emprisonnés ou déportés (l'un de ces an-ciens résistants, Karl-Ernst Naske, dirige aujourd'hui les "Strasser-Archiv"2).
L'idéologie strassérienne
Les idées d'Otto Strasser transparais-sent dans les programmes qu'il a élabo-rés, les articles, livres et brochures que ses amis et lui-même ont écrit. Parmi ces textes, les plus importants sont le pro-gramme de 1925 (résumé P.23), destiné à compléter le programme de 1920 du Parti Nazi, la proclamation du 4 juillet 1930 ("Les socialistes quittent la NSDAP" P.41/42), les "Quatorze thèses de la Ré-volution allemande", adoptées lors du pre-mier Congrès de la KGRNS en octobre 1930 (PP. 240 à 242), le manifeste du "Front Noir", adopté lors du deuxième Congrès de la KGRNS en octobre 1931 (pp. 250/251), et le livre "Construction du So-cialisme allemand", dont la première édi-tion date de 1932.
Une idéologie cohérente se dégage de ces textes, composée de trois éléments étroitement imbriqués: le nationalisme, l'"idéalisme völkisch" et le "socialisme allemand".
* Le nationalisme: Otto Strasser pro-pose la constitution d'un Etat (fédéral et démocratique) grand-allemand "de Memel à Strasbourg, d'Eupen à Vienne" et la li-bération de la Nation allemande du traité de Versailles et du plan Young. Il prône une guerre de libération contre l'Occident ("Nous saluons la Nouvelles Guerre" pp. 245/246), l'alliance avec l'Union sovié-tique et une solidarité internationale an-ti-impérialiste entre toutes les Nations opprimées. Otto Strasser s'en prend aussi avec vigueur aux Juifs, à la Franc-maçon-nerie et à l'Ultramontanisme (cette dé-nonciation des "puissances internatio-nales" semble s'inspirer des violents pamphlets du groupe Ludendorff). Mais les positions d'Otto Strasser vont évoluer. Lors de son exil en Tchécoslovaquie, deux points nouveaux apparaissent: un certain philosémitisme (Otto Strasser propose que soit conféré au peuple juif un statut protecteur de minorité nationale en Euro-pe et soutient le projet sioniste - Patrick Moreau pense que ce philosémitisme est purement tactique: Strasser cherche l'ap-pui des puissantes organisations anti-nazies américaines) et un projet de fédé-ration européenne qui permettrait d'éviter une nouvelle guerre (pp. 185/186). L'anti-occidentalisme et le pro-soviétisme de Strasser s'estompent.
- Au matérialisme bourgeois et mar-xiste, Otto Strasser oppose un "idéalisme völkisch" à fondement religieux.
- A la base de cet "idéalisme völ-kisch", on trouve le "Volk" conçu comme un organisme d'origine divine possédant des caractéristiques de nature physique (raciale), spirituelle et mentale.
La "Révolution allemande" doit, selon Otto Strasser, (re)créer les "formes" ap-propriées à la nature du peuple dans le domaine politique ou économique aussi bien que culturel. Ces formes seraient, dans le domaine économique, le fief (Erb-lehen); dans le domaine politique, l'auto-administration du peuple au moyen des "Stände", c'est-à-dire des états - état ou-vrier, état-paysan, etc. (ständische Selbstverwaltung) et, dans le domaine "culturel", une religiosité allemande 3.
- Principale expression de l'"idéalisme völkisch": un "principe d'amour" au sein du Volk - chacun reconnaissant dans les au-tres ses propres caractéristiques racia-les et culturelles (pp. 70 et 132) - qui doit marquer chaque acte de l'individu et de l'Etat.
Cet idéalisme völkisch entraîne le re-jet par Otto Strasser de l'idée de la lutte des classes au sein du Volk au profit d'une "révolution populaire" des ouvriers-pay-sans-classes moyennes (seule une toute petite minorité d'oppresseurs et d'exploi-teurs seraient éliminés), la condamnation de l'affrontement politique entre Alle-mands: Otto Strasser propose un Front uni de la base des partis extrémistes et des syndicats contre leur hiérarchie et contre le système (pp.69/70). Cet idéalisme völ-kisch sous-tend l'esprit du "socialisme allemand" prôné par Strasser et inspire le programme socialiste strasserien.
Le programme socialiste strasserien comporte les points suivants: la natio-nalisation (partielle) de la terre et des moyens de production, la participation ouvrière, le Plan, l'autarcie et le mono-pole de l'Etat sur le commerce extérieur.
Le "socialisme allemand" prétend s'op-poser au libéralisme comme au marxisme. L'opinion d'Otto Strasser sur le marxisme est cependant nuancée: "Le marxisme n'a-vait pour Strasser aucun caractère 'juif' spécifique comme chez Hitler, il n'était pas "l'invention du Juif Marx", mais l'éla-boration d'une méthode d'analyse des con-tradictions sociales et économiques de son époque (la période du capitalisme sauvage) mise au point par un philosophe doué. Strasser reconnaissait à la pensée marxiste aussi bien qu'à l'analyse de l'im-périalisme par Lénine une vérité objec-tive certaine. Il s'éloignait de la Weltan-schauung marxiste au niveau de ses im-plications philosophiques et utopiques. Le marxisme était le produit de l'ère du li-béralisme et témoignait dans sa méthode analytique et dans sa structure même d'une mentalité dont la tradition libérale remontait au contrat social de Rousseau.
L'erreur de Marx et des marxistes-lé-ninistes résidait, selon Strasser, en ce qu'ils croyaient pouvoir expliquer le déve-loppement historique au moyen des con-cepts de rapport de production et lutte de classes alors que ceux-ci n'apparais-saient valables que pour la période du ca-pitalisme. La dictature du prolétariat, l'internationalisme prolétarien, le com-munisme utopique n'étaient plus con-formes à une Allemagne dans laquelle un processus d'entière transformation des structures spirituelles, sociales et éco-nomiques était engagé, qui conduisait au remplacement du capitalisme par le so-cialisme, de la lutte des classes par la communauté du peuple et de l'internatio-nalisme par le nationalisme.
La théorie économique marxiste de-meurait un instrument nécessaire à la compréhension de l'histoire. Le marxisme philosophique et le bolchévisme de parti périssaient en même temps qu'un libéra-lisme entré en agonie" (pp 62/63).
Le "socialisme allemand" rejette le modèle prolétarien aussi bien que le mo-dèle bourgeois et propose de concilier la responsabilité, l'indépendance et la créa-tivité personnelles avec le sentiment de l'appartenance communautaire dans une société de travailleurs de classes moyen-nes et, plus particulièrement, de paysans (P.135). "Strasser, comme Jünger, rêva d'un nouveau "Travailleur", mais d'un type particulier, le type "Paysan", qu'il soit ouvrier paysan, intellectuel paysan, sol-dat paysan - autant de facettes d'un bouleversement social réalisé par la dislocation de la société industrielle, le démantèlement des usines, la réduction des populations urbaines et les transferts forcés de citoyens vers le travail régé-nérateur de la terre. Pour prendre des il-lustrations contemporaines de la volonté de rupture sociale de la tendance Stras-ser, certains aspects de son projet évo-quent aujourd'hui la Révolution Culturelle chinoise ou l'action des Khmers Rouges au Cambodge" (cf. Patrick Moreau "Socia-lisme national contre hitlerisme" dans La Revue d'Allemagne, tome XVI, n°3, Juillet-septembre 1984, P.493). Otto Strasser veut réorganiser la société alle-mande autour du type paysan. Pour ce fai-re, il préconise le partage des terres, la colonisation des régions agricoles de l'Est peu peuplées et la dispersion des grands complexes industriels en petites unités à travers tout le pays - ainsi naîtrait un type mixte ouvrier-paysan (cette dernière proposition évoque l'expérience des "hauts-fourneaux de poche" dans les com-munes populaires de la Chine commu-niste), PP.134 à 140. Patrick Moreau n'hé-site pas à qualifier Otto Strasser de "con-servateur agraire extrémiste" (article ci-té). Les conséquences de cette réorgani-sation de l'Allemagne (et de la socialisa-tion de l'économie qui doit l'accompagner) seraient: une réduction considérable de la production des biens de consommation du fait de l' "adoption d'un mode de vie spar-tiate où la consommation est réduite à la satisfaction quasi autarcique, au plan lo-cal, des besoins primaires" (article cité) et "l'institution nationale, puis interna-tionale, d'une sorte d'économie de troc" (Ibid.).
Le "socialisme allemand" refuse enfin la bureaucratie et le capitalisme privé (Otto Strasser connaît les méfaits des deux systèmes) et propose la nationali-sation des moyens de production et de la terre qui seraient ensuite (re)distribués à des entrepreneurs sous la forme de fiefs. Cette solution conjuguerait, si l'on en croit Strasser, les avantages de la pos-session individuelle et de la propriété collective.
Thierry MUDRY.
Patrick MOREAU, "Nationalsozialismus von links. Die "Kampfgemeinschaft Revo-lutionärer Nationalsozialisten" und die "Schwarze Front" Otto Strassers 1930-1935", Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1985, 268 S., 39,80 DM.
Notes :
1 Sur Walter Stennes : lire "Als Hitler nach Canossa ging" de Charles Drage (Berlin 1982)
2 "Strasser Archiv, correspondance : Karl-Ernst Naske, 5350 EUSKIRCHEN-Kreuzweingarten, R.F.A.
3 Cfr. "Weder Rom noch Moskau, sondern Deutschland, nichts als Deutschland", article d'Otto Strasser dans "Deutsche Revolution", 5 juillet 1931.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne, weimar, années 20, années 30, national-socialisme, dissidence |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 20 janvier 2010
Vus d'Alsace: les rapports franco-allemands
 Archives de SYNERGIES EUROPENNES
Archives de SYNERGIES EUROPENNES
Vus d’Alsace:
les rapports franco-allemands
L’écrivain alsacien Martin Graff a publié depuis quatre ans trois livres chez l’éditeur Knesebeck, producteurs de très beaux livres d’art ou de photographie, notamment les portraits d’écrivains réalisés par la photographe Isolde Ohlbaum, dont le talent est véritablement époustouflant. La position de Graff est intéressante à plus d’un titre quand il juge les Français (de l’intérieur) et les Allemands: né dans un pays qui a été plusieurs fois bousculé d’un côté à l’autre, il connaît les insuffisances et les atouts des uns et des autres. Son bilinguisme parfait lui donne une lucidité extraordinaire, que les unilingues sont incapables d’imiter ou de capter. Graff se moque de ces lourdeaux gaulois ou germaniques qui affirment être les meilleurs amis du monde, sans être même capables de se comprendre réellement. Graff est tout naturellement européiste, car il l’est dans sa chair, par son travail quotidien dans les instituts radiophoniques (ARD, ZDF, ARTE). Quant à l’Europe technocratique de Maastricht, elle est affirmée par des politiciens qui ne connaissent pas spontanément la pluralité européenne. Graff a raison: la construction européenne doit être laissée aux gens sérieux, aux ressortissants de la ligne de fracture, aux bilingues nés (Martin Graff, Nackte Wahrheiten. Deutsche und Franzosen, ISBN 3-926901-72-1, DM 34, Knesebeck Verlag, Holzstrasse 26, D-80.469 München).
Dans un deuxième ouvrage, Graff étudie le passage sans heurt de l’Alsace de la germanité à la romanité française après 1945. Cet événement extraordinaire, unique en Europe, repose sur des sentiments que Graff discerne très clairement: les Allemands aiment l’Alsace, ils trouvent extraordinaire qu’elle ait gardé son identité germanique tout en adoptant la langue française. Mais les Alsaciens n’aiment pas être considérés comme les reliques d’une germanité idyllique et révolue: ils veulent que les Allemands les prennent au sérieux, cessent de voir en leur pays une “fata morgana gastronomico-touristique”. De même, l’Alsacien est agacé de devoir, en France comme en Allemagne, répondre à une image stéréotypée, élaborée dans des officines propagandistes depuis 1871. L’Alsacien n’est pas un patriote français portant des costumes folkloriques originaux et sympathiques (comme les chapeaux ronds des Bretons) ni un Allemand martyr, auquel on a confisqué de force sa germanité: il est un pont entre la France et l’Allemagne, le trait d’union indispensable dans une Europe en formation, donc un être d’avenir et non pas une relique (Martin Graff, Von Liebe keine Spur. Das Elsaß und die Deutsche, ISBN 3-926901-87-X, DM 39,80, Knesebeck, München, adresse supra).
Cette année, Martin Graff a changé de sujet, tout en assumant pleinement sa fonction d’Alsacien-pontifex, d’Alsacien qui jette des ponts au-dessus des mosaïques européennes. Le thème de son dernier livre est capital: il traite du Danube, du plus long fleuve d’Europe, qui est redevenu de fait son épine dorsale. Les riverains du Danube, écrit Graff, peuvent enfin se remettre à rêver, après la chute du Rideau de Fer. Ce livre sur le Danube est le résultat d’un reportage effectué par Graff pour le compte de la télévision allemande ZDF: il s’agissait de remonter le Danube, depuis son delta sur les rives de la Mer Noire jusqu’à sa source dans la Forêt Noire, à un jet de pierre de l’Alsace natale de Graff. Tous les peuples riverains du Danube sont confrontés d’une façon ou d’une autre à la mutliplicité, à la diversité fécondante des peuples et des cultures autochtones, que les machines étatiques rigides ou le libéralisme universaliste et consumériste veulent mettre au pas, diluer et effacer définitivement. Graff chante les mérites d’une multiculturalité enracinée et non d’une multiculturalité d’importation, en vrac, dans le désordre, incapable de s’organiser sinon dans de glauques réseaux mafieux. Claudio Magris avait chanté la fécondité littéraire des bords du Danube; Graff se penche davantage sur les hommes concrets, libérés du carcan marxiste, désillusionés par les belles promesses du libéralisme occidental qui leur a fait miroiter des villas californiennes et de luxueuses BMW et ne leur a donné que l’endettement et le chômage. La diversité danubienne, celle de son delta où Arméniens, Grecs, Turcs, Tatars, Italiens, Macédoniens, Gagaouzes, Circassiens, Kazakhs, Russes, Roumains, Moldaves, Valaques, Caucasiens, Tziganes, Bulgares, etc. vivent côte à côte dans la paix, est un tour de force, sans doute une imbrication pluriethnique unique au monde, mais elle est possible parce que personne là-bas n’ignore fondamentalement l’autre, connaît sa langue et sa culture, parce que le paysage extraordinaire du delta, porte de l’Europe pour les Caucasiens et les Anatoliens, leur a octroyé un destin commun. Graff nous lègue là une géoethnologie du Danube (M. Graff, Donauträume. Stromaufwärts nach Europa, ISBN 3-89660-044-3, DM 39,80, Knesebeck Verlag, München, adresse supra) (Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : terres d'europe, alsace, france, allemagne, europe, affaires européennes, régions, régionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 15 janvier 2010
Entretien avec Hellmut Diwald
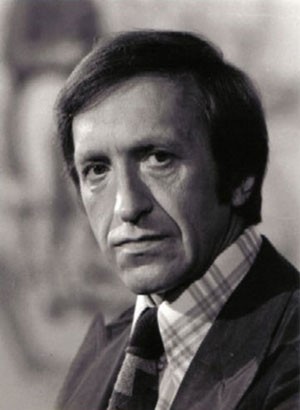 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1992
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1992
Entretien avec Hellmut DIWALD
propos recueillis par Irmhild DESCHNER et Peter BOSSDORF
Hellmut Diwald, né en 1929 en Moravie méridionale, a passé sa jeunesse à Prague et à Nuremberg. Après avoir achevé des études d'ingénieur en 1950, il obtient un diplôme d'histoire et un autre de philosophie en 1953. Depuis 1965, il enseigne l'histoire moderne et contemporaine à l'Université d'Erlangen-Nuremberg. Hellmut Diwald a acquis la célébrité en 1969, quand il a fait paraître une biographie de Wallenstein, et en 1978, en publiant une Histoire des Allemands (Geschichte der Deutschen), qui provoqua un grand scandale, qui annonçait, huit ans à l'avance, la célèbre «querelle des historiens». Dans les années 80, Diwald a écrit et publié une quantité d'études, soulignant l'actualité de la question allemande.
ID/PB: Professeur, la fin de la guerre froide signifie-t-elle également la fin des problèmes de politique extérieure ou, au contraire, ces problèmes de politique extérieure se posent-ils dorénavant avec une acuité plus intense encore?
HD: On peut répondre par l'affirmative à vos deux questions. La fin de la guerre froide transforme globalement la politique internationale. Et la situation nouvelle est, à certains égards, bien plus imprévisible, car le nombre de dangers a cru: on l'a vu notamment quand Ukrainiens et Russes se sont querellés à propos de la flotte de la Mer Noire. Nous assisterons sans doute à l'éclosion de nouveaux conflits ailleurs, vu l'évolution qui se dessine dans le monde musulman. On peut le deviner avec ce qui s'est passé en Algérie.
ID/PB: Peut-on dire que les politiques suivies par les nouveaux Etats né sur le sol de l'ex-URSS sont dictées par des motivations nationales ou s'agit-il d'une tentative de faire passer dans le réel les valeurs occidentales?
HD: Pour moi, il s'agit surtout d'un retour à soi, à sa propre culture. Je ne parle pas de «valeurs occidentales» quand j'évoque les peuples d'Europe de l'Est ou de la CEI, ou quand je parle de leurs «nationalismes», car je n'oublie pas qu'en Union Soviétique, c'était une idéologie de facture occidentale qui était au pouvoir.
ID/PB: Pour nous Allemands, ce retour des peuples de l'Est européen à eux-mêmes, à leurs propres référents culturels, est-ce un signe positif?
HD: C'est un signe positif et prometteur. Dans la mesure où nous aussi, après la réunification partielle de l'Allemagne, ne souffrons plus, en tant que peuple ou partie de peuple, de l'étouffante pression marxiste ni de la doctrine d'Etat de l'ex-RDA. Pour nous aussi, la chute du Rideau de fer signifie le retour à une conscience de soi, qui nous apparaît sous des formes nouvelles, que nous avons encore à définir, à préciser.
ID/PB: Y a-t-il en Russie des traditions culturelles spécifiques qui peuvent spontanément s'aligner sur les conceptions occidentales de la démocratie et des droits de l'homme?
HD: Si ces traditions n'existent pas, ce n'est pas à nous de les imposer. C'est aux Russes à les faire advenir chez eux.
ID/PB: Ne court-on pas le danger, vu la disparité des moyens techniques et militaires modernes, que les Etats nationaux basculent dans une dépendance plus grande encore que par le passé?
HD: C'est possible, effectivement. Mais le danger de plus grande dépendance guettera surtout les Etats et les peuples de l'ex-URSS. Mais le plus gros problème, pour moi, c'est de savoir comment on va procéder pour imposer l'économie de marché dans ces pays. N'oublions pas que nous avons affaire à un pays où il n'y a jamais eu de classe moyenne, de bourgeoisie (au sens positif et industrieux du terme), pendant des décennies voire des siècles, si l'on inclut l'ère des Tsars. Jamais ces peuples n'ont appris à être autonomes.
ID/PB: L'Allemagne doit-elle s'engager politiquement ou économiquement dans ces régions?
HD: Economiquement, oui. Mais je reste très dubitatif quant aux chances de succès.
ID/PB: Mais n'y a-t-il pas de risques pour l'Allemagne, si elle prend des initiatives dans la CEI ou ailleurs? Par exemple, la prompte reconnaissance de la Slovénie et de la Croatie par l'Allemagne a exposé cette dernière à un risque: s'aliéner les Etats occidentaux.
HD: Pour moi, c'est un risque que nous ne devons même pas prendre en considération. Ce que la CEE a fait dans le cas yougoslave relève davantage de la farce que d'une politique précise, qui sait quels sont ses objectifs. Quand des peuples comme les Croates ou les Slovènes mettent si nettement à l'avant-plan leur droit à l'auto-détermination et leur identité et perçoivent ce droit et cette identité comme un droit de la personne humaine, il est normal, pour des motifs tant d'ordre moral que d'ordre politique, que nous ne nous adressions pas à nos voisins, pour leur demander s'ils sont d'accord ou non que nous reconnaissions ces principes. Nous avons toujours trop longtemps attendu avant de donner notre avis. Evidemment, en disant haut et clair son avis, on ne se fait pas toujours des amis. Mais cela n'a aucune importance: l'espace du politique est un espace où personne n'a des amis.
ID/PB: Mais ce que vous nous dites là, est-ce de la Realpolitik? Ne doit-on pas, en première instance, se ranger aux côtés des Etats dont on dépend le plus?
HD: Dans quelques mois, la situation en Yougoslavie sera telle que l'avait prévue, en pionnier, le gouvernement de la République Fédérale. L'éclatement de la Yougoslavie est désormais un fait acquis: les problèmes actuels, aussi tragiques sont-ils, dérivent d'une contestation globale du tracé des frontières. Et la CEE devra se rendre à l'évidence. Ensuite, nous, Allemands, qui avons toujours été la locomotive de l'Europe, n'avons pas sans cesse à dire: si vous n'êtes pas de notre avis, c'est avec plaisir que nous allons tout de suite nous aligner sur vos positions. Les Hollandais ou les Belges pensent-ils qu'ils vont se heurter à nous, s'ils ne sont pas tout-à-fait sur la même longueur d'onde que nous? Non! Il est dans notre intérêt que les Croates et les Slovènes se considèrent comme des partenaires de l'Allemagne. Alors pourquoi n'aurions-nous pas agi comme nous avons agi?
ID/PB: Mais en agissant de la sorte, ne risque-t-on pas de freiner ou de menacer le processus d'intégration à l'œuvre au sein de la CEE?
HD: Si le processus d'intégration est menacé par de telles décisions, c'est qu'il ne vaut rien. Par ailleurs, je voudrais tout de même vous signaler que le processus d'intégration européenne est menacé par des dangers pires; la décision allemande de reconnaître la Croatie et la Slovénie a certes été une décision de haute politique, que la RFA a osé, en pionnière, prendre seule, mais c'était aussi une décision que pas un seul Etat européen ne pouvait, à longue échéance, omettre de prendre. Personne ne pouvait indéfiniment se boucher les oreilles et fermer les yeux.
ID/PB: Mais l'éclatement de la Yougoslavie ne risque-t-il pas de poser un précédent, que craignent, pour de bonnes raisons, plusieurs Etats de l'Europe de l'Ouest?
HD: Ce n'est pas notre problème. L'Allemagne a aussi ses minorités ethniques et elles ne posent pas de problèmes. Prenons l'exemple de la minorité danoise du Nord du pays: elle dispose de droits clairement définis. Et les réglementations qui gèrent cette minorité sont exemplaires; le monde entier pourrait les imiter. Si les Tyroliens du Sud recevaient de Rome ce que nous accordons aux Danois du Slesvig, ils seraient heureux.
ID/PB: Dans le Traité qui sanctionne la réunification, on a expressément rénoncé, pour la première fois, aux régions d'Allemagne orientale (Poméranie, Silésie, Prusse orientale, etc.). En 1992, l'Allemagne aura-t-elle encore intérêt à réclamer ces régions devenues sous-développées du point de vue économique et très abîmées sur le plan écologique?
HD: La décision politique qui a été prise à Bonn n'est qu'un aspect de la problématique, l'aspect extérieur. Pour moi, qui suis historien, je vois les choses d'une toute autre façon, évidemment. Quand il est question de la Silésie et qu'on me demande qui sont les Silésiens, je ne peux bien sûr pas répondre que ce sont des Polonais qui viennent de Pologne. Vous comprenez bien que ça ne va pas, qu'il est exclu de poser une telle assertion, qui va à l'encontre de toute vérité historique. En revanche, on peut dire: oui, en 1991, ces régions ont été cédées en vertu de plusieurs traités; et j'ajouterais, personnellement: elles ont été cédées par nécessité. On nous a imposé le dilemme suivant: vous ne pourrez vous réunir, si vous ne renoncez pas expressément à ces territoires. Mais, l'histoire étant ce qu'elle est, c'est-à-dire un théâtre où surgit constamment l'imprévu, on ne peut pas encore dire avec certitude ce qu'il adviendra de la partie septentrionale de la Prusse orientale, après l'effondrement de l'URSS.
ID/PB: Peut-on encore parler aujourd'hui de sérieux conflits de frontières, mis à part ce qui se passe dans les pays du tiers-monde ou dans les Etats pluri-ethniques en phase de dissolution?
HD: A l'intérieur de l'Europe, les questions de frontières ne sont plus aussi importantes qu'elles ne l'ont été: c'est l'un des rares points positifs de l'intégration européenne.
ID/PB: Y a-t-il encore place en Europe, aujourd'hui, pour des conceptions ou des projets nationaux-étatiques ou stato-nationaux?
HD: Ce que l'on tente de définir comme «régionalisme», n'est rien d'autre qu'une revendication véhémente des groupes ethniques qui affirment ou veulent affirmer leur identité. Pourquoi ces groupes ethniques veulent-ils disposer de leur propre gouvernement? Pourquoi les Croates voudraient-ils leur propre gouvernement, si leur identité ne leur tenait pas à cœur?
ID/PB: N'y a-t-il pas là des motivations économiques qui entrent en ligne de compte?
HD: Non, ce sont des motivations historiques, religieuses, culturelles. Entre la Serbie et la Croatie, il y avait, jadis, un frontière très significative; la Serbie était perçue comme une zone intermédiaire entre l'Europe et le monde ottoman, tandis que la Croatie et la Slovénie faisaient partie de la monarchie austro-hongroise. Serbes et Croates ont été profondément déterminés par leurs destins historiques, très différents l'un de l'autre. Slovènes et Croates se sentent proches des Allemands, dont ils ont longtemps partagé l'histoire. Les choses se sont compliquées peu avant la première guerre mondiale: les Serbes ont rêvé de construire un royaume grand-serbe, en se soumettant tous les petits peuples ou minorités qui vivaient sur leur territoire ou aux alentours. La question qui se pose: cette volonté correspond-elle à l'idée que nous nous faisons de la justice?
ID/PB: Peut-on dès lors parler d'un retour de l'idée stato-nationale classique?
HD: Je ne crois pas. Nous n'assistons pas, je pense, au retour de la vieille conception de l'Etat-Nation, doté de droits de souveraineté, au sens classique du terme. Rien que parce qu'il y a imbrication étroite des économies les unes dans les autres, la souveraineté de chaque Etat est considérablement limitée; mais, en même temps, nous constatons que les pouvoirs exécutifs et législatifs sont demeurés intacts. Où trouve-t-on en Europe cette promptitude à renoncer à ses propres droits de souveraineté, que l'on observe chez nous? Evidemment, nous, Allemands, avons toujours trouvés qu'il était facile de renoncer à ses droits de souveraineté parce que depuis 1945, nous n'en avons plus.
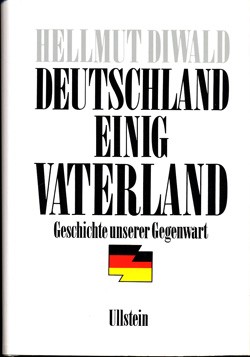 ID/PB: Aujourd'hui, une bonne part du travail législatif se fait au niveau européen...
ID/PB: Aujourd'hui, une bonne part du travail législatif se fait au niveau européen...
HD: Oui mais ce travail législatif concerne essentiellement le domaine économique. Ce n'est pas pour rien que les politiciens de Bonn ont été déçus par les décisions de Maastricht; en effet, pratiquement rien n'a été fait dans le domaine institutionnel. Le gouvernement de Bonn a raconté partout, à grand renfort de publicité, que Maastricht a été un gros succès. Dans le fond, ça a été un bide complet.
ID/PB: Néanmoins, l'Allemagne joue un rôle directeur en Europe. Les vaincus de la seconde guerre mondiale sont-ils les vainqueurs de l'après-guerre?
HD: On résume souvent la situation par cette formule. A croire que, si une troisième guerre mondiale éclate, il vaudrait mieux se trouver dans le camp des vaincus.
ID/PB: La réunification semble donner raison aux adénaueriens et aux «atlantistes» qui préconisaient une politique dure contre l'URSS. Pensez-vous qu'une politique de «neutralisation» de l'Allemagne, comme le voulaient une certaine gauche et une certaine droite nationale, aurait prolongé inutilement la vie de l'URSS moribonde?
HD: Je ne crois pas que les atlantistes aient eu raison, ni d'ailleurs les protagonistes de la politique adenauerienne. Ceux qui le pensent interprètent mal les réalités politiques, géopolitiques et militaires. Si l'Allemagne avait opté pour la neutralité, l'URSS n'aurait eu aucun sursis complémentaire. Le système soviétique ne fonctionnait pas, avec ou sans guerre froide. Notre après-guerre a connu des phases de répit, où il n'y a pas eu la moindre course aux armements; pendant ces périodes de répit, l'URSS n'a pas progressé.
ID/PB: Après l'effondrement du communisme, peut-on encore parler d'un «ordre mondial»?
HD: Non, on assistera peut-être à des esquisses d'ordre mondial, mais non dans le sens où l'on pourrait dire: voilà, ceci est une construction équilibrée et harmonieuse, qui ne pose plus que quelques problèmes en certains points de friction. Observons la réalité contemporaine: l'Amérique est désormais incapable de faire face à ses propres problèmes intérieurs.
ID/PB: Et l'Allemagne, parvient-elle à résoudre les siens?
HD: Votre question peut nous amener à de très longs développements. Surtout dans le domaine de la consolidation juridique et constitutionnelle de la sphère politique. Je ne suis pas un théoricien de l'Etat. Mais je constate, comme beaucoup de mes concitoyens, que, manifestement, il y a quelque chose qui ne va pas en Allemagne, que nous, citoyens allemands, traitons notre communauté politique à la légère, sans la moindre gravité. J'ai un jour eu une formule ironique: notre rapport le plus intense à l'Etat concerne la législation fiscale, la réglementation de la circulation routière et le service militaire. Tout le reste nous est égal. L'Etat ne semble pas s'intéresser au citoyen individuel concret, car il table sur le citoyen majeur et émancipé. Mais l'Etat n'a jamais clairement défini ce qu'est exactement le citoyen majeur et émancipé, si ce n'est par des formules toute faites. Mais peut-on rencontrer quelque part, cet homme libre, responsable, etc., capable de prendre des décisions en toute sérénité et en toute liberté?
ID/PB: Mais n'est-ce pas précisément la rétention de cet Etat qui le rend si attachant?
HD: Non. Cette rétention sera exaltée parce qu'elle permet la liberté mais je ne crois pas que cela suffise pour donner à l'Etat une force générant la cohésion sociale.
ID/PB: Dans le cadre de la RFA, pensez-vous qu'il y ait encore place pour un parti conservateur ou un parti de droite?
HD: Conservateur ou de droite, je n'en sais rien et cela ne m'intéresse pas. Je ne vois pas non plus en quoi ces concepts de conservateur et de droite peuvent nous être encore utiles. En revanche, nous nous trouvons en face d'une quantité de problèmes concrets, qu'il faudrait affronter, de choses à changer et qu'il va falloir changer.
ID/PB: Vous vous êtes tenu éloigné de la politique partisane, mais vous ne vous êtes pas entièrement soustrait à elle. Je pense notamment au préambule du programme des Républicains, que vous avez rédigé...
HD: D'une part, je l'ai fait pour des raisons d'ordre privé. D'autre part, on peut saluer grosso modo la tentative de Schönhuber, qu'il poursuit d'ailleurs. Dans le fond, toute nouvelle formation politique, qui a l'intention de s'ancrer dans la vie politique, doit être saluée avec respect. Ne doit-on pas constater que les partis sont vieux et pétrifiés, qu'ils sont devenus des facteurs d'immobilisme? C'est un souci qui préoccupe surtout les partis eux-mêmes depuis des années, et pas seulement ceux qui ne sont membres d'aucune formation ou les citoyens engagés dans un parti ou un autre.
ID/PB: Après tous les échecs des partis de droite qu'a connus l'Allemagne, y a-t-il encore une chance pour un parti qui se positionnerait à droite de l'Union (le cartel des partis démocrates-chrétiens, ndt)?
HD: Oui. Je ne serais pas étonné si nous nous trouvons, dans deux ans, face à un paysage politique complètement modifié.
ID/PB: Professeur Diwald, nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien.
(une version légèrement différente de cet entretien est parue dans Junge Freiheit, n°1/2-1992; adresse: JF, Postfach 147, D-7801 Stegen/Freiburg).
00:05 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 13 janvier 2010
Presseschau (Januar 2010 / 3)

Presseschau (Januar 2010/3)
Einige Links. Bei Interesse anklicken...
###
Nicht nur Außenminister der Polen, sondern auch der Türken ...
Türkei-Besuch
Westerwelle fordert faire Gespräche über EU-Beitritt
Bei seinem Besuch in Ankara hat Außenminister Westerwelle das in der schwarz-gelben Koalition umstrittene Thema eines EU-Beitritts der Türkei angesprochen. Das Land habe „einen Anspruch auf faire Verhandlungen“, sagte er. Zugleich mahnte er weitere Reformen in der Türkei an, etwa bei der Religionsfreiheit.
http://www.welt.de/politik/ausland/article5761915/Westerwelle-fordert-faire-Gespraeche-ueber-EU-Beitritt.html
Ausblick
Bis 2020 überholt China locker den Westen
Die Vorherrschaft des Westens ist beendet. Nun sind die Drittweltstaaten und die ehemaligen Kolonien dran. In der nächsten Dekade wird die Schwäche des Westens noch deutlicher werden. 2020 spielen nur noch China und Amerika eine Rolle, ist der britisch-amerikanische Historiker Niall Ferguson überzeugt.
http://www.welt.de/kultur/article5675814/Bis-2020-ueberholt-China-locker-den-Westen.html
Afghanistan
Geheimdienstexperten werfen US-Agenten Versagen vor
„Ahnungslos, unfähig, unbedeutend“: Ranghohe Geheimdienstexperten haben ein vernichtendes Urteil über die US-Agenten in Afghanistan gefällt. In einem Bericht vergleichen sie die Arbeit der Nachrichtendienste mit Wahrsagerei.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,670289,00.html
Anschlag in Afghanistan
Attackierte CIA-Basis plante Drohnen-Angriffe
Schwerer Schlag für die CIA: Bei einem Attentat in Afghanistan kamen sieben Geheimdienstler ums Leben. Laut „Washington Post“ spielt die betroffene Basis eine Schlüsselrolle bei der Vorbereitung geheimer Luftangriffe auf die Terroristenstützpunkte in der Region.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,669739,00.html
Selbstmordanschlag
CIA-Attentäter war offenbar Al-Qaida-Doppelagent
Von Florian Flade
Offensichtlich hat sich die CIA von einem scheinbar vertrauenswürdigen Informanten täuschen lassen. Für den schwersten Anschlag auf CIA-Agenten seit fast 30 Jahren soll ein jordanischer Doppelagent verantwortlich sein. Bei dem Selbstmordattentat an Silvester starben sieben Mitarbeiter der CIA.
http://www.welt.de/politik/ausland/article5731849/CIA-Attentaeter-war-offenbar-Al-Qaida-Doppelagent.html
Sicherster Airport der Welt
Israelis vertrauen auf Spürsinn statt Nacktscanner
Von Michael Borgstede
Der internationale Flughafen von Tel Aviv gilt als der sicherste Airport der Welt. Und das, obwohl – oder weil – Israel seit Jahrzehnten Anschläge fürchten muß. Doch das Land kommt ohne Nacktscanner aus. Während anderswo nach den technischen Hilfsmitteln für Bomben gefahndet wird, suchen die Israelis nach dem Bombenleger.
http://www.welt.de/politik/ausland/article5702002/Israelis-vertrauen-auf-Spuersinn-statt-Nacktscanner.html
So einen Vorgesetzten wünscht man niemandem ...
Polizeipräsident Glietsch: Berliner Polizisten sollen ab 2010 Namensschilder tragen
Berlins Polizeipräsident Dieter Glietsch will 2010 die individuelle Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte einführen. In einem demokratischen Rechtsstaat sei es selbstverständlich, „daß der Bürger weiß, mit wem er es zu tun hat, wenn er einem Polizisten auf der Straße begegnet“, sagte Glietsch in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur ddp. Daher wolle er, daß das Namenschild an der Uniform getragen werde. Seit 2003 werde den Berliner Polizisten empfohlen, dies freiwillig zu tun.
http://www.ad-hoc-news.de/polizeipraesident-ddp-interview-wiederholung-vom--/de/Polizeimeldungen/20834201
Im Extremfall könnte die Kennzeichnungspflicht zu so etwas führen ...
Racheakt in Mexiko
Drogenmafia richtet Familie eines Soldaten hin
Die mexikanische Drogenmafia hat auf grausame Art und Weise Rache genommen: Auftragskiller ermordeten die Familie eines der Elitesoldaten, der an der Jagd auf den Drogenboß Arturo Beltrán Leyva beteiligt gewesen und dabei getötet worden war.
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,668889,00.html#ref=nldt
In was für einem Staat leben wir nur ...
Juristisches Problem
Waffenamnestie bereitet reuigen Bürgern Ärger
Von Martin Lutz
Bis zum Jahresende konnten Besitzer illegaler Waffen diese der Polizei übergeben und so straffrei ausgehen. Doch es gab einen Haken: Persönlich zur Polizei transportieren durfte man die Waffen nicht. Jetzt laufen zahlreiche Ermittlungsverfahren. So mancher Teilnehmer der Aktion fühlt sich verschaukelt.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5726792/Waffenamnestie-bereitet-reuigen-Buergern-Aerger.html
Dazu passend (gefunden bei sondereinheiten.de):
Viele Bürger haben nach dem Amoklauf in der Gegend von Winnenden ihre Waffen abgegeben. Die Mehrzahl gab dabei an, sie sei durch diesen Amoklauf zu der Erkenntnis gelangt, daß Waffen grundsätzlich nicht in Privatbesitz sein sollten. Eine erstaunliche Zahl von Bürgern gab in kurzer Zeit mehrere Tausend Waffen ab in dem Glauben der Staat würde diese Waffen vernichten.
In vielen Fällen hat der Staat aber diese Waffen für Spottpreise umgehend weiterverkauft. Es wurden mehrere tausend abgegebene Waffen vom Staat umgehend wieder an private Waffenbesitzer und auch an Händler verkauft. Des weiteren wurde bei der Lagerung der abgegebenen Waffen in mehreren Fällen geschlampt. Die gleichen Ämter die private Waffenbesitzer wegen der sicheren Aufbewahrung gängeln, bewahren die abgegebenen Waffen nicht sicher auf.
Um dem ganzen noch die Krone aufzusetzen, kam es aufgrund der schlampigen Aufbewahrung in mehreren Fällen zum Diebstahl von abgegebenen Waffen. Der größte Fall war dabei in Crailsheim. Am 16 Juni entwendete dabei ein Dieb aus dem unverschlossenen Stahlschrank im Rathaus insgesamt 11 Schußwaffen. Und nur durch Zufall ist es der Polizei gelungen, den Dieb in diesem Fall zu ermitteln.
http://www.sondereinheiten.de/forum/viewtopic.php?f=10&t=16714
Das allein war schon ein Hammer ...
Provinzposse
Beamte lassen sich elf Pistolen stehlen
Von Jörg Diehl
Peinliche Panne im baden-württembergischen Crailsheim: Unbekannte haben aus dem Tresorraum des Rathauses elf Pistolen gestohlen, die Bürger nach dem Amoklauf von Winnenden freiwillig zurückgegeben hatten. Die Beamten hatten die Panzertür nicht ordnungsgemäß verriegelt.
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,631041,00.html
http://www.taz.de/1/politik/deutschland/artikel/1/waffen-aus-amt-gestohlen
Aber es kam noch dicker ...
Stadt Crailsheim in Waffengeschäfte verwickelt
Die Stadt Crailsheim soll Waffen, die nach dem Amoklauf in Winnenden zur Entsorgung abgegeben worden waren, verkauft haben. Das haben inzwischen zwei Vereine bestätigt.
http://www.suedkurier.de/news/baden-wuerttemberg/badenwuerttemberg/art330342,3856124
Bei der Polizei selbst – oder jedenfalls einigen ihrer Angehörigen – scheint auch einiges im argen zu liegen ... ;-)
Polizist
Sex beim Rosenkranzgebet
Überraschung bei der Morgenandacht: In einer Kirche in Oberbayern wurden die Gläubigen von eindeutigen Geräuschen gestört. Auf der Empore vergnügte sich ein Polizist mit seiner Freundin.
http://www.focus.de/panorama/welt/polizist-sex-beim-rosenkranzgebet_aid_467765.html
Linke
Das Erfolgsduo Lafontaine und Bartsch zerbricht
Von Thomas Vitzthum
Ein Machtkampf in der Linken? Davon will in der Partei offiziell niemand etwas wissen. Doch die Gemeinsamkeiten zwischen Parteichef Lafontaine und Bundesgeschäftsführer Bartsch sind aufgebraucht, das Gerangel um die Führung ist in vollem Gange. Zwei ominöse Briefe heizen die Unruhe weiter an.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5753224/Das-Erfolgsduo-Lafontaine-und-Bartsch-zerbricht.html
Zu schön, um wahr zu sein ...
Kommentar
Lafontaines Schweigen kann die Linke zerstören
Von Thomas Vitzthum
Die Debattenkultur in der Linkspartei liegt am Boden, Ost- und Westlinke haben sich entzweit. Bisher schweigt der prominenteste Vertreter der Partei dazu. Oskar Lafontaine muß sich jetzt endlich erklären. Sonst riskiert er, den von ihm vollbrachten Vereinigungsprozeß der Linken weit zurückzuwerfen.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5765052/Lafontaines-Schweigen-kann-die-Linke-zerstoeren.html
Streit mit der FDP
Steinbach bietet Verzicht auf Stiftungssitz an
Es kommt offenbar Bewegung in den festgefahrenen Konflikt zwischen Vertriebenenpräsidentin Steinbach und der FDP. Steinbach würde auf den Stiftungssitz, auf dem die FDP sie nicht sehen will, verzichten. Dafür allerdings stellt sie Berichten zufolge zahlreiche Forderungen an die Regierung.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5727598/Steinbach-bietet-Verzicht-auf-Stiftungssitz-an.html
Thierse mal wieder ...
Streit um Stiftungssitz
Steinbachs Angebot sorgt für neue Mißtöne
Das Vorstoß von Erika Steinbach im Streit um die Besetzung des Stiftungsrats sorgt für neuen Ärger. Bundestagsvizepräsident Thierse warf der Vertriebenenpräsidentin vor, „erpresserisch“ vorzugehen. Die CSU dagegen fordert von Außenminister Westerwelle, auf Steinbachs Vorschlag „nicht wieder mit Blockade“ zu antworten.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5735217/Steinbachs-Angebot-sorgt-fuer-neue-Misstoene.html
Thierse nun wieder!
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M5ab3d022a46.0.html
Steinbach grüßt Westerwelle – in Stuttgart
Von Götz Kubitschek
Eine der konservativ-subversiven aktion (ksa) nahestehende Gruppe hat im Namen Erika Steinbachs – aber vermutlich ohne deren Segen – während des Dreikönigstreffens der FDP in Stuttgart einen Gruß an Westerwelle plaziert – oder war doch Polens Außenminister gemeint?
http://www.sezession.de/10315/steinbach-gruesst-westerwelle-in-stuttgart.html
Konservative Aktion besucht Westerwelle in Stuttgart: „Erika Steinbach grüßt herzlich Polens Außenminister!“
Zum heutigen Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart konfrontierte eine der konservativ subversiven aktion (ksa) nahestehende Gruppe Außenminister Guido Westerwelle mit seiner Parteinahme für polnische Interessen im Streit um die Besetzung des Rates der Stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“. Die Konservativen entrollten auf dem politischen Jahresauftakt der FDP ein Transparent: „Erika Steinbach grüßt herzlich Polens Außenminister!“ Westerwelle reagierte persönlich: „Stellen Sie sich bitte an den rechten Rand!“
http://www.blauenarzisse.de/v3/index.php/aktuelles/1224-konservative-aktion-besucht-westerwelle-in-stuttgart-erika-steinbach-gruesst-herzlich-polens-aussenminister
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M5d4471ec4b9.0.html
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/Ich-bin-nur-im-Ausland-zur-Diplomatie-verpflichtet_aid_803410.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/deutschland/FDP-Guido-Westerwelle;art122,2994767
http://www.zeit.de/newsticker/2010/1/6/iptc-bdt-20100106-479-23467178xml
Die ewige Schuld der Euroamerikaner
Von Michael Wiesberg
Zwischen den Jahren gab der Greifswalder Althistoriker Egon Flaig dem Online-Magazin Telepolis ein umfängliches Interview, in dessen Mittelpunkt die Thesen seines Buches „Weltgeschichte der Sklaverei“ standen. Flaig gehört, dies sei hier am Rande eingeflochten, zu den wenigen deutschen Wissenschaftlern, die sich gegen das Märchen von der „islamischen Toleranz“ wenden. Im Verlauf des Gesprächs kam Flaig auch auf die islamische Sklaverei zu sprechen.
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M53484fc6409.0.html
Brühl als Kriegsheld
Goebbels hätte „Stolz der Nation“ gut gefallen
Von Hanns-Georg Rodek
Quentin Tarantinos Kino-Hit „Inglourious Basterds“ handelt unter anderem von dem deutschen Kriegshelden Fredrick Zoller (gespielt von Daniel Brühl), über den Joseph Goebbels einen Propaganda-Film drehen läßt. Diesen Streifen hat Eli Roth jetzt tatsächlich produziert – als kurze Parodie mit dem Titel „Stolz der Nation“.
http://www.welt.de/kultur/article5722264/Goebbels-haette-Stolz-der-Nation-gut-gefallen.html
Grauen der Ära Mao
Als in China Kannibalismus herrschte
Von Johnny Erling
Ein halbes Jahrhundert nach der Ära Mao bricht ein Funktionär sein Schweigen über die bis heute in ihrem Ausmaß von Peking geleugneten Verbrechen dieser Zeit. Ganze Provinzen versanken damals in Massenmord und Kannibalismus. Hungersnöten fielen – zurückhaltenden Schätzungen zufolge – 25 Millionen Menschen zum Opfer.
http://www.welt.de/politik/ausland/article5769033/Als-in-China-Kannibalismus-herrschte.html
SPD-Ausschluß
Gutachten wirft Thilo Sarrazin Rassismus vor
Von Stefan Schulz
Ein Berliner Kreisverband der SPD hat einen Gutachter die umstrittenen Äußerungen von Bundesbanker Thilo Sarrazin (SPD) über türkische Migranten bewerten lassen. Zentrale Passagen hält der Experte für eindeutig rassistisch. Der Kreisverband will Sarrazin aus der Partei werfen. Der reagiert kämpferisch.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5771847/Gutachten-wirft-Thilo-Sarrazin-Rassismus-vor.html
Frankfurt
Schwul-lesbisches Jugendzentrum
„Kein bißchen unnormal“
http://www.fr-online.de/frankfurt_und_hessen/nachrichten/frankfurt/2179065_Schwul-lesbisches-Jugendzentrum-Kein-bisschen-unnormal.html
Dänemark
Polizei vereitelt Anschlag auf Mohammed-Karikaturisten
Er kam mit einer Axt und drang in das Haus von Kurt Westergaard ein: Die dänische Polizei hat den Angriff eines 28jährigen Somaliers mit Verbindungen zu al-Qaida auf den Mohammed-Karikaturisten knapp verhindert. Westergaard rettete sich in letzter Minute in einen Sicherheitsraum.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,669748,00.html
Berlin: Polizist beim Geldholen niedergestochen
Ein Polizist ist am frühen Sonntagmorgen in Berlin-Reinickendorf von einer Gruppe beim Geldabheben (Foto: Die Blutspuren vor der Bank sind am Morgen noch zu sehen) niedergestochen und schwer verletzt worden. Er schwebt noch immer in Lebensgefahr. Dem Notarzt sagte der Polizist, es habe sich um Araber oder Türken gehandelt, die Geld gefordert und dann sofort zugestochen hätten.
http://www.pi-news.net/2010/01/berlin-polizist-beim-geld-holen-niedergestochen/
http://www.welt.de/berlin/article5709441/Berliner-Polizist-vor-Sparkasse-niedergestochen.html
http://www.rbb-online.de/nachrichten/vermischtes/2010_01/berliner_polizist.html
http://www.zeit.de/newsticker/2010/1/3/iptc-hfk-20100103-24-23437110xml
http://www.bild.de/BILD/news/2010/01/03/bluttat-in-berlin/polizist-niedergestochen.html
Morgenpost: Täter war „Ausländer mit Mütze“
Das war der Morgenpost-Redaktion dann wohl doch etwas zu heikel. Hatte sie in ihrer ursprünglichen Meldung zum versuchten Polizistenmord noch von „Arabern oder Türken“ als möglichen Tätern berichtet, wurde daraus wie von Geisterhand ein „Ausländer mit Mütze“.
http://www.pi-news.net/2010/01/morgenpost-taeter-war-auslaender-mit-muetze/
Fall El-Sherbini: Polizist ohne Schuld
Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Beamten ein
Dresden – Die Staatsanwaltschaft Dresden hat das Ermittlungsverfahren gegen den Bundespolizisten eingestellt, der den Ehemann der ermordeten Ägypterin Marwa El-Sherbini irrtümlich angeschossen hatte. Dem Beamten könne weder eine vorsätzliche noch eine fahrlässige Körperverletzung angelastet werden, teilte die Behörde am Dienstag in Dresden mit. El-Sherbinis Mann Elwy Okaz hatte am 1. Juli mit dem Rußlanddeutschen Alex W. gerungen, der zuvor in einem Dresdner Gerichtssaal wie von Sinnen auf die Frau eingestochen hatte. In dem Moment kam der Polizist in den Raum. Er hielt Elwy Okaz für den Angreifer und schoß ihm in den Oberschenkel.
http://www.sueddeutsche.de/p5f38B/3207134/Fall-El-Sherbini-Polizist-ohne-Schuld.html
El-Sherbini: Weitere Ermittlungen gefordert
Bis vor den Europäischen Gerichtshof will man gehen, wenn notwendig. So empört sich wutentbrannt der Witwer der in Dresden von einem Rußlanddeutschen ermordeten Marwa El Sherbini, nachdem er erkennen mußte, daß alle weiteren Ermittlungen in diesem Mordfall eingestellt werden. Erinnern wir uns: Der Täter Alex W. wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt. Der Fall ist geklärt, sollte man meinen.
http://www.pi-news.net/2010/01/el-sherbini-weitere-ermittlungen-gefordert/#more-109425
Hamburg
SPD-„Obama“ wegen Scheinehevorwurfs angeklagt
Von Per Hinrichs
Bülent Ciftlik ist ein vorbildlich integrierter Deutschtürke. Er galt als Hoffnungsträger nicht nur der Hamburger SPD. Doch nun hat die Hamburger Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn erhoben. Ciftlik soll für die Anbahnung einer Scheinehe Geld genommen – und es in seinen Wahlkampf gesteckt haben.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5750613/SPD-Obama-wegen-Scheinehevorwurfs-angeklagt.html
14 Jahre nach der Tat
Münchner U-Bahn-Schläger müssen ins Gefängnis
Als ein 23jähriger zwei junge Männer bittet, in einem Münchner U-Bahnhof die Zigaretten zu löschen, wird er fast von ihnen getötet. Nur eine Not-OP rettete ihm nach mehreren Messerstichen das Leben. Das war im Jahr 1996. Jetzt wurden die beiden Männer für den Mordversuch verurteilt – 14 Jahre nach der Tat. [Da gab es wohl „ein wenig“ Migrantenbonus. Die Täter sind übrigens Cousins und heißen Enver und Rexhep.]
http://www.welt.de/vermischtes/article5732805/Muenchner-U-Bahn-Schlaeger-muessen-ins-Gefaengnis.html
http://www.zeit.de/newsticker/2010/1/5/iptc-bdt-20100105-130-23453804xml
Freispruch verworfen
Urteil zu verbranntem Asylbewerber aufgehoben
Der Fall des Asylbewerbers Oury Jalloh, der in Polizeigewahrsam in einer Zelle verbrannte, wird neu verhandelt. Das BGH verwarf den Freispruch für den Polizisten, der während Jallohs Tod die Verantwortung in dem Dessauer Revier hatte. Er soll den Feueralarm der Zelle ignoriert und sogar abgeschaltet haben.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5760389/Urteil-zu-verbranntem-Asylbewerber-aufgehoben.html
Zuwanderung
Polizeigewerkschaft warnt vor Integrationsdefiziten
Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Konrad Freiberg, sieht Handlungsbedarf in der Integrationspolitik. Die „Islamisierung“ in Deutschland nehme deutlich zu, sagte Freiberg. „Ob das in eine Radikalisierung umschlägt, hängt davon ab, ob sich die Integrationsdefizite noch vergrößern.“
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5708657/Polizeigewerkschaft-warnt-vor-Integrationsdefiziten.html
Polizei klagt über zunehmende Gewaltbereitschaft
http://www.bild.de/BILD/regional/frankfurt/dpa/2010/01/04/polizei-klagt-ueber-zunehmende-gewaltbereitschaft.html
http://www.hna.de/hessenstart/00_20100104165700_Hessische_Polizeigewerkschaft_beklagt_Gewalt_g.html
Antideutscher Ausrutscher
Von Thomas Paulwitz
„Ich rutsche nicht!“ schrieb mir eine empörte Sprachwelt-Leserin. Unser Anglizismenmuffel hatte Unerhörtes gewagt. Denn er hatte es sich nicht nehmen lassen, den Lesern seiner Kolumne zu wünschen, noch in „viele neue Jahre rutschen“ zu können. Das war zu viel für die gute Frau: „Ehrlich gesagt, ich bin entsetzt!“ Den Beweis der rechten nationalen Gesinnung blieben wir ihr schuldig: „Ich bin national, und Sie?“
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M5092bf9ef93.0.html
Kita-Debatte – Pro
Kitas sind wichtig für die kindliche Entwicklung
Von Sabine Höher
Wer Eltern, die ihre Kinder in die Kita schicken, ein schlechtes Gewissen macht, hat unrecht. Die Kleinen brauchen die Gesellschaft anderer Kinder. Eltern können deshalb viel leisten für die Entwicklung ihres Nachwuchses, doch alles Mutter und Vater zu überlassen, ist weder realistisch noch sinnvoll.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5760813/Kitas-sind-wichtig-fuer-die-kindliche-Entwicklung.html
Contra
Kitas sind gut für Eltern, nicht für Kinder
Von Birgitta vom Lehn
Nur noch wenige Mütter und Väter können es sich leisten, nicht arbeiten zu gehen. Deshalb sind Kitas eine praktische Einrichtung. Doch den Kindern bringen sie keine Vorteile, auch wenn sie nun aller Orten in den Himmel gelobt werden. Denn ein individuelles Eingehen auf die Kleinen ist in der Kita kaum möglich.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5760816/Kitas-sind-gut-fuer-Eltern-nicht-fuer-Kinder.html
Gerhard Amendt im Interview
Männer haben Kampf gegen Feminismus verpaßt
Von A. Seibel und J. Luig
Gerhard Amendt wirft den Männern vor, sich nur halbherzig gegen die Auswüchse des Feminismus gewehrt zu haben. Im Interview auf WELT ONLINE spricht der Soziologe über die Mißverständnisse zwischen den Geschlechtern, die letzten männlichen Domänen und den fehlenden Respekt der Frauen.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5711005/Maenner-haben-Kampf-gegen-Feminismus-verpasst.html
Die Zukunft des Journalismus – als Wohltätigkeitsveranstaltung
Von Hannes Stein
Die New Yorker Stiftung ProPublica finanziert investigative Recherchen. Also genau das, was sich immer weniger Medien leisten können
http://www.welt.de/die-welt/politik/article5745382/Die-Zukunft-des-Journalismus-als-Wohltaetigkeitsveranstaltung.html
Ein Plattenbau soll Altenburgs Marktplatz entstellen
Von Dankwart Guratzsch
Krieg und Sozialismus hat der Marktplatz von Altenburg überstanden. Jetzt soll er durch Neubauten entstellt werden. Dabei könnten die Stadtväter das mit gutem Gewissen noch verhindern. Schließlich gibt es viele Beispiele, die zeigen, daß sich mit der Sanierung von Altbauten das Stadtbild aufwerten läßt.
http://www.welt.de/kultur/article5679929/Ein-Plattenbau-soll-Altenburgs-Marktplatz-entstellen.html
Frankfurt und Warschau
Warnung vor der „McDonaldisierung“
http://www.faz.net/s/RubFAE83B7DDEFD4F2882ED5B3C15AC43E2/Doc~E0CF4D561C3A5435D9420FBB97425DC54~ATpl~Ecommon~Scontent.html
Bildungspolitik
Die Schulreform kommt
Von Florentine Anders
Berlins Bildungspolitiker haben gestern den Weg freigemacht zur umfassendsten Reform der hauptstädtischen Bildungslandschaft der letzten Jahrzehnte. Die nötigen Gesetzesänderungen haben mit den Stimmen der Koalition den Schulausschuß passiert. FDP und CDU stimmten dagegen. Die Grünen haben sich der Stimme enthalten.
http://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article1235235/Die-Schulreform-kommt.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/art270,2995846
Bildung
Bündnis gründet sich gegen Schulreform
Gegen die Einführung der Sekundarschule in Berlin will sich am Freitag ein Aktionsbündnis gründen.
http://www.rbb-online.de/nachrichten/politik/2010_01/aktionsbuendnis_gegen.html
Hacker zeigen auf EU-Seite Mister Bean statt Zapatero
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gKg2iyiiOihVpabfBAuO6Qbug5Cw
NDR blamiert sich mit Quiz-Frage
„Kleines Schwarzes“: Jan Hofer beleidigt in TV-Show Madonnas Adoptiv-Tochter
http://www.mopo.de/2010/20100103/hamburg/panorama/ndr_blamiert_sich_mit_quiz_frage.html
„We are all Gay, Gypsy & Jew!“
http://www.sezession.de/10293/we-are-all-gay-gypsy-jew.html
00:15 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journaux, allemagne, europe, politique, affaires européennes, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 12 janvier 2010
Grezngänger Ernst Niekisch
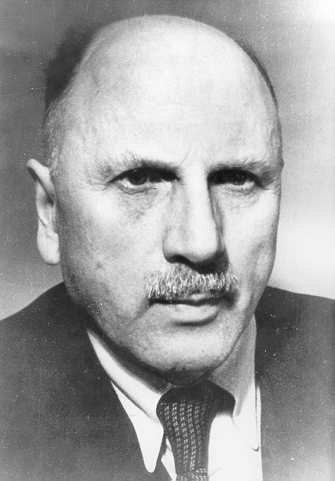 Grenzgänger Ernst Niekisch
Grenzgänger Ernst Niekisch
Ex: http://rittermabuse.wordpress.com/
In der DDR bekleidete Ernst Niekisch zahlreiche Funktionen; dennoch entzog die deutsche Teilung ihm den Boden: »Zuletzt erkannte ich, dass man in Deutschland nur noch die Wahl habe, Amerikaner oder Russe zu sein. Wer mit Entschiedenheit eine eigene deutsche Position bewahren will, verfällt über kurz oder lang hoffnungsloser Vereinsamung.« In einem unveröffentlichten Manuskript schlug er tatsächlich kurz vor seinem Tod vor, die DDR, das »Bollwerk gegen den Westen«, in »Preußen« umzubenennen.
Als Grenzgänger zwischen links und rechts blieb Niekisch auch nach seinem Tod wirkungsmächtig. Bei vielen Versuchen, die Linke mit der Nation zu versöhnen, stand er Pate. Der Historiker Sebastian Haffner forderte noch im November 1989 angesichts der sich abzeichnenden Wiedervereinigung, Niekisch wieder auf die Tagesordnung zu setzen: »So unwahrscheinlich es klingen mag: Der wahre Theoretiker der Weltrevolution, die heute im Gange ist, ist nicht Marx und nicht einmal Lenin. Es ist Niekisch.«
00:16 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, weimar, années 20, années 30, nationalisme révolutionnaire, nationalisme, socialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Entretien avec Günter Maschke
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991
 Entretien avec Günter Maschke
Entretien avec Günter Maschke
propos recueillis par Dieter STEIN et Jürgen LANTER
Q.: Monsieur Maschke, êtes-vous un ennemi de la Constitution de la RFA?
Q.: Monsieur Maschke, êtes-vous un ennemi de la Constitution de la RFA?
GM: Oui. Car cette loi fondamentale (Grundgesetz) est pour une moitié un octroi, pour une autre moitié la production juridique de ceux qui collaborent avec les vainqueurs. On pourrait dire que cette constitution est un octroi que nous nous sommes donné à nous-mêmes. Les meilleurs liens qui entravent l'Allemagne sont ceux que nous nous sommes fabriqués nous-mêmes.
Q.: Mais dans le débat qui a lieu aujourd'hui à propos de cette constitution, vous la défendez...
GM: Oui, nous devons défendre la loi fondamentale, la constitution existante car s'il fallait en créer une nouvelle, elle serait pire, du fait que notre peuple est complètement «rééduqué» et de ce fait, choisirait le pire. Toute nouvelle constitution, surtout si le peuple en débat, comme le souhaitent aussi bon nombre d'hommes de droite, connaîtrait une inflation de droits sociaux, un gonflement purement quantitatif des droits fondamentaux, et conduirait à la destruction des prérogatives minimales qui reviennent normalement à l'Etat national.
Q.: Donc, quelque chose de fondamental a changé depuis 1986, où vous écriviez dans votre article «Die Verschwörung des Flakhelfer» (= La conjuration des auxiliaires de la DCA; ndlr: mobilisés à partir de 1944, les jeunes hommes de 14 à 17 ans devaient servir les batteries de DCA dans les villes allemandes; c'est au sein de cette classe d'âge que se sont développées, pour la première fois en Allemagne, certaines modes américaines de nature individualiste, telles que l'engouement pour le jazz, pour les mouvements swing et zazou; c'est évidemment cette classe d'âge-là qui tient les rênes du pouvoir dans la RFA actuelle; en parlant de conjuration des auxiliaires de la DCA, G. Maschke entendait stigmatiser la propension à aduler tout ce qui est américain de même que la rupture avec toutes les traditions politiques et culturelles européennes). Dans cet article aux accents pamphlétaires, vous écriviez que la Constitution était une prison de laquelle il fallait s'échapper...
GM: Vu la dégénérescence du peuple allemand, nous devons partir du principe que toute nouvelle constitution serait pire que celle qui existe actuellement. Les rapports de force sont clairs et le resteraient: nous devrions donc nous débarrasser d'abord de cette nouvelle constitution, si elle en venait à exister. En disant cela, je me doute bien que j'étonne les «nationaux»...
Q.: Depuis le 9 novembre 1989, jour où le Mur est tombé, et depuis le 3 octobre 1990, jour officiel de la réunification, dans quelle mesure la situation a-t-elle changé?
GM: D'abord, je dirais que la servilité des Allemands à l'égard des puissances étrangères s'est encore accrue. Ma thèse a toujours été la suivante: rien, dans cette réunification, ne pouvait effrayer la France ou l'Angleterre. Comme nous sommes devenus terriblement grands, nous sommes bien décidés, désormais, à prouver, par tous les moyens et dans des circonstances plus critiques, notre bonne nature bien inoffensive. L'argumentaire développé par le camp national ou par les établis qui ont encore un petit sens de la Nation s'est estompé; il ne s'est nullement renforcé. Nous tranquilisons le monde entier, en lui disant qu'il s'agit du processus d'unification européenne qui est en cours et que l'unité allemande n'en est qu'une facette, une étape. Si d'aventure on rendait aux Allemands les territoires de l'Est (englobés dans la Pologne ou l'URSS), l'Autriche ou le Tyrol du Sud, ces braves Teutons n'oseraient même plus respirer; ainsi, à la joie du monde entier, la question allemande serait enfin réglée. Mais trêve de plaisanterie... L'enjeu, la Guerre du Golfe nous l'a montré. Le gouvernement fédéral a payé vite, sans sourciller, pour la guerre des Alliés qui, soit dit en passant, a eu pour résultat de maintenir leur domination sur l'Allemagne. Ce gouvernement n'a pas osé exiger une augmentation des impôts pour améliorer le sort de nos propres compatriotes de l'ex-RDA, mais lorsqu'a éclaté la guerre du Golfe, il a immédiatement imposé une augmentation et a soutenu une action militaire qui a fait passer un peu plus de 100.000 Irakiens de vie à trépas. Admettons que la guerre du Golfe a servi de prétexte pour faire passer une nécessaire augmentation des impôts. Il n'empêche que le procédé, que ce type de justification, dévoile la déchéance morale de nos milieux officiels. Pas d'augmentation des impôts pour l'Allemagne centrale, mais une augmentation pour permettre aux Américains de massacrer les Irakiens qui ne nous menaçaient nullement. Je ne trouve pas de mots assez durs pour dénoncer cette aberration, même si je stigmatise très souvent les hypocrisies à connotations humanistes qui conduisent à l'inhumanité. Je préfère les discours non humanistes qui ne conduisent pas à l'inhumanité.
Q.: Comment le gouvernement fédéral aurait-il dû agir?
GM: Il avait deux possibilités, qui peuvent sembler contradictoires à première vue. J'aime toujours paraphraser Charles Maurras et dire «La nation d'abord!». Première possibilité: nous aurions dû participer à la guerre avec un fort contingent, si possible un contingent quantitativement supérieur à celui des Britanniques, mais exclusivement avec des troupes terrestres, car, nous Allemands, savons trop bien ce qu'est la guerre aérienne. Nous aurions alors dû lier cet engagement à plusieurs conditions: avoir un siège dans le Conseil de Sécurité, faire supprimer les clauses des Nations Unies qui font toujours de nous «une nation ennemie», faire en sorte que le traité nous interdisant de posséder des armes nucléaires soit rendu caduc. Il y a au moins certains indices qui nous font croire que les Etats-Unis auraient accepté ces conditions. Deuxième possibilité: nous aurions dû refuser catégoriquement de nous impliquer dans cette guerre, de quelque façon que ce soit; nous aurions dû agir au sein de l'ONU, surtout au moment où elle était encore réticente, et faire avancer les choses de façon telle, que nous aurions déclenché un conflit de grande envergure avec les Etats-Unis. Ces deux scénarios n'apparaissent fantasques que parce que notre dégénérescence nationale et politique est désormais sans limites.
Q.: Mais la bombe atomique ne jette-t-elle pas un discrédit définitif sur le phénomène de la guerre?
GM: Non. Le vrai problème est celui de sa localisation. Nous n'allons pas revenir, bien sûr, à une conception merveilleuse de la guerre limitée, de la guerre sur mesure. Il n'empêche que le phénomène de la guerre doit être accepté en tant que régulateur de tout statu quo devenu inacceptable. Sinon, devant toute crise semblable à celle du Koweit, nous devrons nous poser la question: devons-nous répéter ou non l'action que nous avons entreprise dans le Golfe? Alors, si nous la répétons effectivement, nous créons de facto une situation où plus aucun droit des gens n'est en vigueur, c'est-à-dire où seule une grande puissance exécute ses plans de guerre sans égard pour personne et impose au reste du monde ses intérêts particuliers. Or comme toute action contre une grande puissance s'avère impossible, nous aurions en effet un nouvel ordre mondial, centré sur la grande puissance dominante. Et si nous ne répétons pas l'action ou si nous introduisons dans la pratique politique un «double critère» (nous intervenons contre l'Irak mais non contre Israël), alors le nouveau droit des gens, expression du nouvel ordre envisagé, échouera comme a échoué le droit des gens imposé par Genève jadis. S'il n'y a plus assez de possibilités pour faire accepter une mutation pacifique, pour amorcer une révision générale des traités, alors nous devons accepter la guerre, par nécessité. J'ajouterais en passant que toute la Guerre du Golfe a été une provocation, car, depuis 1988, le Koweit menait une guerre froide et une guerre économique contre l'Irak, avec l'encouragement des Américains.
Q.: L'Allemagne est-elle incapable, aujourd'hui, de mener une politique extérieure cohérente?
GM: A chaque occasion qui se présentera sur la scène de la grande politique, on verra que non seulement nous sommes incapables de mener une opération, quelle qu'elle soit, mais, pire, que nous ne le voulons pas.
Q.: Pourquoi?
GM: Parce qu'il y a le problème de la culpabilité, et celui du refoulement: nous avons refoulé nos instincts politiques profonds et naturels. Tant que ce refoulement et cette culpabilité seront là, tant que leurs retombées concrètes ne seront pas définitivement éliminées, il ne pourra pas y avoir de politique allemande.
Q.: Donc l'Allemagne ne cesse de capituler sur tous les fronts...
GM: Oui. Et cela appelle une autre question: sur les monuments aux morts de l'avenir, inscrira-t-on «ils sont tombés pour que soit imposée la résolution 1786 de l'ONU»? Au printemps de cette année 1991, on pouvait repérer deux formes de lâcheté en Allemagne. Il y avait la lâcheté de ceux qui, en toutes circonstances, hissent toujours le drapeau blanc. Et il y avait aussi la servilité de la CSU qui disait: «nous devons combattre aux côtés de nos amis!». C'était une servilité machiste qui, inconditionnellement, voulait que nous exécutions les caprices de nos pseudo-amis.
Q.: Sur le plan de la politique intérieure, qui sont les vainqueurs et qui sont les perdants du débat sur la Guerre du Golfe?
GM: Le vainqueur est inconstestablement la gauche, style UNESCO. Celle qui n'a que les droits de l'homme à la bouche, etc. et estime que ce discours exprime les plus hautes valeurs de l'humanité. Mais il est une question que ces braves gens ne se posent pas: QUI décide de l'interprétation de ces droits et de ces valeurs? QUI va les imposer au monde? La réponse est simple: dans le doute, ce sera toujours la puissance la plus puissante. Alors, bonjour le droit du plus fort! Les droits de l'homme, récemment, ont servi de levier pour faire basculer le socialisme. A ce moment-là, la gauche protestait encore. Mais aujourd'hui, les droits de l'homme servent à fractionner, à diviser les grands espaces qui recherchent leur unité, où à détruire des Etats qui refusent l'alignement, où, plus simplement, pour empêcher certains Etats de fonctionner normalement.
Q.: Que pensez-vous du pluralisme?
GM: Chez nous, on entend, par «pluralisme», un mode de fonctionnement politique qui subsiste encore ci et là à grand peine. On prétend que le pluralisme, ce sont des camps politiques, opposés sur le plan de leurs Weltanschauungen, qui règlent leurs différends en négociant des compromis. Or la RFA, si l'on fait abstraction des nouveaux Länder d'Allemagne centrale, est un pays idéologiquement arasé. Les oppositions d'ordre confessionnel ne constituent plus un facteur; les partis ne sont plus des «armées» et n'exigent plus de leurs membres qu'ils s'engagent totalement, comme du temps de la République de Weimar. A cette époque, comme nous l'enseigne Carl Schmitt, les «totalités parcellisées» se juxtaposaient. On naissait quasiment communiste, catholique du Zentrum, social-démocrate, etc. On passait sa jeunesse dans le mouvement de jeunesse du parti, on s'affiliait à son association sportive et, au bout du rouleau, on était enterré grâce à la caisse d'allocation-décès que les coreligionnaires avaient fondée... Ce pluralisme, qui méritait bien son nom, n'existe plus. Chez nous, aujourd'hui, ce qui domine, c'est une mise-au-pas intérieure complète, où, pour faire bonne mesure, on laisse subsister de petites différences mineures. Les bonnes consciences se réjouissent de cette situation: elles estiment que la RFA a résolu l'énigme de l'histoire. C'est là notre nouveau wilhelminisme: «on y est arrivé, hourra!»; nous avons tiré les leçons des erreurs de nos grands-pères. Voilà le consensus et nous, qui étions, paraît-il, un peuple de héros (Helden), sommes devenus de véritables marchands (Händler), pacifiques, amoureux de l'argent et roublards. Qui plus est, la fourchette de ce qui peut être dit et pensé sans encourir de sanctions s'est réduite continuellement depuis les années 50. Je vous rappellerais qu'en 1955 paraissait, dans une grande maison d'édition, la Deutsche Verlags-Anstalt, un livre de Wilfried Martini, Das Ende aller Sicherheit, l'une des critiques les plus pertinentes de la démocratie parlementaire. Ce livre, aujourd'hui, ne pourrait plus paraître que chez un éditeur ultra-snob ou dans une maison minuscule d'obédience extrême-droitiste. Cela prouve bien que l'espace de liberté intellectuelle qui nous reste se rétrécit comme une peau de chagrin. Les critiques du système, de la trempe d'un Martini, ont été sans cesse refoulés, houspillés dans les feuilles les plus obscures ou les cénacles les plus sombres: une fatalité pour l'intelligence! L'Allemagne centrale, l'ex-RDA, ne nous apportera aucun renouveau spirituel. Les intellectuels de ces provinces-là sont en grande majorité des adeptes extatiques de l'idéologie libérale de gauche, du pacifisme et de la panacée «droit-de-l'hommarde». Ils n'ont conservé de l'idéologie officielle de la SED (le parti au pouvoir) que le miel humaniste: ils ne veulent plus entendre parler d'inimitié (au sens schmittien), de conflit, d'agonalité, et fourrent leur nez dans les bouquins indigestes et abscons de Sternberger et de Habermas. Mesurez le désastre: les 40 ans d'oppression SED n'ont même pas eu l'effet d'accroître l'intelligence des oppressés!
Q.: Mais les Allemands des Länder centraux vont-ils comprendre le langage de la rééducation que nous maîtrisons si bien?
GM: Ils sont déjà en train de l'apprendre! Mais ce qui est important, c'est de savoir repérer ce qui se passe derrière les affects qu'ils veulent bien montrer. Savoir si quelque chose changera grâce au nouveau mélange inter-allemand. Bien peu de choses se dessinent à l'horizon. Mais c'est également une question qui relève de l'achèvement du processus de réunification, de l'harmonisation économique, de savoir quand et comment elle réussira. A ce moment-là, l'Allemagne pourra vraiment se demander si elle pourra jouer un rôle politique et non plus se borner à suivre les Alliés comme un toutou. Quant à la classe politique de Bonn, elle espère pouvoir échapper au destin grâce à l'unification européenne. L'absorption de l'Allemagne dans le tout européen: voilà ce qui devrait nous libérer de la grande politique. Mais cette Europe ne fonctionnera pas car tout ce qui était «faisable» au niveau européen a déjà été fait depuis longtemps. La construction du marché intérieur est un bricolage qui n'a ni queue ni tête. Prenons un exemple: qui décidera demain s'il faut ou non proclamer l'état d'urgence en Grèce? Une majorité rendue possible par les voix de quelques députés écossais ou belges? Vouloir mener une politique supra-nationale en conservant des Etats nationaux consolidés est une impossibilité qui divisera les Européens plutôt que de les unir.
Q.: Comment jugez-vous le monde du conservatisme, de la droite, en Allemagne? Sont-ils les moteurs des processus dominants ou ne sont-ils que des romantiques qui claudiquent derrière les événements?
GM: Depuis 1789, le monde évolue vers la gauche, c'est la force des choses. Le national-socialisme et le fascisme étaient, eux aussi, des mouvements de gauche (j'émets là une idée qui n'est pas originale du tout). Le conservateur, le droitier —je joue ici au terrible simplificateur— est l'homme du moindre mal. Il suit Bismarck, Hitler, puis Adenauer, puis Kohl. Et ainsi de suite, usque ad finem. Je ne suis pas un conservateur, un homme de droite. Car le problème est ailleurs: il importe bien plutôt de savoir comment, à quel moment et qui l'on «maintient». Ce qui m'intéresse, c'est le «mainteneur», l'Aufhalter, le Cat-echon dont parlait si souvent Carl Schmitt. Hegel et Savigny étaient des Aufhalter de ce type; en politique, nous avons eu Napoléon III et Bismarck. L'idée de maintenir, de contenir le flot révolutionnaire/dissolutif, m'apparait bien plus intéressante que toutes les belles idées de nos braves conservateurs droitiers, si soucieux de leur Bildung. L'Aufhalter est un pessimiste qui passe à l'action. Lui, au moins, veut agir. Le conservateur droitier ouest-allemand, veut-il agir? Moi, je dis que non!
Q.: Quelles sont les principales erreurs des hommes de droite allemands?
GM: Leur grande erreur, c'est leur rousseauisme, qui, finalement, n'est pas tellement éloigné du rousseauisme de la gauche. C'est la croyance que le peuple est naturellement bon et que le magistrat est corruptible. C'est le discours qui veut que le peuple soit manipulé par les politiciens qui l'oppressent. En vérité, nous avons la démocratie totale: voilà notre misère! Nous avons aujourd'hui, en Allemagne, un système où, en haut, règne la même morale ou a-morale qu'en bas. Seule différence: la place de la virgule sur le compte en banque; un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Pour tout ordre politique qui mérite d'être qualifié d'«ordre», il est normal qu'en haut, on puisse faire certaines choses qu'il n'est pas permis de faire en bas. Et inversément: ceux qui sont en haut ne peuvent pas faire certaines choses que peuvent faire ceux qui sont en bas. On s'insurge contre le financement des partis, les mensonges des politiciens, leur corruption, etc. Mais le mensonge et la corruption, c'est désormais un sport que pratique tout le peuple. Pas à pas, la RFA devient un pays orientalisé, parce que les structures de l'Etat fonctionnent de moins en moins correctement, parce qu'il n'y a plus d'éthique politique, de Staatsethos, y compris dans les hautes sphères de la bureaucratie. La démocratie accomplie, c'est l'universalisation de l'esprit du p'tit cochon roublard, le règne universel des petits malins. C'est précisément ce que nous subissons aujourd'hui. C'est pourquoi le mécontentement à l'égard de la classe politicienne s'estompe toujours aussi rapidement: les gens devinent qu'ils agiraient exactement de la même façon. Pourquoi, dès lors, les politiciens seraient-ils meilleurs qu'eux-mêmes? Il faudrait un jour examiner dans quelle mesure le mépris à l'égard du politicien n'est pas l'envers d'un mépris que l'on cultive trop souvent à l'égard de soi-même et qui s'accommode parfaitement de toutes nos petites prétentions, de notre volonté générale à vouloir rouler autrui dans la farine, etc.
Q.: Et le libéralisme?
GM: Dans les années qui arrivent, des crises toujours plus importantes secoueront la planète, le pays et le concert international. Le libéralisme y rencontrera ses limites. La prochaine grande crise sera celle du libéralisme. Aujourd'hui, il triomphe, se croit invincible, mais demain, soyez en sûr, il tombera dans la boue pour ne plus se relever.
Q.: Pourquoi?
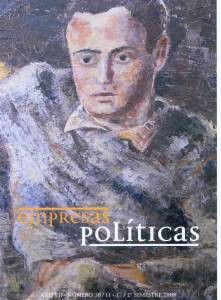 GM: Parce que le monde ne deviendra jamais une unité. Parce que les coûts de toutes sortes ne pourront pas constamment être externalisés. Parce que le libéralisme vit de ce qu'ont construit des forces pré-libérales ou non libérales; il ne crée rien mais consomme tout. Or nous arrivons à un stade où il n'y a plus grand chose à consommer. A commencer par la morale... Puisque la morale n'est plus déterminée par l'ennemi extérieur, n'a plus l'ennemi extérieur pour affirmer ce qu'elle entend être et promouvoir, nous débouchons tout naturellement sur l'implosion des valeurs... Et le libéralisme échouera parce qu'il ne pourra plus satisfaire les besoins économiques qui se font de plus en plus pressants, notamment en Europe orientale.
GM: Parce que le monde ne deviendra jamais une unité. Parce que les coûts de toutes sortes ne pourront pas constamment être externalisés. Parce que le libéralisme vit de ce qu'ont construit des forces pré-libérales ou non libérales; il ne crée rien mais consomme tout. Or nous arrivons à un stade où il n'y a plus grand chose à consommer. A commencer par la morale... Puisque la morale n'est plus déterminée par l'ennemi extérieur, n'a plus l'ennemi extérieur pour affirmer ce qu'elle entend être et promouvoir, nous débouchons tout naturellement sur l'implosion des valeurs... Et le libéralisme échouera parce qu'il ne pourra plus satisfaire les besoins économiques qui se font de plus en plus pressants, notamment en Europe orientale.
Q.: Vous croyez donc que les choses ne changent qu'à coup de catastrophes?
GM: C'est exact. Seules les catastrophes font que le monde change. Ceci dit, les catastrophes ne garantissent pas pour autant que les peuples modifient de fond en comble leurs modes de penser déficitaires. Depuis des années, nous savions, ou du moins nous étions en mesure de savoir, ce qui allait se passer si l'Europe continuait à être envahie en masse par des individus étrangers à notre espace, provenant de cultures radicalement autres par rapport aux nôtres. Le problème devient particulièrement aigu en Allemagne et en France. Quand nous aurons le «marché intérieur», il deviendra plus aigu encore. Or à toute politique rationnelle, on met des bâtons dans les roues en invoquant les droits de l'homme, etc. Ceci n'est qu'un exemple pour montrer que le fossé se creusera toujours davantage entre la capacité des uns à prévoir et la promptitude des autres à agir en conséquence.
Q.: Ne vous faites-vous pas d'illusions sur la durée que peuvent prendre de tels processus? Au début des années 70, on a pronostiqué la fin de l'ère industrielle; or, des catastrophes comme celles de Tchernobyl n'ont eu pour conséquence qu'un accroissement générale de l'efficience industrielle. Même les Verts pratiquent aujourd'hui une politique industrielle. Ne croyez-vous pas que le libéralisme s'est montré plus résistant et innovateur qu'on ne l'avait cru?
GM: «Libéralisme» est un mot qui recouvre beaucoup de choses et dont la signification ne s'étend pas à la seule politique industrielle. Mais, même en restant à ce niveau de politique industrielle, je resterai critique à l'égard du libéralisme. Partout, on cherche le salut dans la «dé-régulation». Quelles en sont les conséquences? Elles sont patentes dans le tiers-monde. Pour passer à un autre plan, je m'étonne toujours que la droite reproche au libéralisme d'être inoffensif et inefficace, alors qu'elle est toujours vaincue par lui. On oublie trop souvent que le libéralisme est aussi ou peut être un système de domination qui fonctionne très bien, à la condition, bien sûr, que l'on ne prenne pas ses impératifs au sérieux. C'est très clair dans les pays anglo-saxons, où l'on parle sans cesse de democracy ou de freedom, tout en pensant God's own country ou Britannia rules the waves. En Allemagne, le libéralisme a d'emblée des effets destructeurs et dissolutifs parce que nous prenons les idéologies au sérieux, nous en faisons les impératifs catégoriques de notre agir. C'est la raison pour laquelle les Alliés nous ont octroyé ce système après 1945: pour nous neutraliser.
Q.: Etes-vous un anti-démocrate,
Monsieur Maschke?
GM: Si l'on entend par «démocratie» la partitocratie existente, alors, oui, je suis anti-démocrate. Il n'y a aucun doute: ce système promeut l'ascension sociale de types humains de basse qualité, des types humains médiocres. A la rigueur, nous pourrions vivre sous ce système si, à l'instar des Anglo-Saxons ou, partiellement, des Français, nous l'appliquions ou l'instrumentalisions avec les réserves nécessaires, s'il y avait en Allemagne un «bloc d'idées incontestables», imperméable aux effets délétères du libéralisme idéologique et pratique, un «bloc» selon la définition du juriste français Maurice Hauriou. Evidemment, si l'on veut, les Allemands ont aujourd'hui un «bloc d'idées incontestables»: ce sont celles de la culpabilité, de la rééducation, du refoulement des acquis du passé. Mais contrairement au «bloc» défini par Hauriou, notre «bloc» est un «bloc» de faiblesses, d'éléments affaiblissants, incapacitants. La «raison d'Etat» réside chez nous dans ces faiblesses que nous cultivons jalousement, que nous conservons comme s'il s'agissait d'un Graal. Mais cette omniprésence de Hitler, cette fois comme croquemitaine, signifie que Hitler règne toujours sur l'Allemagne, parce que c'est lui, en tant que contre-exemple, qui détermine les règles de la politique. Je suis, moi, pour la suppression définitive du pouvoir hitlérien.
Q.: Vous êtes donc le seul véritable
anti-fasciste?
GM: Oui. Chez nous, la police ne peut pas être une police, l'armée ne peut pas être une armée, le supérieur hiérarchique ne peut pas être un supérieur hiérarchique, un Etat ne peut pas être un Etat, un ordre ne peut pas être un ordre, etc. Car tous les chemins mènent à Hitler. Cette obsession prend les formes les plus folles qui soient. Les spéculations des «rééducateurs» ont pris l'ampleur qu'elles ont parce qu'ils ont affirmé avec succès que Hitler résumait en sa personne tout ce qui relevait de l'Etat, de la Nation et de l'Autorité. Les conséquences, Arnold Gehlen les a résumées en une seule phrase: «A tout ce qui est encore debout, on extirpe la moëlle des os». Or, en réalité, le système mis sur pied par Hitler n'était pas un Etat mais une «anarchie autoritaire», une alliance de groupes ou de bandes qui n'ont jamais cessé de se combattre les uns les autres pendant les douze ans qu'a duré le national-socialisme. Hitler n'était pas un nationaliste, mais un impérialiste racialiste. Pour lui, la nation allemande était un instrument, un réservoir de chair à canon, comme le prouve son comportement du printemps 1945. Mais cette vision-là, bien réelle, de l'hitlérisme n'a pas la cote; c'est l'interprétation sélectivement colorée qui s'est imposée dans nos esprits; résultat: les notions d'Etat et de Nation peuvent être dénoncées de manière ininterrompue, détruites au nom de l'émancipation.
Q.: Voyez-vous un avenir pour la droite en Allemagne?
GM: Pas pour le moment.
Q.: A quoi cela est-il dû?
GM: Notamment parce que le niveau intellectuel de la droite allemande est misérable. Je n'ai jamais cessé de le constater. Avant, je prononçais souvent des conférences pour ce public; je voyais arriver 30 bonshommes, parmi lesquels un seul était lucide et les 29 autres, idiots. La plupart étaient tenaillés par des fantasmes ou des ressentiments. Ce public des cénacles de droite vous coupe tous vos effets. Ce ne sont pas des assemblées, soudées par une volonté commune, mais des poulaillers où s'agitent des individus qui se prétendent favorables à l'autorité mais qui, en réalité, sont des produits de l'éducation anti-autoritaire.
Q.: L'Amérique est-elle la cible principale
de l'anti-libéralisme?
GM: Deux fois en ce siècle, l'Amérique s'est dressée contre nous, a voulu détruire nos œuvres politiques, deux fois, elle nous a déclaré la guerre, nous a occupés et nous a rééduqués.
Q.: Mais l'anti-américanisme ne se déploie-t-il pas essentiellement au niveau «impolitique» des sentiments?
GM: L'Amérique est une puissance étrangère à notre espace, qui occupe l'Europe. Je suis insensible à ses séductions. Sa culture de masse a des effets désorientants. Certes, d'aucuns minimisent les effets de cette culture de masse, en croyant que tout style de vie n'est que convention, n'est qu'extériorité. Beaucoup le croient, ce qui prouve que le problème de la forme, problème essentiel, n'est plus compris. Et pas seulement en Allemagne.
Q.: Comment expliquez-vous la montée du néo-paganisme, au sein des droites, spécialement en Allemagne et en France?
GM: Cette montée s'explique par la crise du christianisme. En Allemagne, après 1918, le protestantisme s'est dissous; plus tard, à la suite de Vatican II dans les années 60, ça a été au tour du catholicisme. On interprète le problème du christianisme au départ du concept d'«humanité». Or le christianisme ne repose pas sur l'humanité mais sur l'amour de Dieu, l'amour porté à Dieu. Aujourd'hui, les théologiens progressistes attribuent au christianisme tout ce qu'il a jadis combattu: les droits de l'homme, la démocratie, l'amour du lointain (de l'exotique), l'affaiblissement de la nation. Pourtant, du christianisme véritable, on ne peut même pas déduire un refus de la politique de puissance. Il suffit de penser à l'époque baroque. De nos jours, nous trouvons des chrétiens qui jugent qu'il est très chrétien de rejetter la distinction entre l'ami et l'ennemi, alors qu'elle est induite par le péché originel, que les théologiens actuels cherchent à minimiser dans leurs interprétations. Mais seul Dieu peut lever cette distinction. Hernán Cortés et Francisco Pizarro savaient encore que c'était impossible, contrairement à nos évêques d'aujourd'hui, Lehmann et Kruse. Cortés et Pizarro étaient de meilleurs chrétiens que ces deux évêques. Le néo-paganisme a le vent en poupe à notre époque où la sécularisation s'accélére et où les églises elles-mêmes favorisent la dé-spiritualisation. Mais être païen, cela signifie aussi prier. Demandez donc à l'un ou l'autre de ces néo-païens s'il prie ou s'il croit à l'un ou l'autre dieu païen. Au fond, le néo-paganisme n'est qu'un travestissement actualisé de l'athéisme et de l'anticléricalisme. Pour moi, le néo-paganisme qui prétend revenir à nos racines est absurde. Nos racines se situent dans le christianisme et nous ne pouvons pas revenir 2000 ans en arrière.
Q.: Alors, le néo-paganisme,
de quoi est-il l'indice?
GM: Il est l'indice que nous vivons en décadence. Pour stigmatiser la décadence, notre époque a besoin d'un coupable et elle l'a trouvé dans le christianisme. Et cela dans un monde où les chrétiens sont devenus rarissimes! Le christianisme est coupable de la décadence, pensait Nietzsche, ce «fanfaron de l'intemporel» comme aimait à l'appeler Carl Schmitt. Nietzsche est bel et bien l'ancêtre spirituel de ces gens-là. Mais qu'entendait Nietzsche par christianisme? Le protestantisme culturel libéral, prusso-allemand. C'est-à-dire une idéologie qui n'existait pas en Italie et en France; aussi je ne saisis pas pourquoi tant de Français et d'Italiens se réclament de Nietzsche quand ils s'attaquent au christianisme.
Q.: Monsieur Maschke, nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien.
(une version abrégée de cet entretien est parue dans Junge Freiheit n°6/91; adresse: JF, Postfach 147, D-7801 Stegen/Freiburg).
00:05 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, entretien, réflexions personnelles, politique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 11 janvier 2010
Der absolute Krieg
 Der absolute Krieg
Der absolute Krieg
Da man den unabhängigen Willen des Gegners sich gegenüber hat, so gilt es, diesen Willen zu brechen. Dies geschieht mit Hilfe der eigenen Machtmittel und der eigenen Willenskraft. Wenn sich die eigenen Machtmittel als unzureichend erweisen oder die eigene Willenskraft der des Gegners nachsteht, müssen daraus gewissen Gegengewichte erwachsen. Diese beiden Faktoren sind daher von geradezu entscheidender Bedeutung. Jeder Kriegführende wird folgerichtig bestrebt sein, sie zu möglichst grosser Wirkung zu bringen, d. h. die "äusserste Anstrengung der Kräfte" vorzubereiten und in die Tat umzusetzen.
Theoretisch betrachtet, müsste man nun zu einem Maximum an personeller, materieller, wirtschaftlicher und willensmässiger Anstrengung gelangen können, aus dem sich ein völlig ungehemmter Krieg ergeben würde, den Clausewitz mit dem Begriff "Absoluter Krieg" umfasst. Aber das ist nur höchst selten der Fall. Vielmehr ist "die Gestalt, die der Krieg gewinnt, abhängig von allem Fremdartigen, was sich darin einmischt und daran ansetzt..., von aller natürlichen Schwere und Reibung der Teile, der ganzen Inkonsequenz, Unklarheit und Verzagtheit des menschlichen Geistes".
Der "absolute" oder, wie ihn Clausewitz gelegentlich auch nennt, der "abstrakte" Krieg hat also mit dem Krieg, wie er sich in der Wirklichkeit abspielt, nur wenig zu tun. Wenn auch gerade in neuester Zeit seit dem Zeitalter Napoleons das offensichtliche Bestreben zutage tritt, dem Kriege auch in der Wirklichkeit eine absolute Gestalt zu verleihen, so wurde dies doch noch nie in der letzten Vollkommenheit erreicht. Selbst die glänzendsten Feldzüge weisen hier und da, wenn auch kleinere, Lücken auf, die z. B. durch unvermeidliche Fehler von Unterführerm hervorgerufen worden sind.
Friedrich von Cochenhausen, Der Wille zum Sieg. Clausewitz´ Lehre von den dem Kriege innewohnenden Gegengewichten und ihrer Überwindung, erläutert am Feldzug 1814 in Frankreich, Berlin 1943.
00:10 Publié dans Polémologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, guerre, sociologie, théorie politique, sciences politiques, politologie, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 10 janvier 2010
La "Bulle d'or" est proclamée...
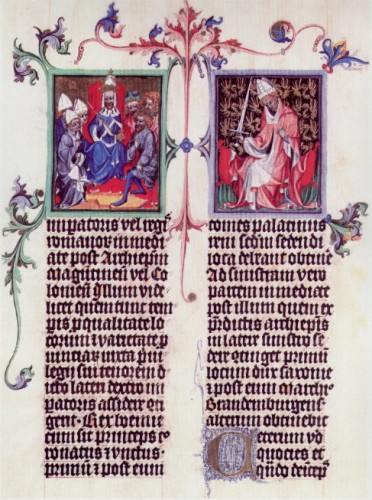
10 janvier 1356: L’Empereur du Saint Empire Romain de la Nation Germanique, Charles IV, proclame la “Bulle d’Or”, un édit impérial qui fixe les règles déterminant l’élection des rois germaniques et les droits des princes électeurs (Kurfürsten), sans prévoir un quelconque assentiment du Pape. Les électeurs sont au nombre de huit: les archevêques de Cologne, de Mayence et de Trêves, le roi de Bohème, le comte palatin du Rhin, le Duc de Saxe-Wittemberg, le margrave de Brandebourg.
00:13 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne, moyen âge, époque médiévale, saint empire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 09 janvier 2010
Spuren
 Spuren
Spuren
Das Wesen dieses Glaubens ist vielleicht am besten getroffen, wenn man darum besorgt ist, das Heil seiner Seele nicht zu verscherzen, damit die Selbstachtung zu verlieren und mit der eigenen Würde auch das Gewissen zu ertöten.
Josef Strzygowski, Geistige Umkehr. Indogermanische Gegenwartsstreifzüge eines Kunstforschers, Heidelberg 1938, S. 81.
00:10 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, révolution conservatrice, indo-européens |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 08 janvier 2010
Armin Mohler et la révolution conservatrice
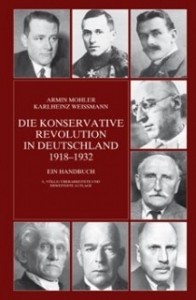 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Armin Mohler et la «Révolution Conservatrice»
(2ième partie)
par Luc PAUWELS
Dans notre numéro 59/60 de novembre-décembre 1989, Robert Steuckers avait analysé la première partie de l'introduction théorique d'Armin Mohler. Au même moment, Luc Pauwels, directeur de la revue Teksten, Kommentaren en Studies (in nr. 55, 2de trimester 1989), se penchait sur le même maître-ouvrage de Mohler et mettait l'accent sur la seconde partie théorique, notamment sur la classification des différentes écoles de ce mouvement aux strates multiples. Nous ne reproduisons pas ci-dessous l'entrée en matière de Pauwels, car ce serait répéter en d'autres mots les propos de Steuckers. En revanche, le reste de sa démonstration constitue presque une sorte de suite logique à l'analyse parue dans notre n°59/60.
Débuts et contenu
Les premiers balbutiements de la Révolution Conservatrice, écrit Mohler, ont lieu lors de la Révolution française: «Toute révolution suscite en même temps qu'elle la contre-révolution qui tente de l'annihiler. Avec la Révolution française, advient victorieusement le monde qui, pour la Révolution Conservatrice représente l'adversaire par excellence. Définissons provisoirement ce monde comme celui qui refuse de mettre l'immuable de la nature humaine au centre de tout et croit que l'essence de l'homme peut être changée. La Révolution française annonce ainsi la possibilité d'un progrès graduel et estime que toutes les choses, relations et événements sont explicables rationnellement; de ce fait, elle essaie d'isoler chaque chose de son contexte et de la comprendre ainsi pour soi».
Mohler nous rappelle ensuite un malentendu tenace, que l'on rencontre très souvent lorsque l'on évoque la Révolution Conservatrice. Un malentendu qui, outre la confusion avec le fascisme et le national-socialisme, lui a infligé beaucoup de tort: c'est l'idée erronée qui veut que tout ce qui est (ou a été) fait et dit contre la Révolution française, son idéologie et ses conséquences, relève de la Révolution Conservatrice.
La Révolution de 1789 a dû faire face, à ses débuts, à deux types d'ennemis qui ne sont en aucune manière des précurseurs de la Révolution Conservatrice. D'abord, il y avait ses adversaires intérieurs, qui estimaient que les résultats de la Révolution française et/ou de son idéologie égalitaire étaient insuffisants. Cette opposition interne a commencé avec Gracchus Babeuf (1760-1797), adepte d'«Egalité parfaite» (la majuscule est de lui), qui voulait supprimer toutes les formes de propriété privée et espérait atteindre l'«Egalité des jouissances». Sa tentative de coup d'Etat, appelée la «Conjuration des Egaux», fut tué dans l'œuf et l'aventure se termina en parfaite égalité le 27 mai 1797... sous le couperet de la guillotine.
Toutes les tendances qui puisent leur inspiration dans l'égalitarisme de Babeuf et qui, sur base de ces idées, critiquent la Révolution française, n'ont rien à voir, bien entendu, avec la Révolution Conservatrice (RC). Elles appartiennent, pour être plus précis, aux traditions du marxisme et de l'anarchisme de gauche.
Ensuite, la Révolution française, dès ses débuts, a eu affaire à des groupes qui la combattaient pour maintenir ou récupérer leurs positions sociales (matérielles ou non), que les Jacobins menaçaient de leur ôter ou avaient détruites. Les adeptes de la RC ont toujours eu le souci de faire la différence entre leur propre attitude et cette position; ils ont qualifié l'action qui en découlait, écrit Mohler, de «restauratrice», de «réactionnaire», d'«altkonservativ» («vieille-conservatrice»), etc. Mais, au cours du XIXième siècle, les tenants de la RC (qui ne porte pas encore son nom, ndt) et les «Altkonservativen» font face à un ennemi commun, ce qui les force trop souvent à forger des alliances tactiques avec les réactionnaires, à se retrouver dans le même camp politique. Ainsi, la différence essentielle qui sépare les uns des autres devient moins perceptible pour les observateurs extérieurs. Dans les rangs mêmes de la RC, on s'aperçoit des ambiguïtés et le discours s'anémie. Pour les RC de pure eau, ces alliances et ces ambiguïtés auront trop souvent des conséquences fatales. Mohler nous l'explique: «Car, à la RC, n'appartiennent —comme le couplage paradoxal des deux mots l'indique— que ceux qui s'attaquent aux fondements du siècle du progrès sans simplement vouloir une restauration de l'Ancien Régime».
Sous sa forme pure, la RC est toujours restée au stade de la formulation théorique. Rauschning, lui aussi, décrit ce caractère composite dans son ouvrage intitulé précisément Die Konservative Revolution: «Le mouvement opposé, qui se dresse contre le développement des idées révolutionnaires, a amorcé sa croissance au départ de stades initiaux embrouillés et semi-conscients, pour atteindre ce que nous nommons, avec Hugo von Hoffmannstahl, la RC. Elle représente le renversement complet de la tendance politique actuelle. Mais ce contre-mouvement n'a pas encore trouvé d'incarnation pure, adaptée à lui-même. Il participe aux tentatives d'instaurer des modèles d'ordre totalitaire et césariste ou à des essais plattement réactionnaires. C'est pour toutes ces raisons, précisément, qu'il reste confus et brouillon...».
Sur base de cette constatation, Mohler observe que toute description cohérente du processus de maturation de la RC se mue automatiquement en une véritable histoire des idées. Si on cherche à la décrire comme une partie intégrante de la réalité politique, elle déchoit en un événement subalterne ou marginal. De ce fait, il ne faut pas donner des limites trop exiguës à la RC: elle déborde en effet sur d'autres mouvements, d'autres courants de pensée. Et vu le flou de ces limites, flou dû à la très grande hétérogénéité des choses que la RC embrasse, des choses qui font irruption dans son champs, Mohler est obligé de tracer une démarcation arbitraire afin de bien circonscrire son sujet. Il s'explique: «Au sens large, le terme "Révolution Conservatrice" englobe un ensemble de transformations s'appuyant sur un fondement commun, des transformations qui se sont accomplies ou qui s'annoncent, et qui concerne tous les domaines de l'existence, la théologie comme par exemple les sciences naturelles, la musique comme l'urbanisme, les relations interfamiliales comme les soins du coprs ou la façon de construire une machine. Dans notre étude, nous nous bornerons à donner une définition exclusivement politique au terme; notre étude se limitant à l'histoire des idées, nous désignons par "Révolution Conservatrice" une certaine pensée politique».
Les pères fondateurs, les précurseurs et les parrains
Une pensée politique, une Weltanschauung, implique qu'il y ait des penseurs. Mohler les appelle les Leitfiguren, les figures de proue, que nous nommerions par commodité les «précurseurs». Mohler souligne, dans la seconde partie de son ouvrage, inédite dans les premières éditions, que l'intérêt pour les précurseurs s'est considérablement amplifié. Les figures qui ont donné à la RC sa plus haute intensité spirituelle et psychique, ses penseurs les plus convaincants et aussi ses incarnations humaines les plus irritantes ont désormais trouvé leurs biographes et leurs analystes».
Si l'on parle de «père fondateur», il faut évidemment citer Friedrich Nietzsche (1844-1900), reconnu par les amis et les ennemis comme l'initiateur véritable du phénomène intellectuel et spirituel de la RC. A côté de lui, le penseur français, moins universellement connu, Georges Sorel (1847-1922)... Nous reviendrons tout à l'heure sur ces deux personnages centraux.
Au second rang, une génération plus tard, nous trouvons le «trio» (ainsi que le nomme Mohler): Carl Schmitt (1888-1985), Ernst Jünger (°1895) et Martin Heidegger (1889-1976). Mohler cite ensuite toute une série de penseurs dont l'influence sur la RC est sans doute moins directe mais non moins intense. Les parrains non-allemands sont essentiellement des sociologues et des historiens du début de notre siècle qui, très tôt, avaient annoncé le crise du libéralisme bourgeois: les Italiens Vilfredo Pareto (1848-1923) et Gaëtano Mosca (1858-1941), l'Allemand Robert(o) Michels (1876-1936), installé en Italie, l'Américain d'origine norvégienne Thorstein Veblen (1857-1929). L'Espagne nous a donné Miguel de Unamuno (1864-1936) puis, une génération plus tard, José Ortega y Gasset (1883-1956). La France, elle, a donné le jour à Maurice Barrès (1862-1923).
Quelques-uns de ces penseurs revêtent une double signification pour notre propos: ils sont à la fois «parrains» de la RC en Allemagne et partie intégrante dans les initiatives conservatrices-révolutionnaires qui ont animé la scène politico-idéologiques dans nos propres provinces.
Parmi les «parrains» allemands de la RC, Mohler compte le compositeur Richard Wagner (1813-1883), les poètes Gerhart Hauptmann (1862-1946) et Stefan George (1868-1933), le psychologue Ludwig Klages (1872-1956) et, bien sûr, Thomas Mann (1875-1955), Gottfried Benn (1896-1956) et Freidrich-Georg Jünger (1898-1977), le frère d'Ernst.
D'autres parrains allemands sont à peine connus dans nos provinces; Mohler les cite: les poètes Konrad Weiss (1880-1940) et Alfred Schuler (1865-1923), les écrivains Rudolf Borchardt (1877-1945) et Léopold Ziegler (1881-1958), un ami d'Edgar J. Jung, connu surtout pour son livre Volk, Staat und Persönlichkeit («Peuple, Etat et personnalité»; 1917). Enfin, il y a Max Weber (1864-1920), le plus grand sociologue que l'Allemagne ait connu, célèbre dans le monde entier mais pas assez pratiqué dans nos cercles non-conformistes.
La RC dans
d'autres pays
Pour Mohler, la RC est «un phénomène politique qui embrasse toute l'Europe et qui n'est pas encore arrivé au bout de sa course». Dans la préface à la première édition de son ouvrage, nous lisons que la RC est «ce mouvement de rénovation intellectuelle qui tente de remettre de l'ordre dans le champs de ruines laissé par le XIXième siècle et cherche à créer un nouvel ordre de la vie. Mais si nous ne sélectionnons que la période qui va de 1918 à 1932, nous pouvons quand même affirmer que la RC commence déjà au temps de Goethe et qu'elle s'est déployée sans interruption depuis lors et qu'elle poursuit sa trajectoire aujourd'hui sur des voies très diverses. Et si nous ne présentons ici que la partie allemande du phénomène, nous n'oublions pas que la RC a touché la plupart des autres pays européens, voire certains pays extra-européens».
Mohler réfute la thèse qui prétend que la RC est un phénomène exclusivement allemand. Il suffit de nommer quelques auteurs pour ruiner cet opinion, explique Mohler. Quelques exemples: en Russie, Dostoievski (1821-1881), le grand écrivain, chaleureux nationaliste et populiste russe; les frères Konstantin (1917-1860) et Ivan S. Axakov (1823-1886). En France, Georges Sorel (1847-1922), le social-révolutionnaire le plus original qui soit, et Maurice Barrès (1862-1923). Ensuite, le philosophe, homme politique et écrivain espagnol Miguel de Unamuno (1864-1936), l'économiste et sociologue italien Vilfredo Pareto (1848-1923), célèbre pour sa théorie sur l'émergence et la dissolution des élites. En Angleterre, citons David Herbert Lawrence (1885-1930) et Thomas Edward Lawrence (1888-1935), qui fut non seulement le mystérieux «Lawrence d'Arabie» mais aussi l'auteur des Seven Pillars of Wisdom, de The Mint, etc.
Cette liste pourrait être complétée ad infinitum. Bornons-nous à nommer encore T.S. Eliot et le grand Chesterton pour la Grande-Bretagne et Jabotinski pour la diaspora juive. Tous ces noms ne sont choisis qu'au hasard, dit Mohler, parmi d'autres possibles.
Dans les Bas Pays de l'actuel Bénélux, on observe un contre-mouvement contre les effets de la Révolution française dès le début du XIXième siècle. En Hollande, les conservateurs protestants se donnèrent le nom d'«antirévolutionnaires», ce qui est très significatif. Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) et Abraham Kuyper (1837-1920) donnèrent au mouvement antirévolutionnaire et au parti du même nom (ARP, depuis 1879) une idéologie corporatiste et organique de facture nettement populiste-conservatrice (volkskonservatief). Conrad Busken Huet (1826-1886), prédicateur, journaliste et romancier, infléchit son mouvement, Nationale Vertoogen, contre le libéralisme, héritier de la Révolution française. Son ami Evert-Jan Potgieter (1808-1875) qui, en tant qu'auteur et co-auteur de De Gids, avait beaucoup de lecteurs, évolua, lui aussi, dans sa critique de la société, vers des positions conservatrices-révolutionnaires; il décrivait ses idées comme participant d'un «radicalisme conservateur» (konservatief radikalisme).
Après la première guerre mondiale, aux Pays-Bas, les idéaux conservateurs-révolutionnaires avaient bel et bien pignon sur rue et se distinguaient nettement du conservatisme confessionnel. Ainsi, le Dr. Emile Verviers, qui enseignait l'économie politique à l'Université de Leiden, adressa une lettre ouverte à la Reine, contenant un programme assez rudimentaire d'inspiration conservatrice-révolutionnaire. Sur base de ce programme rudimentaire, une revue vit le jour, Opbouwende Staatkunde (Politologie en marche). Le philosophe et professeur Gerard Bolland (1854-1922) prononça le 28 septembre 1921 un discours inaugural à l'Université de Leiden, tiré de son ouvrage De Tekenen des Tijds (Les signes du temps), qui lança véritablement le mouvement conservateur-révolutionnaire aux Pays-Bas et en Flandre.
Dans les lettres néerlandaises, dans la vie intellectuelle des années 20 et 30, les tonalités et influences conservatrices-révolutionnaires étaient partout présentes: citons d'abord la figure très contestée d'Erich Wichman sans oublier Anton van Duinkerken, Gerard Knuvelder, Menno ter Braak, Hendrik Marsman et bien d'autres. En Flandre, la tendance conservatrice-révolutionnaire ne se distingue pas facilement du Mouvement Flamand, du nationalisme flamand et du courant Grand-Néerlandais: la composante national(ist)e de la RC domine et refoule facilement les autres. Hugo Verriest et Cyriel Verschaeve, deux prêtres, doivent être mentionnés ici (1), de même qu'Odiel Spruytte (1891-1940), un autre prêtre peu connu mais qui fut très influent, surtout parce qu'il était un brillant connaisseur de l'œuvre de Nietzsche (2). En dehors du mouvement flamand, il convient de mentionner le leader socialiste Henri De Man (3), le Professeur Léon van der Essen (4) et Robert Poulet, récemment décédé et auteur, entre autres, de La Révolution est à droite (5). Sans oublier le Baron Pierre Nothomb (6), chef des Jeunesses Nationales et Charles Anciaux de l'Institut de l'Ordre Corporatif (7).
Les noms de Lothrop Stoddard et de Madison Grant, défenseurs soucieux de l'identité de la race blanche, de James Burnham, théoricien de The Managerial Revolution, mais aussi auteur du The Suicide of the West et de The War we are in, montrent que les Etats-Unis aussi ont contribué à la RC. Dans les grands bouleversements qui affectent depuis quelques dizaines d'années l'Afrique, l'Asie et l'Amérique Latine, on peut, explique Mohler, trouver des phénomènes apparentés: «Notamment le mélange, caractéristique de la RC, de lutte pour la libération nationale, de révolution sociale et de rédécouverte de sa propre identité».
Le mouvement ouvrier péroniste en Argentine, avec Juan et Evita Perón, constitue, sur ce chapitre, un exemple d'école. Plus nettement marquée encore est l'œuvre du révolutionnaire chinois, le Dr. Sun Ya-Tsen (1866-1925), fondateur du Kuo-Min-Tang, qui, dans son livre Les trois principes du peuple (8), prêche explicitement pour le nationalisme, la révolution sociale et la voie chinoise vers la démocratie.
Mohler pose un constat: le fait que la Révolution française a mis en branle un contre-mouvement conservateur dont le point focal a été l'Allemagne, indique clairement que nous avons affaire à un phénomène de dimensions au moins européennes; «L'accent mis sur l'élément allemand dans la RC mondiale se justifie sur certains plans. Mêmes les expressions non allemandes de cette révolution intellectuelle contre les idées de 1789 s'enracinent dans ce chapitre de l'histoire des idées en Allemagne, qui s'étend de Herder au Romantisme. En Allemagne même, cette révolte a connu sa plus forte intensité».
L'un des facteurs qui a le plus contribué à l'européanisation générale de la RC est sans conteste la large diffusion des œuvres et des idées de Nietzsche. Armin Mohler tente de ne pas englober Nietzsche dans la RC, mais démontre de façon convaincante que sans Nietzsche, le mouvement n'aurait pas acquis ses Leitbilder («images directrices») typiques et communes. Son influence s'est faite sentir dans les Bas Pays, notamment chez le jeune August Vermeylen (9) et, d'après H.J. Elias (10), sur toute une génération d'étudiants de l'Athenée d'Anvers, parmi lesquels nous découvrons Herman van den Reeck, Max Rooses, Lode Claes et d'autres figures célèbres. La philosophie de Nietzsche a permis qu'éclosent dans toute l'Europe des courants d'inspiration conservatrice-révolutionnaire.
Le Normand Georges Sorel, le second «père fondateur» de la RC selon Mohler (11), est toutefois resté inconnu dans nos régions. Cet ingénieur et philosophe n'a pratiquement jamais été évoqué dans notre entre-deux-guerres (12). A notre connaissance, la seule publication néerlandaise qui parle de lui est l'étude de J. de Kadt sur le fascisme italien; elle date de 1937 (13). On dit qu'il aurait exercé une influence discrète sur Joris van Severen (14) mais son meilleur biographe, Arthur de Bruyne (15), dont le travail est pourtant très fouillé, ne mentionne rien.
Les groupes «völkisch»
Nous ne devons pas concevoir la RC comme un ensemble monolithique. Elle a toujours été plurielle, contradictoire, partagée en de nombreuses tendances, mouvements et mentalités souvent antagonistes. Mohler distingue cinq groupes au sein de la RC; leurs noms allemands sont: les Völkischen, les Jungkonservativen et les Nationalrevolutionäre, dont les tendances idéologiques sont précises et distinctes. Ensuite, il y a les Bündischen et la Landvolkbewegung, que Mohler décrit comme des dissidences historiques concrètes qui n'ont produit des idéologies spécifiques que par la suite. Cette classification en cinq groupes de la RC allemande n'est pas aisément transposable dans les autres pays. Partout, on trouve certes les mêmes ingrédients mais en doses et mixages chaque fois différents. Cette prolixité rend évidemment l'étude de la RC très passionnante.
Le premier groupe, celui des Völkischen, met l'idée de l'«origine» au centre de ses préoccupations. Les mots-clefs sont alors, très souvent, le peuple (Volk), la race, la souche (Stamm) ou la communauté linguistique. Et chacun de ces mots-clefs conduit à l'éclosion de tendances völkische très différentes les unes des autres. Dans la foule des auteurs allemands de tendance völkische, signalons-en quelques-uns qui ont été lus et appréciés à titres divers chez nous, de manière à ce que le lecteur puisse discerner plus aisément la nature du groupe que par l'intermédiaire d'une longue démonstration théorique: Houston Stewart Chamberlain, Adolf Bartels, Hans F.K. Günther, Ernst Bergmann, Erich et Mathilde Ludendorff, Herman Wirth et Erwin Guido Kolbenheyer.
Chez nous, quand la tendance völkische est évoquée, l'on songe tout de suite à Cyriel Verschaeve qui y a indubitablement sa place. Les mots-clefs volk (peuple) et taal (langue) peuvent toutefois nous induire en erreur car l'ensemble du mouvement flamand a pris pour axes ces deux vocables. Une fraction seulement de ce mouvement peut être considérée comme appartenant à la tendance völkische, notamment une partie de l'orientation grande-néerlandaise qui, explicitement, plaçait le «principe organique de peuple» (organische volksbeginsel), théorisé par Wies Moens (16), ou le «principe national-populaire», au-dessus de toutes autres considérations politiques et/ou philosophiques. Nous songeons à Wies Moens lui-même et à la revue Dietbrand, à Ferdinand Vercnocke, à Robrecht de Smet et sa Jong-Nederlandse Gemeenschap (Communauté Jeune-Néerlandaise), à l'aile dite Jong-Vlaanderen (Jeune-Flandre) de l'activisme (17), à l'anthropologue Dr. Gustaaf Schamelhout (18), etc.
Au sein de la tendance völkische a toujours coexisté, chez nous, une tradition basse-allemande (nederduits), à laquelle appartenaient Victor Delecourt et Lodewijk Vlesschouwer (qui participait, e.a., à la revue De Broederhand), le Aldietscher (Pan-Thiois) Constant Jacob Hansen (1833-1910) (19) et le germanisant plus radical encore Pol de Mont (1857-1931), qui déjà avant la première guerre mondiale avait développé son propre corpus völkisch.
Le groupe des Jungkonservativen
A rebours de volks (völkisch), le terme de jungkonservativ (jongkonservatief) n'a jamais, à ma connaissance, été utilisé dans nos provinces. En Allemagne, démontre Mohler, le terme jungkonservativ est le vocable classique qu'ont utilisé les fractions du mouvement conservateur qui, par l'adjonction de l'adjectif «jeune» (jung), voulaient se démarquer du conservatisme antérieur, purement «conservant» et réactionnaire, l'Altkonservativismus. Les Jungkonservativen s'opposent, en esprit et sur la scène politique, au monde légué par 1789 et tirent de cette opposition des conséquences résolument révolutionnaires. Les grandes figures du Jungkonservativismus, également connue hors d'Allemagne, sont notamment Oswald Spengler (20), Arthur Moeller van den Bruck (21), Othmar Spann, Hans Grimm et Edgar J. Jung.
Le peuple et la langue, concepts-clefs des Völkischen, ne sont certes pas niés par les Jungkonservativen, encore moins méprisés. Mais pour eux, ces concepts ne sont pas pertinents si l'on veut construire un ordre: ils conduisent à la constitution d'Etats nationaux fermés, monotone, comparables aux Etats d'inspiration jacobine. De plus, ces Etats précipitent l'Europe, continent qui n'a que peu de frontières linguistiques et ethniques précises, dans des conflits frontaliers incessants, dans des querelles d'irrédentisme, des guerres balkaniques. En pervertissant le principe völkisch, ils provoquent une extrême intolérance à l'encontre des minorités ethniques et linguistiques à l'intérieur de leurs propres frontières. De tels débordements, l'histoire en a déjà assez connus.
Le mot-clef pour les Jungkonservativen est dès lors le Reich. L'idée de Reich, prisée également dans les Bas Pays, n'implique pas un Etat fermé à peuple unique ni un Etat créé par un peuple conquérant sachant manier l'épée. Le Reich est une forme de vivre-en-commun propre à l'Europe, né de son histoire, qui laisse aux souches ethniques et aux peuples, aux langues et aux régions, leurs propres identités et leurs propres rythmes de développement, mais les rassemble dans une structure hiérarchiquement supérieure. Dans ce sens, explique Mohler, l'Etat de Bismarck et celui de Hitler ne peuvent être considérés comme des avatars de l'idée de Reich. Ce sont des formes étatiques qui oscillent entre l'Etat-Nation de type jacobin et l'Etat-conquérant impérialiste à la Gengis Khan.
En langue néerlandaise, Reich peut parfaitement se traduire par rijk. Dans d'autres langues, le mot allemand est souvent traduit à la hâte par des mots qui n'ont pas le même sens: «Empire» suggère trop la présence d'un empereur; «Imperium» fait trop «impérialiste»; «Commonwealth» suggère une association de peuples beaucoup plus lâche.
Mentionnons encore trois particularités qui nous donnerons une image plus complète du groupe jungkonservativ. D'abord, l'influence chrétienne est la plus prononcée dans ce groupe. L'idée médiévale de Reich est perçue par quelques-uns de ces penseurs jungkonservativ comme essentiellement chrétienne, qualité qui demeurera telle, affirment-ils, même si l'idée doit connaître encore des avatars historiques. Les Jungkonservativen chrétiens perçoivent la catholitas comme une force fédératrice des peuples, comme une sorte de ciment historique. Pour eux, cette catholitas ne semble donc pas un but en soi mais un instrument au service de l'idée de Reich.
Ensuite, ces Jungkonservativen cutlivent une nette tendance à peaufiner leur pensée juridique, à ébaucher des structures et des ordres juridiques idéaux. C'est en tenant compte de cet arrière-plan que le deuxième concept-clef de la sphère jungkonservative, en l'occurrence l'idée d'ordre, prend tout son sens. En dehors de l'Allemagne, c'est incontestablement ce concept-là qui a été le plus typique. Mohler écrit, à ce propos: «L'unité, à laquelle songent les Jungkonservativen (...) englobe une telle prolixité d'éléments, qu'elle exige une mise en ordre juridique».
 Enfin, troisièmement, les Jungkonservativen sont les plus «civilisés» de la planète RC et, pour leurs adversaires, les plus «bourgeois». Après eux viennent les Völkischen, qui passent pour des philologues mystiques ou des danseurs de danses populaires, et les Nationaux-Révolutionnaires, qui font figures de dinamiteros exaltés. Des cinq groupes, les Jungkonservativen sont les seuls, dit Mohler, qui ne s'opposent pas de manière irréconciliable à l'environnement politique établi, soit à la République de Weimar. Ils sont restés de ce fait des interlocuteurs acceptés. Entre eux et les adversaires de la RC, les ponts n'ont pas été totalement coupés, malgré les césures profondes qui séparaient à l'époque les familles intellectuelles.
Enfin, troisièmement, les Jungkonservativen sont les plus «civilisés» de la planète RC et, pour leurs adversaires, les plus «bourgeois». Après eux viennent les Völkischen, qui passent pour des philologues mystiques ou des danseurs de danses populaires, et les Nationaux-Révolutionnaires, qui font figures de dinamiteros exaltés. Des cinq groupes, les Jungkonservativen sont les seuls, dit Mohler, qui ne s'opposent pas de manière irréconciliable à l'environnement politique établi, soit à la République de Weimar. Ils sont restés de ce fait des interlocuteurs acceptés. Entre eux et les adversaires de la RC, les ponts n'ont pas été totalement coupés, malgré les césures profondes qui séparaient à l'époque les familles intellectuelles.
Dans les Bas Pays, plusieurs figures de la vie intellectuelle étaient apparentées au courant jungkonservativ. Songeons à Odiel Spruytte qui, malgré son ancrage profond dans le Mouvement Flamand, restait un défenseur typique de l'«universalisme» d'Othmar Spann (22). Aux Pays-Bas, citons Frederik Carel Gerretsen, historien, poète (sous le pseudonyme de Geerten Gossaert) et homme politique (actif, entre autres, dans la Nationale Unie).
Lorque l'on recherche les traces de l'idéologie jungkonservative dans nos pays, il faut analyser et étudier les concepts de solidarisme et de personnalisme: les tenants de cette orientation doctrinale appartenaient très souvent à la démocratie chrétienne. Les «navetteurs» qui oscillaient entre la démocratie chrétienne et la RC, version jungkonservative, étaient légion.
Le Jungkonservativ le plus typé, le seul à peu près qui ait vraiment fait école chez nous, c'est Joris van Severen. Chez lui, les concepts-clefs d'«ordre» et d'«élite» sont omniprésents; sa pensée est juridico-structurante, ce qui le distingue nettement des nationalistes flamands aux démarches protestataires et friands de manifestations populaires. Autre affinité avec les Jungkonservativen: sa tendance à chercher des interlocuteurs dans l'aile droite de l'établissement... Mais ce qui est le plus étonnant, c'est la similitude entre sa pensée de l'ordre et l'idée de Reich des Jungkonservativen de l'ère weimarienne: Joris van Severen refuse la thèse «une langue, un peuple, un Etat» et part en quête d'un modèle historique plus qualitatif, reflet d'un ordre supérieur, mais très éloigné de l'Etat belge de type jacobin, qui, pour lui, était aussi inacceptable. Dans cette optique, ce n'est pas un hasard qu'il se soit référé aux anciens Pays-Bas, dans leur forme la plus traditionnelle, celle du «Cercle de Bourgogne» du Reich de Charles-Quint. Jacques van Artevelde (23) en avait lancé l'idée au Moyen Age et elle avait tenu jusqu'en 1795. L'argumentation qu'a développé Joris van Severen pour étayer son idéal grand-néerlandais dans le sens des Dix-Sept Provinces historiques (24), et contre toutes les tentatives de créer un Etat sur une base exclusivement linguistique, est au fond très semblable à celle qu'avait déployé Edgar J. Jung lorsqu'il polémiquait avec les Völkischen pour défendre l'idée de Reich. A la fin des années 30, van Severen parlait de plus en plus souvent du «Dietse Rijk» (de l'Etat thiois; du Regnum thiois), utilisant dans la foulée le vieux terme de Dietsland (Pays Thiois) (25) pour bien marquer la différence qui l'opposait aux «nationalistes linguistiques» (26).
Les nationaux-révolutionnaires
Le troisième groupe, celui des nationaux-révolutionnaires, est un produit typique de la «génération du front» en Allemagne. Il est plus difficile à cerner pour nous, dans les Bas Pays. De plus, la plupart des auteurs nationaux-révolutionnaires sont peu connus chez nous. Friedrich Hielscher, Karl O. Paetel, Arthur Mahraun, pour ne nommer que les plus connus d'entre eux, sont très souvent ignorés, même par les politologues les plus chevronnés. D'autres, en revanche, sont beaucoup plus célèbres. Mais cette célébrité, ils l'ont acquise pendant une autre période et pour d'autres activités que leur engagement national-révolutionnaire. Ainsi, Ernst von Salomon acquit sa grande notoriété pour ses romans à succès. Otto et Gregor Strasser, à la fin de leur carrière, ont été connus du monde entier parce qu'ils ont été les compagnons de route de Hitler, avant de s'opposer violemment à lui et, pour Gregor, de devenir sa victime. Ernst Niekisch, lui, est souvent considéré à tort comme un communiste parce qu'après la guerre il a enseigné à Berlin-Est (27). Mais cette notoriété, due à des faits et gestes posés en dehors de l'engagement politique, fait que les nationaux-révolutionnaires sont en général très mal situés. On les considère comme des «nazis de gauche», ce qui est inexact dans la plupart des cas, sauf peut-être pour Gregor Strasser, assassiné sur ordre de Hitler en 1934. Ou bien on les considère comme des communistes sans carte du parti, ce qui n'est vrai que pour quelques-uns d'entre eux.
En réalité, l'attitude nationale-révolutionnaire est le fruit d'une étincelle jaillie du choc entre l'extrême-gauche et l'extrême-droite. Les étincelles ne meurent pas si l'on parvient, grâce à elles, à allumer un foyer: ce que voulaient les nationaux-révolutionnaires. Ils considéraient plus ou moins les Völkischen comme des romantiques et des «archéologues» et les Jungkonservativen comme des individus qui voulaient construire du neuf avant que les ruines n'aient été balayées. Evacuer les ruines, mieux, contribuer énergiquement au déclin rapide du monde bourgeois, dénoncer la décadence capitaliste: voilà ce que les nationaux-révolutionnaires comprenaient comme leur tâche. Pour la mener à bien, ils présentait un curieux cocktail de passion sauvage et de froideur sans illusions, produit de leur expérience du front.
Mohler cite une phrase typique de Franz Schauwecker, figure de proue du «nationalisme soldatique»: «L'Allemand se réjouit de ses déclins parce qu'ils sont le rajeunissement». La gauche comme la droite sont dépassées pour les nationaux-révolutionnaires. Ils voulaient dépasser la gauche sur sa gauche et la droite sur sa droite. Pour eux, Staline était un conservateur et Hitler un libéral. Ce que les temps nouveaux apporteront, ils ne le savent pas trop: «mouvement», tel est le premier mot-clef. Le deuxième, c'est la «nation», celle qui est née dans les tranchées. Schauwecker décrit comment la réalité et la foi, comment l'instinct et la profondeur de la pensée, la nature et l'esprit ont fusionné. «Dans cette unité, la nation était soudainement présente». C'est cela pour eux, le nationalisme: la société allemande sans classes.
Au Pays-Bas, il y a eu une figure nationale-révolutionnaire bien typée: Erich Wichman (1890-1929), surnommé souvent avec mépris le «premier fasciste néerlandais», alors qu'il est très difficile de coller l'étiquette de fasciste (si l'on entend par fasciste, cette sorte de militaires d'opérette chaussés de belles bottes bien cirées) sur ce représentant impétueux de la bohème hollandaise, au visage déformé par un oeil de verre. Les noms des groupuscules qu'il a fondé De Rebelse Patriotten (Les Patriotes Rebelles), De Anderen (Les Autres), De Rapaljepartij (Le Parti de la Racaille) trahissent tous l'élan oppositionnel et le défi adressé à «tout ce qui est d'hier», assortis d'un résidu de foi nationale. A son ami, le Dr. Hans Bruch, il écrivit ces phrases révélatrices: «Je n'ai pas besoin de vous dire que, moi comme vous, nous souhaitons que les Pays-Bas et Orange soient au-dessus de tout! Mais... ce cri de guerre ne peut plus être un cri de guerre parce qu'il a été répété a satiété, éculé, galvaudé et usé par les nationalistes de vieille mouture; par de gros bonshommes tout gras affublés de moustaches tombantes, qui remplissent des salles de réunion pour se plaindre, se lamenter et se consumer en jérémiades parce que notre nation, hélas, n'a jamais eu assez de sentiment national. (...) Et nous, les combatifs, nous ne pouvons rien avoir en commun avec eux! Car, nous, nous ne voulons pas nous plaindre, mais agir. Mais nous ne voulons pas non plus pousser des cris de joie, car nous savons qu'en tant que peuple nous n'avons encore rien - nous avons la ferme volonté de mettre un terme définitif à notre misère!» (28).
La prose de Wichman, en violence et en radicalisme, ne cède en rien devant les phrases de Franz Schauwecker ou d'autres nationaux-révolutionnaires: «Tout, aujourd'hui, est cérébralisé et calculé. Il n'y a plus place en ce monde pour l'aventure, l'imprévu, l'élasticité, la fantaisie et la «démonie». La raison raisonnante la plus bête garde seule droit au chapitre. Dieu s'est mis à vivre peinard. Cette époque est morte, sans âme, sans foi, sans art, sans amour. (...) Ce n'est plus une époque, c'est une phase de transition mais qui peut nous dire vers où elle nous mène? Si tout devient autrement que nous le voulons — et pourquoi cela ne deviendrait-il pas autrement? On pourra une fois de plus nous appeler "les fous". Tout acte peut être folie, est en un certain sens une folie. Et celui qui craint d'être appelé un "fou", d'être un "fou", celui qui craint d'être une part vivante d'un tout vivant, celui qui ne veut pas "servir", celui qui ne veut pas être "facteur" en invoquant sa précieuse "personnalité" et ainsi faire en sorte qu'advienne un monde contraire à ses pensées, celui qui a peur d'être un «lépreux de l'esprit», qui ne veut être "particule", qui ne veut être ni une feuille dans le vent ni un animal soumis à la nécessité ni un soldat dans une tranchée ni un homme armé d'un gourdin et d'un revolver sur la Piazza del Duomo (ou sur le Dam); celui qui ne commence rien sans apercevoir déjà la fin, qui ne fait rien pour ne pas commettre de sottise: voilà le véritable âne! On ne possède rien que l'on ne puisse jeter, y compris soi-même et sa propre vie. C'est pourquoi, il serait peut-être bon de nous débarrasser maintenant de cette "République des Camarades", de cette étable de "mauvais bergers". Oui, avec violence, oui, avec des "moyens illégaux"! C'est par des phrases que le peuple a été perverti, ce n'est pas par des phrases qu'il guérira (Multatuli) (29). Donc, répétons-le: aux armes!».
Le type du national-révolutionnaire a également fait irruption sur la scène politique flamande, surtout dans les tumultueuses années 20. Notamment dans le groupe Clarté et dans sa nébuleuse, qui voulaient forger un front unitaire révolutionnaire regroupant les frontistes flamands (30), les communistes, les anarchistes et les socialistes minoritaires. On hésite toutefois à ranger des individus dans cette catégorie car l'engagement proprement national-révolutionnaire n'a quasi jamais été qu'une phase de transition: quelques flamingants radicaux ont tenté de trouver une synthèse personnelle entre, d'une part, un engagement nationaliste flamand et, d'autre part, une volonté de lutte sociale-révolutionnaire. Après une hésitation, longue ou courte selon les individualités, cette synthèse a débouché sur un national-socialisme plus proche du sens étymologique du mot que de la NSDAP, encore peu connue à l'époque. Chez d'autres, la synthèse conduisit à un engagement résolument à gauche, à un socialisme voire un communisme teinté de nationalisme flamand.
Boudewijn Maes (1873-1946) est sans doute l'une des figures les plus hautes en couleurs du microcosme «national-révolutionnaire» flamand. Ce nationaliste flamand libre-penseur (vrijzinnig) avait lutté contre les activistes pendant la première guerre mondiale parce qu'ils étaient trop bourgeois à son goût. Après 1918, il les défendit parce qu'il était animé d'un sens aigu de la justice et parce qu'il s'estimait solidaire du combat national flamand. Aussi parce qu'il voyait en eux des victimes de l'«Etat bourgeois» belge et donc des révolutionnaires potentiels. En 1919, il est élu au Parlement belge sur les listes du Frontpartij. Il y restera seulement deux ans. Dans des groupuscules toujours plus petits, notamment au sein d'un Vlaams-nationaal Volksfront, il illustra un radicalisme pur, dont il ne faut pas exagérer la portée, et par lequel il voulait dépasser les socialistes et les communistes sur leur gauche. Plus tard, il passa au socialisme et mourut communiste flamand.
A propos des deux derniers groupes de la RC allemande, nous pouvons être brefs. Les Bündischen, héritiers des célèbres Wandervögel, constituent un phénomène typique dans l'histoire du mouvement de jeunesse allemand, lequel a véritablement alimenté tous les cénacles de la RC. Notre mouvement de jeunesse flamand, depuis Rodenbach (31), en passant par l'Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond (AKVS) (32), jusqu'au Diets Jeugdverbond, n'est pas comparable aux Bündischen sur le plan idéologique: la majeure partie des affiliés à l'AKVS, à ses successeurs et à ses émules, est restée, des années durant, fidèle à une sorte de tradition völkische catholisante. D'autres noyauteront l'aile droite de la démocratie chrétienne flamande. Cette communauté de tradition forme aujourd'hui encore le lien entre les groupes nationalistes flamands et certains cénacles du parti catholique. C'est l'idéologie de base que partagent notamment un journal comme De Standaard et les animateurs du pélérinage annuel à la Tour de l'Yser (IJzerbedevaart).
La Landvolkbewegung fut une révolte paysanne, brève mais violente, qui secoua le Slesvig-Holstein entre 1928 et 1932. On peut tracer des parallèles entre des événements analogues qui se sont produits au Danemark et en France mais, dans nos régions, nous n'apercevons aucun phénomène de même nature. Mohler lui-même, dans son Ergänzungsband (cf. références infra) de 1989, revient sur sa classification antérieure des strates de la RC en cinq groupes: la Landvolkbewegung a été de trop courte durée, trop peu chargée d'idéologie et trop dépendante d'orateurs issus d'autres groupes de la RC (surtout des nationaux-révolutionnaires) pour constituer à égalité un cinquième groupe.
Le fascisme défini
par les Staliniens
Mohler note que la littérature secondaire concernant la RC parue depuis 1972 (année de parution de la seconde édition de son maître-ouvrage) est devenue de plus en plus abondante et imprécise. La raison de cet état de choses: la propagation de la conception stalinienne du fascisme, y compris dans les milieux universitaires. «Cette conception, qui a l'élasticité du caoutchouc, est en fait un concept de combat, contenant tout ce que le stalinisme perçoit comme ennemi de ses desseins, jusque et y compris les sociaux-démocrates. Lorsque l'on parlait jadis du national-socialisme de Hitler ou du fascisme de Mussolini, on savait de quoi il était question. Mais le «fascisme allemand» peut tout désigner: la NSDAP, les Deutsch-Nationalen, la CDU, le capitalisme, Strauß comme Helmut Schmidt - et c'est précisément cette confusion qui est le but. Et bien sûr, la RC, elle aussi, aboutit dans cette énorme marmite».
Cette confusion a débouché d'abord sur une littérature tertiaire traitant du fascisme et dépourvue de toute valeur historique, ensuite sur des petits opuscules apologétiques qui «désinforment» en toute conscience. Prenons un exemple pour montrer comment le concept illimité de fascisme, propre au vocabulaire stalinien, s'est répandu dans le langage courant au cours des années 70 et 80: l'écrivain néerlandais Wim Zaal écrit un livre qui connaitra deux éditions, avec un titre chaque fois différent pour un contenu grosso modo identique. Ce changement de titre est révélateur. En 1966, l'ouvrage est titré De Herstellers (Les Restaurateurs). Il traite de plusieurs aspects de l'idéologie conservatrice-révolutionnaire aux Pays-Bas. La définition qu'il donne de cette idéologie n'est pas tout à fait juste mais elle a le mérite de ne pas être ambiguë et parfaitement concise; nous lui reprocherions de réduire l'univers conservateur-révolutionnaire à celui des adeptes de l'«ordre naturel», ce qui n'est pas le cas car d'autres traditions intellectuelles l'ont alimenté. Ecoutons sa définition: «Ce que visait le mouvement restaurateur, c'était précisément de restaurer l'ordre naturel du vivre-en-commun et de le débarrasser des maux que lui avait infligés les forces révolutionnaires à partir de 1780. Toutes les conséquences de ces révolutions n'étaient pas perverses mais leurs principes l'étaient». La seconde édition (remaniée) du livre paraît en 1973: elle traite du même sujet mais change de titre: De Nederlandse fascisten (Les fascistes néerlandais).
De Gorbatchev au Pape Jean-Paul II, de Reagan à Khomeiny, y a-t-il une figure de proue du monde politique ou de l'innovation idéologique qui n'ait jamais été traité de «fasciste» par l'un ou l'autre de ses adversaires? Dans de telles conditions, ne doit-on pas considérer que le mot est désormais vide de toute signification, du moins pour ce qui concerne le récepteur. En revanche, dans le chef de l'émetteur, le message est très clair; celui qui traite un autre de «fasciste», veut dire: «J'entends vous discriminer sur le plan intellectuel»; en d'autres mots: «Je refuse tout dialogue».
Ni dans cet article ni dans le travail de Mohler, le fait de dénoncer cet usage élastique du terme «fascisme» ne constitue pas une tentative d'évacuer du débat les rapports historiques réels qui ont existé entre, d'une part, la RC et, d'autre part, le fascisme ou le national-socialisme. La pensée révolutionnaire-conservatrice ne peut être purement et simplement réduite au rôle de «précurseur» de l'idéologie fasciste. ce serait trop facile et grotesque. A ce propos, Mohler écrit: «Tous ceux qui critiquent les idées de 1789 courent le risque de se voir étiquettés par les protagonistes de ces idées révolutionnaires de "pères fondateurs du fascisme" (ou du "nazisme") (...) D'Héraclite à Maître Eckehart, en passant par Paracelse et Luther, Frédéric le Grand, Hamann et Zinzendorf, pour aboutir à Schopenhauer et Kierkegaard, on peut, dans la foulée, construire les arbres généalogiques du fascisme les plus fantasmagoriques».
En réalité, parmi les protagonistes des idées conservatrices-révolutionnaires, on trouvera les appréciations et les attitudes les plus diverses vis-à-vis du fascisme, tant en Allemagne que dans nos pays. La prudence et la précision s'imposent. Quelques figures de la RC se sont en effet converties très vite et avec beaucoup d'enthousiasme au nazisme, comme, par exemple, un Alfred Bäumler ou un Ernst Kriek, ou, chez nous, un Herman van Puymbroeck (33), futur rédacteur-en-chef de Volk en Staat. D'autres ont vu leur enthousiasme s'évanouir rapidement, mais trop tard pour échapper à la mort: l'exemple de Gregor Strasser, assassiné le 30 juin 1934, un jour avant Edgar J. Jung, qui avait, lui, combattu le national-socialisme dès le début et avec la plus grande énergie. Thomas Mann et Karl Otto Paetel choisirent d'émigrer, tout comme Otto Strasser et Hermann Rauschning. Le national-révolutionnaire dur et pur, ennemi de Hitler, Hartmut Plaas, mourra en 1944 dans un camp de concentration tout comme l'avocat liégeois Paul Hoornaert, grand admirateur de Mussolini et chef de la Légion Nationale.
Pour d'autres encore, la collaboration mena à un ultime engagement dans la Waffen-SS, dont ils ne revinrent jamais; pour citer deux exemples, l'un flamand, l'autre néerlandais: Reimond Tollenaere (1909-1942) et Hugo Sinclair de Rochemont (1901-1942). Au cours de cette même année 1942, la collaboration était déjà un passé bien révolu pour un Henri De Man ou un Arnold Meijer, ex-chef du Zwart Front néerlandais. Quant à Tony Herbert, jadis figure symbolique de tout ce qui comptait à droite en Flandre dans les années 30, il était déjà entré de plein pied dans la résistance. Dans la véritable résistance à Hitler, derrière l'attentat du 20 juillet 1944, se profile une quantité de figures issues de la RC, notamment de la Brigade Ehrhardt, comme l'Amiral Wilhelm Canaris, le Général Hans Oster voire l'écrivain Ernst Jünger. Quant à l'homme qui, en 1945, dans le tout dernier numéro de Signal, la revue de propagande allemande qui paraissait dans la plupart des langues européennes pendant la guerre, publia un article pathétique pour marquer la fin du IIIième Reich, était une figure de la RC: Giselher Wirsing, issu du Tat-Kreis (34). En 1948, il participera à la fondation du journal Christ und Welt, dont il deviendra le rédacteur en chef en 1954 et le restera jusqu'à sa mort en 1975 (35).
Les noms que nous venons de citer ne constituent pas des exceptions. Loin de là. Tous répondent en quelque sorte à la règle. Mais comment expliquer à quelqu'un qui a été élevé sous l'égide du concept stalinien de fascisme, ou a reçu un enseignement universitaire marqué par ce concept, que c'est un fait historiquement attesté que dès le début de l'année 1933, le citoyen néerlandais Jan Baars (36), chef de l'Algemene Nederlandse Fascistenbond (ANFB; = Ligue Générale des Fascistes Néerlandais), envoie un télégramme à Hitler pour protester contre la persécution des Juifs (37). Le 30 janvier 1933, le jour où Hitler arriva au pouvoir, un autre télégramme partit de Hollande. Non pas envoyé par Jan Baars mais par l'association des étudiants catholiques d'Amsterdam, le cercle Thomas Aquinas. C'était un télégramme de félicitations. Précisons-le. Au cas où vous ne l'auriez pas deviné.
Luc PAUWELS.
(texte paru dans la revue anversoise Teksten, Kommentaren en Studies, nr. 55, 2de Trimester 1989; adresse: DELTAPERS v.z.w., Postbus 4, B-2110 Wijnegem).
(1) cfr. Arthur De Bruyne, Cyriel Verschaeve - Hendrik De Man, West-Pocket, 4-5, De Panne, 1969.
Jos Vinks, Cyriel Verschaeve, de Vlaming, De Roerdomp, Brecht/Antwerpen, 1977.
Hugo Verriest (1840-1922) fut l'élève de Guido Gezelle au couvent théologique de Roeselare (Roulers). Nommé prêtre en 1864. Enseigne à Bruges, Roeselare, Ypres, Heule. Curé à Wakken, commune de la famille de Joris van Severen en 1888. Exerça une influence prépondérante sur le mouvement étudiant nationaliste d'Albrecht Rodenbach (la fameuse Blauwvoeterij).
A son sujet, lire: Luc Delafortrie, Reinoud D'Haese, Noël Dobbelaere, Antoon Van Severen, Rudy Pauwels, Dr. R. Bekaert, Hugo Verriest - Joris Van Severen, Komitee Wakken, Wakken, 1984.
(2) Frank Goovaerts, «Odiel Spruytte. Een vergeten konservatief-revolutionnair denker in Vlaanderen», in Teksten, kommentaren en studies, nr. 55/1989.
(3) Sur De Man en français: André Philip, Henri De Man et la crise doctrinale du socialisme, Librairie universitaire J. Gambier, Paris, 1928.
Revue européenne des sciences sociales, Cahiers Vilfredo Pareto, Tome XII, 1974, n°31 («Sur l'œuvre de Henri De Man»).
Michel Brelaz, Henri De Man. Une autre idée du socialisme, Ed. des Antipodes, Genève, 1985.
En guise d'introduction générale: Robert Steuckers, «Henri De Man», in Etudes et Recherches, GRECE, Paris, n°3, 1984.
En anglais: Peter Dodge, Beyond Marxism. The Faith and Works of Hendrik De Man, M. Nijhoff, The Hague (NL), 1966.
(4) Léon van der Essen, Pages d'histoire nationale et européenne, Les Œuvres/Goemare, Bruxelles, 1942.
Léon van der Essen, Alexandre Farnèse et les origines de la Belgique moderne, 1545-1592, Office de publicité, Bruxelles, 1943.
Léon van der Essen, Pour mieux comprendre notre histoire nationale, Charles Dessart éd., s.d.
(5) Robert Poulet, La Révolution est à droite. Pamphlet, Denoël et Steele, Paris, 1934.
(6) Frederic Kiesel, Pierre Nothomb, Pierre de Meyere éd., Paris/Bruxelles, 1965.
(7) Charles Anciaux, L'Etat corporatif. Lois et conditions d'un régime corporatif en Belgique, ESPES, Bruxelles, 1942.
(8) Dr. Sun Ya-Tsen, The Three Principles of the People, China Publishing Company, Taipei R.O.C., 1981.
(9) August Vermeylen, écrivain flamand, né à Bruxelles en 1872 et mort à Uccle en 1945. Etudie à Bruxelles, Berlin et Vienne. Il enseignera à Bruxelles et à Gand. Sera démis de ses fonctions par les autorités allemandes en 1940. Influence de Baudelaire et du mouvement décadent français mais défenseur de la langue néerlandaise. Co-fondateur de la revue littéraire Van Nu en Straks. Individualiste anarchisant à ses débuts, il évoluera vers un socialisme communautaire, justifié par un panthéisme dynamique. Son œuvre la plus célèbre est De wandelende Jood (Le Juif errant), illustrant la quête de la vérité en trois phases: la jouissance sensuelle, l'ascèse et le travail.
(10) Hendrik J. Elias, Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte, 4 delen, Uitg. De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1971. Ces quatre volumes retracent l'histoire intellectuelle du mouvement flamand et recense minutieusement les influences diverses qu'il a subies, notamment celles venues des Pays-Bas, d'Allemagne et de Scandinavie. Ces ouvrages sont indispensables pour comprendre les lames de fond non seulement de l'histoire flamande mais aussi de l'histoire belge.
(11) Mohler se réfère surtout au livre de Michael Freund, Georges Sorel. Der revolutionäre Konservatismus (V. Klostermann, Frankfurt a.M., 1972). De même qu'aux passage que consacre Carl Schmitt à Sorel dans Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus (1926), aujourd'hui disponible en français sous le titre de Démocratie et Parlementarisme (Seuil, 1988).
(12) Sorel a exercé une incontestable influence sur le philosophe martyr José Streel (1910-1946), idéologue du rexisme et auteur, entre autres, de La Révolution du XXième siècle (Nouvelle Société d'Edition, Bruxelles, 1942). Dans cet ouvrage concis, on repère aussi l'influence prépondérante de Péguy, Maurras et De Man. Sur José Streel, lire ce qu'en écrit Bernard Delcord, «A propos de quelques "chapelles" politico-littéraires en Belgique (1919-1945)», in Cahiers du Centre de Recherches et d'Etudes historiques de la Seconde Guerre mondiale/Bijdragen van het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, Bruxelles, Ministère de l'Education nationale/Ministerie van Onderwijs, Archives Générales du Royaume - Algemeen Rijksarchief, Place de Louvain 4 (b.19), Bruxelles, 1986. On lira de même toutes les remarques que formule à son sujet le Prof. Jacques Willequet dans La Belgique sous la botte, résistances et collaborations, 1940-1945, Ed. Universitaires, Paris, 1986. Signalons aussi que José Streel fut l'un des artisans de l'accord Rex-VNV, règlant, dans le cadre de la collaboration, le problème linguistique belge.
(13) J. De Kadt, Het fascisme en de nieuwe vrijheid, N.V. Em. Querido's Uitgevers-Maatschappij, Amsterdam, 1939.
(14) Sur Joris Van Severen, lire: L. Delafortrie, Joris Van Severen en de Nederlanden, Oranje-Uitgaven, Zulte, 1963.
Jan Creve, Recht en Trouw. De Geschiedenis van het Verdinaso en zijn milities, Soethoudt, Antwerpen, 1987.
(15) Arthur De Bruyne, Joris Van Severen, droom en daad, De Roerdomp, Brecht/Antwerpen, 1961-63.
(16) Le poète Wies Moens (1898-1982) fut un activiste (un «collaborateur») pendant la première guerre mondiale. Il étudia à l'Université de Gand de 1916 à 1918. Il purgera quatre ans de prison pour ses sympathies nationalistes. Il fondera les revues Pogen (1923-25) et Dietbrand (1933-40). En 1945, il est condamné à mort mais trouve refuge aux Pays-Bas pour échapper à ses bourreaux. Il fut le principal représentant de l'expressionnisme flamand et entretint des liens avec Joris Van Severen, avant de rompre avec lui.
Cfr. Erik Verstraete, Wies Moens, Orion, Brugge, 1973.
(17) L'activisme est la collaboration germano-flamande pendant la première guerre mondiale. A ce propos, lire: Maurits van Haegendoren, Het aktivisme op de kentering der tijden, Uitgeverij De Nederlanden, Antwerpen, 1984.
(18) Frank Goovarts, «Dr. G. Schamelhout, antropologie en Vlaamse Beweging», in Teksten, kommentaren en studies, nr. 42, 1985. Le Dr. G. Schamelhout peut être considéré comme un élève de Georges Vacher de Lapouge. Il s'est intéressé également aux ethnies européennes.
(19) Le mouvement pan-thiois (Alldietscher Beweging) visait à unir toutes les «tribus» basses-allemandes, soit néerlandaises et allemandes du nord, en forgeant un Etat qui aurait rassemblé les Pays-Bas, la Belgique (avec les départements français du Nord et du Pas-de-Calais), la Prusse, le Hanovre, le Oldenbourg, etc. La langue de cet Etat aurait été une synthèse entre le néerlandais actuel et les dialectes bas-allemands. A ce sujet, lire: Ludo Simons, Van Duinkerke tot Königsberg. Geschiedenis van de Alldietsche Beweging, Orion, Brugge, 1980.
(20) Sur Spengler, l'ouvrage en français le plus complet est celui de Gilbert Merlio, Oswald Spengler, témoin de son temps, Akademischer Verlag Hans-Dieter Heinz, Stuttgart, 1982 (deux volumes).
(21) Sur Arthur Moeller van den Bruck, l'ouvrage en français le plus complet est celui de Denis Goeldel, Moeller van den Bruck (1876-1925), un nationaliste contre la révolution, Peter Lang, Frankfurt a.M./Bern, 1984.
(22) Deux livres récents sur Spann: Walter Becher, Der Blick aufs Ganze. Das Weltbild Othmar Spanns, Universitas, München, 1985.
J. Hanns Pichler (Hg.), Othmar Spann oder die Welt als Ganzes, Böhlau, Wien, 1988.
(23) Pour comprendre le mouvement d'unité dans les Bas Pays au Moyen Age, lire Léon Vanderkinderen, Le siècle des Artevelde. Etudes sur la civilisation morale et politique de la Flandre et du Brabant, J. Lebègue & Cie, Bruxelles, 1907.
(24) Les dix-sept provinces regroupent les pays suivants dans l'optique de Joris Van Severen et de ses adeptes de jadis et d'aujourd'hui: la Frise, le Groningue, la Drenthe, l'Overijssel, le Pays de Gueldre, le Pays d'Utrecht, la Hollande, la Zélande, le Brabant, le Limbourg (Limbourg historique, Limbourg belge, soit l'ex-Comté de Looz, Limbourg néerlandais contemporain), le Pays de Liège, le Pays de Namur, le Luxembourg (Grand-Duché, Luxembourg belge et Pays de Thionville/Diedenhofen), le Hainaut, la Flandre, l'Artois et la Picardie.
(25) Le terme néerlandais de «Dietsland» se traduit en français par «Pays Thiois». Le long de la frontière linguistique, en Pays de Liège, on trouve également la forme «tixhe», typique de l'ancienne graphie liégeoise. On parle également de «Lorraine thioise» pour désigner la partie allemande de la Lorraine.
(26) Van Severen semble être le seule représentant de la RC dans nos pays à avoir utiliser et revendiquer le terme de «conservateur-révolutionnaire». C'était dans un article du 23 juillet 1932, paru dans De West-Vlaming. Cité par Arthur De Bruyne, op. cit., p. 140.
Rappelons qu'une querelle demeure sous-jacente entre, d'une part, le nationalisme à base exclusivement linguistique, rêvant d'un Etat néerlandais unissant la Flandre et les Pays-Bas, et, d'autre part, les adeptes des Dix-Sept Provinces Unies, regroupant les régions néerlandophones, wallonophones, picardophones et germanophones de l'ancien «Cercle de Bourgogne».
(27) Pour comprendre l'itinéraire d'Ernst Niekisch, lire Uwe Sauermann, Ernst Niekisch und der revolutionäre Nationalismus, Bibliothekdienst Angerer, München, 1985.
(28) Cité par Wim Zaal dans De Nederlandse Fascisten, Wetenschapelijke Uigeverij, Amsterdam, 1973.
(29) Multatuli est le pseudonyme d'Eduard Douwes Dekker (1820-1887), écrivain néerlandais, pionnier de la colonisation de l'Indonésie. Lecteur de Nietzsche, il se posera en partisan d'une monarchie éclairée et d'un système d'éducation non étouffant. Son roman le plus célèbre est Max Havelaer, une chronique assez satirique de la colonie néerlandaise en Indonésie.
(30) Le frontisme est le mouvement politique des années 20 en Flandre, porté par les soldats revenus du front. Sur la scène électorale, il se présentait sous la dénomination de Frontpartij. Ce mouvement d'anciens soldats du contingent était pacifiste et soucieux de ne plus verser une seule goutte de sang flamand pour la France, considérée comme ennemie mortelle des peuples germaniques et du catholicisme populaire.
(31) Albrecht Rodenbach (1856-1880), jeune poète flamand, formé au séminaire de Roeselare (Roulers), élève de Hugo Verriest (cf. supra), fonde, en entrant à la faculté de droit de l'Université Catholique de Louvain, le mouvement étudiant flamand, la Blauwvoeterij. Ses poèmes mêlent un catholicisme charnel et sensuel, typiquement flamand, à un paganisme wagnérien, nourri de l'épopée des Nibelungen: un contraste étonnant et explosif...
A son sujet, lire: Cyriel Verschaeve, Albrecht Rodenbach. De Dichter, Zeemeeuw, Brugge, 1937.
(32) L'AKVS publie toujours une revue, AKVS-Schriften. Adresse: AKVS-Schriften, c/o Paul Meulemans, Kruisdagenlaan 75, B-1040 Brussel. Tél.: 02/734.25.52.
(33) La radicalité des positions de H. Van Puymbrouck transparaît dans le texte d'une brochure publiée à Berlin en 1941 et intitulée Flandern in der neuen Weltordnung (Verlag Grenze und Ausland, Berlin, 1941) et rééditée en 1985 par Hagal-Boeken, Speelhof 10, B-3840 Borgloon.
(34) Sur le Tat-Kreis, cfr.: Klaus Fritzsche, Politische Romantik und Gegenrevolution, Fluchtwege in der Krise der bürgerlichen Gesellschaft: Das Beispiel des «Tat-Kreises», edition Suhrkamp, es 778, Frankfurt a.M., 1976. Ouvrage très critique mais qui révèle les grandes lignes de l'idéologie du Tat-Kreis.
(35) A propos de Giselher Wirsing, on lira avec profit le texte que lui a consacré Armin Mohler au moment de sa mort en 1975 («Der Fall Giselher Wirsing») et repris dans son recueil intitulé Tendenzwende für Fortgeschrittene, Criticón Verlag, München, 1978.
(36) Jan Baars, né le 30 juin 1903, fit partie de la résistance néerlandaise pendant la guerre. Il est décédé le 24 avril 1989.
(37) Wim Zaal, op. cit., p.119.
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, années 20, années 30, révolution conservatrice, droite, conservatisme, nouvelle droite, idéologie, sciences politiques, politologie, philosophie, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 07 janvier 2010
Presseschau / Januar 2010/2
 PRESSESCHAU (Januar 2010/2)
PRESSESCHAU (Januar 2010/2)
Einige Links. Bei Interesse anklicken...
(Alles Gute für 2010)
###
Ahmadinedschad nennt Europas Politiker dumm
Neuer Verbalausfall von Mahmud Ahmadinedschad: Irans Präsident hat seine europäischen Politikerkollegen als „dumm“ beschimpft. Diese wüßten „weder was über Politik noch über Geschichte“.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,669094,00.html
http://www.pi-news.net/2009/12/ahmadinedschad-europas-politiker-sind-dumm/
Iranischer Oppositionsführer
Mussawi ist bereit, den Märtyrer-Tod zu sterben
Oppositionsführer Mir Hossein Mussawi hat nach den jüngsten Unruhen im Iran erklärt, daß er bereit sei, für die Rechte des iranischen Volkes zu sterben. Sein Tod würde die Oppositionsbewegung nicht bremsen, sagte Mussawi. Der Protest des Volkes habe mittlerweile eine Eigendynamik entwickelt.
http://www.welt.de/politik/ausland/article5689886/Mussawi-ist-bereit-den-Maertyrer-Tod-zu-sterben.html
Angriff verschoben?
Zwei kurz nacheinander erfolgte Entwicklungen in Israel haben die Schlußfolgerung nahegelegt, daß etwas Dramatisches unmittelbar bevorstehe. Die innere Logik der Lage im Mittleren Osten deutet auf den seit geraumer Zeit angedrohten israelischen Schlag gegen die iranischen Nuklearanlagen.
Von Ivan Denes
http://www.pi-news.net/2010/01/angriff-verschoben/#more-109118
Terrorgefahr
Flugzeugattentäter droht mit weiteren Anschlägen
Al-Qaida hat sich zu dem gescheiterten Anschlag auf ein US-Flugzeug bekannt, nun werden Details aus der Vernehmung des Attentäters bekannt: Der Nigerianer Abdulmutallab behauptet, daß derzeit weitere Terroristen trainiert würden.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,669354,00.html
Afghanistan
Selbstmordattentäter zündet Bombe auf CIA-Basis
Er sprengte sich im Fitneßraum in die Luft: In der afghanischen Provinz Khost tötete ein Selbstmordattentäter auf einer Geheimdienstbasis mindestens acht US-Bürger. Die meisten waren laut „Washington Post“ CIA-Agenten. Zu der Tat bekannten sich die Taliban.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,669658,00.html
Selbstmordanschlag auf CIA-Basis
Der Attentäter kam in Uniform
Der Mann trug afghanische Armeeuniform und erregte offenbar keinen Verdacht. Dann sprengte er sich mitten im Fitneßraum einer US-Basis im Süden des Landes in die Luft. Acht Amerikaner starben – sieben von ihnen waren bei der CIA. Afghanen beklagen unterdessen zivile Opfer.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,669680,00.html
Attentäter kam ungehindert auf CIA-Basis
Als Informant umworben
Daß ein Selbstmordattentäter am Mittwoch auf einer CIA-Basis in Afghanistan eine Bombe zünden konnte und dabei acht Menschen in den Tod riß, ist für die USA schon fatal genug. Allem Anschein nach war das außerdem erst durch eine unglaubliche Sicherheitspanne möglich.
http://news.orf.at/091231-46403/?href=http%3A%2F%2Fnews.orf.at%2F091231-46403%2F46404txt_story.html
Deutsche verlieren Vertrauen in Politiker und Manager
Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung stellt jeder vierte Befragte sogar die repräsentative Demokratie in Frage.
http://www.wz-newsline.de/?redid=715337
Arbeitsmarkt 2010
Deutschland rüstet sich für das Jobkrisenjahr
Von Stefan Schultz
2009 war schlimm, 2010 wird schlimmer. Nach Finanz-Crash und Konjunkturflaute droht Deutschland nun die große Jobmisere. Um die Turbulenzen am Arbeitsmarkt zu überstehen, braucht die Republik einen tiefgreifenden Strukturwandel.
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,669227,00.html
Eingetretene Pfade der „Politisierung“ ...
Shell-Jugendstudie 2010
Die Jugend wird wieder politischer
Klaus Hurrelmann, Leiter der neuen Shell-Studie, spricht im Interview über die Jugend in der Krise. Er erwartet eine Repolitisierung. Schließlich gibt es neuen Zündstoff.
http://www.zeit.de/gesellschaft/generationen/2009-12/interview-hurrelmann-shell-studie-2010
Evangelische Kirche
Kritik an Auszeichnung für „idea“
Eine Auszeichnung sorgt für Zoff innerhalb der Evangelischen Kirche in Thüringen. Die rechtsgerichtete Zeitschrift „Junge Freiheit“ hatte den Chef der evangelikalen Nachrichtenagentur „idea“ mit einem Preis geehrt.
http://www.ksta.de/html/artikel/1261581630607.shtml
http://www.open-report.de/artikel/Kritik+an+idea-Leiter+wegen+Annahme+des+Gerhard-L%F6wenthal-Preises/30262.html
Bischof kritisiert „Haßausbrüche“ des Zentralrats
Von Petr Jerabek
Das Verhältnis von Juden und Katholiken in Deutschland scheint an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Der Zentralrat der Juden bekundet sein „tiefes Mißtrauen“ gegenüber Papst Benedikt XVI. Der Regensburger Bischof Gerhard Ludwig Müller beklagt „Haßausbrüche“ des Zentralrats.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5655935/Bischof-kritisiert-Hassausbrueche-des-Zentralrats.html
Hannover
„Getarnte Volksverhetzung“
CDU-Chef Toepffer zeigt Neonazis an
http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/CDU-Chef-Toepffer-zeigt-Neonazis-an
Um dieses Video geht es wohl ...
besseres-hannover.info
http://www.youtube.com/watch?v=XeIzlwzR6ZY
Brennende Autos
„Wo gehobelt wird, fallen Späne“
Ein Autoabfackler erzählt über einen aufgezwungenen Krieg, ein für ihn menschenverachtendes System und das Ziel, andere durch brennende Autos wachzurütteln. [Kommentare beachten!]
http://www.taz.de/1/politik/deutschland/artikel/1/wo-gehobelt-wird-fallen-spaene/
Künstlergruppe „Frankreich muß bis Polen reichen“
http://www.myspace.com/frankreichmussbispolenreichen
http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/399611
http://www.youtube.com/watch?v=FPc0iUZY4As
http://www.youtube.com/watch?v=iLGuoU_NyCQ
Darauf hat Offenbach gewartet. Ein deutsch-israelischer Künstler will auf einer Verkehrsinsel in der Migrantenstadt einen gigantischen Monumentalobelisken gegen den NS-Holocaust errichten ...
Ein Zeichen der Erinnerung
http://www.op-online.de/nachrichten/offenbach/zeichen-erinnerung-570900.html
Runder Tisch gegen Rechts – Passau
[Man achte auf die illustre Zusammensetzung des Bündnisses]
http://www.buendnis-gegen-rechts.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=68
Passau
Runder Tisch gegen Rechts fordert Bierverbot für Nazis
Bündnis ruft Kunstwettbewerb an 31 hiesigen Schulen aus
http://www.pnp.de/mitmachen/forum/artikel.php?cid=29-26596570&Ressort=asta&BNR=0
Fürs Vaterland: Auf ein Bier mit der NPD ...
http://thomastrappe.wordpress.com/2009/12/30/die-netten-schreibers-in-strehla/
http://thomastrappe.wordpress.com/2009/12/15/furs-vaterland-auf-ein-bier-mit-der-npd/
Für einen Moment hofft man, er hätte irgend etwas verstanden ...
Einwanderung
Körting gibt Türkei Schuld an fehlender Integration
Nicht nur kulturell, auch politisch erschwere die türkische Regierung die Integration von Einwanderern in Deutschland. Diese Ansicht vertritt Berlins Innensenator Ehrhart Körting (SPD) und plädiert dafür, andere Kulturen und Religionen mehr zu respektieren. Er hat auch einen Vorschlag, wie man mit Radikalen umgehen sollte.
http://www.welt.de/politik/article5658111/Koerting-gibt-Tuerkei-Schuld-an-fehlender-Integration.html
Europas absehbarer Untergang
„Das Europa, das Sie durch Besuche kennen, oder durch ihre Eltern oder Freunde, steht kurz vor dem Zusammenbruch“, sagte Geert Wilders letztes Jahr in einer Rede in den Vereinigten Staaten. Der Chef der volksnahen niederländischen Freiheitspartei fügte hinzu: „Wir werden gegenwärtig Zeugen tiefgreifender Veränderungen, die Europas Zukunft für immer verändern und den Kontinent in – wie Ronald Reagan sagte – ‚tausend Jahre Finsternis‘ stürzen werden.“ Und nicht nur Europa, sondern ebenso Amerika.
http://www.pi-news.net/2009/12/europas-absehbarer-untergang/
Betreiber zündet arabisches Café in Hannover an und stirbt in den Flammen
Der Brand in einem arabischen Café in Hannover mit einem Toten ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei von dem Cafébetreiber selbst gelegt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verteilte der 29jährige wahrscheinlich Brandbeschleuniger in seinem Lokal und starb anschließend in den Flammen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.
http://www.pr-inside.com/de/betreiber-z-uuml-ndet-arabisches-caf-eacute-r1647206.htm
http://www.welt.de/die-welt/vermischtes/hamburg/article5674031/Wirt-kommt-bei-Brandstiftung-in-Lokal-ums-Leben.html
Wilde Schießerei in Berlin-Wedding
http://www.bild.de/BILD/news/2009/12/30/schiesserei-wedding-berlin/vier-kugeln-im-koerper-und-opfer-aydin-t-tippt-eine-sms-kurznachricht.html
Basel: Türken schlagen Deutschen zusammen
Offenbar völlig grundlos ist in der Nacht auf den Stephanstag in Basel ein 21jähriger Deutscher von mehreren Türken angegriffen und zusammengeschlagen worden. Der Mann befand sich auf dem Weg nach Hause, als ihm die fünf bis sechs jüngeren Türken entgegenkamen, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte. Sie beschimpften ihn, schlugen ihn zusammen und flüchteten anschließend.
http://www.pi-news.net/2009/12/basel-tuerken-schlagen-deutschen-zusammen/
Vater soll für Beleidigung eines Schlägers zahlen
Sendenhorst/Ahlen – Vier auf einen? Das geht für Walter Petker gar nicht. Als er nahe dem Johannes-Baldauf-Haus Zeuge einer Schlägerei wurde und vier Teenager dann anfingen, den auf dem Boden liegenden Jungen auch noch zu treten, sprang er aus dem Wagen und erwischte einen der Schläger am Kragen. Daß er ihn dabei unwirsch angesprochen hat, soll ihn jetzt 200 Euro kosten. Dann ist die Staatsanwaltschaft bereit zur Einstellung eines gegen den Sendenhorster eingeleiteten Verfahrens.
http://www.ahlener-zeitung.de/lokales/kreis_warendorf/ahlen/1241393_Vater_soll_fuer_Beleidigung_eines_Schlaegers_zahlen.html
http://www.ahlener-zeitung.de/lokales/kreis_warendorf/ahlen/1241854_Beleidigungsverfahren_gegen_Streitschlichter_wird_eingestellt.html
Zivilcourage führte zu Kopfplatzwunde
Ein 31jähriger Familienvater guckte nicht weg, als ein 16jähriger von südländischem Temperament in vierfacher Ausfertigung angegriffen wurde. Davon jedenfalls darf man wohl aufgrund der Art des Überfalls ausgehen. Lesen kann man es nicht, der Leser könnte ja sonst beim Finden der Täter helfen.
http://www.pi-news.net/2009/12/zivilcourage-fuehrte-zu-kopfplatzwunde/
Ethnokulturelle Hintergründe bleiben konsequent ausgeklammert ...
Jugendgewalt
Bessere Ausbildung für Pädagogen
http://www.focus.de/politik/weitere-meldungen/jugendgewalt-bessere-ausbildung-fuer-paedagogen_aid_466591.html
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/wissen_und_bildung/aktuell/2169222_Gastbeitrag-Bindung-zaehlt.html
http://www.pro-medienmagazin.de/paedagogik.html?&news%5Baction%5D=detail&news%5Bid%5D=2611
Krefeld: Polizei kooperiert mit Verfassungsfeinden
Ganz stolz präsentieren sich auf einem Foto Vertreter der Krefelder Polizei bei einem Besuch einer Moschee, die der Union der türkischen und islamischen Vereine in Krefeld angehört. Brisant: Der Vorsitzende des Dachverbandes ist Mehmet Demir, Vertrauter des Krefelder Oberbürgermeisters Kathstede und Sympathisant der Grauen Wölfe.
http://www.pi-news.net/2009/12/krefeld-polizei-kooperiert-mit-verfassungsfeinden/#more-108807
Flüchtlinge in Hessen
Votum der Härtefallkommission: 63 dürfen bleiben
http://www.bild.de/BILD/regional/frankfurt/dpa/2009/12/29/votum-der-haertefallkommission-63-duerfen.html
http://www.ad-hoc-news.de/haertefallkommission-haertefallkommission-dringt-auf--/de/Regional/Hessen/20828546
Härtefallkommission in Hessen
http://www.migrationsrecht.net/nachrichten-auslaenderrecht-politik-gesetzgebung/1200-haertefallkommission-in-hessen.html
Türkenangriff auf Wien
Sturm auf den „Goldenen Apfel“
Von Jan Puhl
61 Tage lang zitterte Wien im Jahr 1683 unter der Belagerung der Türken, die Bewohner aßen sogar Katzen, um nicht zu verhungern. Einem Heer aus Österreichern, Polen, Bayern und Sachsen gelang es schließlich, die Belagerer zu bezwingen. Das war der Anfang vom Ende des Osmanischen Reichs.
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,669197,00.html
Die Konsequenzen „freier Erziehung“
Von Michael Wiesberg
Wer kennt sie nicht: Kinder, die sich, weil Eltern der Meinung sind, ihre Kinder müßten sich „frei entfalten“ können, zu wahren Quälgeistern entwickelt haben. Der ein oder andere wird nach dem zurückliegenden Weihnachtsfest, dem Familienfest schlechthin, davon möglicherweise ein Lied singen können.
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M5b06b7c057a.0.html
Wieder mal: Einkaufscenter-Wahn führt zu Abriß historischer Bausubstanz ...
Velbert: Abriß geplant – Villa im Weg
http://www.derwesten.de/staedte/velbert/Villa-im-Weg-id2277992.html
http://www.derwesten.de/staedte/velbert/Erhebliche-Bedeutung-id2306362.html
00:15 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journaux, allemagne, europe, affaires européennes, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Noi, jüngeriani proprio perchè libertari
Noi, jüngeriani proprio perchè libertari
di Luciano Lanna
Ex: http://robertoalfattiappetiti.blogspot.com/
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande, allemagne, révolution conservatrice, ernst jünger, libertaires |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 02 janvier 2010
Presseschau (Januar 2010/1)
###
Zwölfnächte/Rauhnächte
 Zwölfnächte, Rauhnächte, Rauchnächte, die Nächte zwischen dem 25.12. und 6.1. Sie sind eine Zeit der Wiederkehr der Seelen, der Wilden Jagd und des Erscheinens von Geistern, die bewirtet oder durch Räuchern, Lärmen oder Kreuzeszeichen abgewehrt werden. Jeder dieser Tage soll als Lostag Vorbedeutung für Wetter und Schicksal im betreffenden Monat des folgenden Jahres haben.
Zwölfnächte, Rauhnächte, Rauchnächte, die Nächte zwischen dem 25.12. und 6.1. Sie sind eine Zeit der Wiederkehr der Seelen, der Wilden Jagd und des Erscheinens von Geistern, die bewirtet oder durch Räuchern, Lärmen oder Kreuzeszeichen abgewehrt werden. Jeder dieser Tage soll als Lostag Vorbedeutung für Wetter und Schicksal im betreffenden Monat des folgenden Jahres haben.(Der Neue Brockhaus in fünf Bänden, 4., neu bearbeitete Aufl., Wiesbaden 1968)
---
Zwölf Nächte (Zwölften), im Volksglauben und Brauchtum besonders hervorgehobener Zeitraum, in der Regel (mit landschaftlichen Abweichungen) zwischen Weihnachten und Dreikönigstag; galt als die Zeit von Spukgeistern (Wilde Jagd, Frau Holle, Percht), die mit mancherlei Arbeitsverbot belegt war, sowie als Lostage; zum Schutz vor den Geistern besprengte man in katholischen Gegenden Zimmer und Ställe mit Weihwasser (=>Rauhnächte). Aus dem Wetter der Zwölf Nächte leitete man Voraussagen für das Wetter der 12 Monate des kommenden Jahres ab; auch Träume galten als vorbedeutend.
(Der Brockhaus in fünf Bänden, Leipzig 2000)
###
Kopenhagen gescheitert
US-Präsident Obama stürzt vom Klima-Gipfel
Von D. Wetzel und G. Lachmann
Das faktische Scheitern der Klimaverhandlungen in Kopenhagen ist eine schwere Niederlage für US-Präsident Barack Obama auf internationaler Ebene. Nicht nur, daß er und Bundeskanzlerin Angela Merkel vorzeitig abreisten, ohne ein sicherers Ergebnis erzielt zu haben. Er ließ sich zudem von den Chinesen vorführen.
http://www.welt.de/politik/ausland/article5581658/US-Praesident-Obama-stuerzt-vom-Klima-Gipfel.html
Armenien, die Türkei und der Bergkarabach-Konflikt ...
Hundert Jahre Feindseligkeit
http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/493977
US-Armee: Iranische Streitkräfte besetzen Bohrturm im Irak
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iONNkKSNcihLy5hXhKxCTCKuZuWw
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,668023,00.html
Einfach nur dreist ... (eine Dreistigkeit, der von deutscher Seite kein Halt gesetzt wird)
Nachbarschaftsvertrag
Polen fordern mehr Rechte in Deutschland
Von Gerhard Gnauck
In erster Linie geht es der Regierung in Warschau bei der Verlängerung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages um die Förderung von Polnisch als Muttersprache. Ein Regierungsgutachten kommt darüber hinaus zu dem Schluß, daß der von den Nazis abgeschaffte Minderheitenstatus von Deutsch-Polen weiter Bestand habe.
http://www.welt.de/politik/ausland/article5593463/Polen-fordern-mehr-Rechte-in-Deutschland.html
Generalinspekteur mit Einsatzerfahrung
Von Fritz Friedebold;Thorsten Jungholt
Guttenberg ernennt Volker Wieker zum obersten deutschen Soldaten – Verteidigungsminister weiterhin beliebt
http://www.welt.de/die-welt/politik/article5579050/Generalinspekteur-mit-Einsatzerfahrung.html
ZDF-Bericht über Kämpfe deutscher Truppen in Afghanistan (02:31 min)
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/aktuellste/331022#/beitrag/video/927744/Deutsche-Soldaten-unter-Beschuss/
Afghanistanpolitik: Kritik der Bundeswehr wächst
Sie haben sie in den Krieg geschickt und wollen sie jetzt, getrieben von verblendeter Ideologie und poltischem Machtkalkül, am Pranger sehen. Zu Recht werden die Stimmen gegen die Vereinigte Linke aus den Reihen der Bundeswehr immer lauter: „Überspitzt gesagt fragten sich viele Soldaten: Kommt die Öffentlichkeit eher damit klar, wenn wir getötet werden als unsere Gegner?“ teilte jetzt General Volker Bescht mit.
http://www.pi-news.net/2009/12/afghanistanpolitik-kritik-der-bundeswehr-waechst/#more-107806
Ex-Verteidigungsminister
Rupert Scholz verteidigt Luftangriff von Kundus
Der Staatsrechtler und frühere Verteidigungsminister Rupert Scholz ordnet den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan den Rechtskategorien des Kriegsvölkerrechts zu. Sie erlauben das „gezielte Töten“, sagt Scholz, und damit auch den von Oberst Georg Klein ausgelösten Luftangriff, der Talibanführer „vernichten“ sollte.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5574082/Rupert-Scholz-verteidigt-Luftangriff-von-Kundus.html
Wo bleibt mein Geld, Mr. Brown?
Von Ronald Gläser
Die Kampagne gegen Karl-Theodor zu Guttenberg hört nicht auf. Dabei war der Mann noch nicht einmal Verteidigungsminister, als amerikanische Piloten ihren Angriff bei Kundus ausgeführt haben.
Was also wirft die linke Presse dem Franken überhaupt vor? Es habe eine „gewaltige Vertuschungs-, Verheimlichungs- und Beschönigungsaktion“ gegeben, schreibt der SPIEGEL in seiner neuesten Ausgabe. Die „deutsche Demokratie“ habe „ein Desaster“ erlebt. Drunter macht’s der SPIEGEL nicht. An Fakten hat er aber nur die spannende Frage, wer wann welches Dossier zu lesen bekommen hat. Gähn. Wenn das ein Skandal sein soll, dann lachen doch die Hühner. Diese rot-grüne Diffamierungskampagne stinkt bis nach Kabul.
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M59b60f06747.0.html
Bundeswehr
Guttenberg entwirft neue Afghanistan-Strategie
Von T. Jungholt und T. Krauel
Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) weist alle Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Luftangriff bei Kundus von sich. Derzeit läßt er eine neue Afghanistan-Strategie erarbeiten. Sie könnte eine Aufstockung der Truppen zur Folge haben. Unter Umständen will er auch mit den Taliban sprechen.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5584812/Guttenberg-entwirft-neue-Afghanistan-Strategie.html
Zuerst! Deutsches Nachrichtenmagazin
Von Götz Kubitschek
Am vergangenen Freitag sah ich am Naumburger Bahnhof die erste Ausgabe des neuen Nachrichtenmagazins Zuerst! ausliegen. Zuhause fand ich sie im Briefkasten: 84 Seiten, Focus-Style, ein paar lesenswerte Artikel und die übliche Werbung. Ich las und blätterte mit Vorkenntnissen zu Planung und Positionierung des Magazins und prüfte, inwiefern der Anspruch, das rechte Milieu zu überspringen, eingelöst wird.
http://www.sezession.de/10135/zuerst-deutsches-nachrichtenmagazin.html#more-10135
Zuerst! – zum zweiten
Von Götz Kubitschek
Ich habe die Diskussion auf meinen Beitrag zum Nachrichtenmagazin Zuerst! nun einmal laufen lassen, ohne groß moderierend oder kommentierend einzugreifen. Ich will diesen Eingriff jetzt vornehmen, indem ich einzelne Kommentare herausgreife und einiges dazu sage.
http://www.sezession.de/10226/zuerst-zum-zweiten.html
Klimaskeptiker
Die letzten Fortschrittsgläubigen
Von Lorenz Jäger
http://www.faz.net/s/RubC5406E1142284FB6BB79CE581A20766E/Doc~EE604428F360A4BE18ADB54220443B8B6~ATpl~Ecommon~Scontent.html
Wir haben’s ja ...
Entwicklungshilfe: China bekommt Millionen für den Klimaschutz
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/entwicklungshilfe-china-bekommt-millionen-fuer-den-klimaschutz;2501310
Schäuble spart später
Kommentar: Merkels Terminator
Ein unrühmlicher Platz in den Geschichtsbüchern ist ihm so sicher wie weiland Theo Waigel: Im nächsten Jahr wird Wolfgang Schäuble sich als neuer Schuldenkönig inthronisieren, erst von 2011 an will er eisern sparen. Von Ulrich Kaiser
http://www.op-online.de/nachrichten/politik/merkels-terminator-566993.html
Arbeitsrecht
SPD will Kündigung wegen Kleindiebstählen verbieten
Die SPD will den Arbeitnehmerschutz ausweiten. Im Januar will die Fraktion einen Gesetzentwurf in den Bundestag einbringen, demzufolge sofortige Kündigungen wegen Bagatellvergehen künftig verboten werden sollen.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,668299,00.html
Racheakt in Mexiko
Drogenmafia richtet Familie eines Soldaten hin
Die mexikanische Drogenmafia hat auf grausame Art und Weise Rache genommen: Auftragskiller ermordeten die Familie eines der Elitesoldaten, der an der Jagd auf den Drogenboß Arturo Beltrán Leyva beteiligt gewesen und dabei getötet worden war.
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,668889,00.html#ref=nldt
BKA warnt
Drei rechte Gewalttaten am Tag
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/aktuell/2150712_BKA-warnt-Drei-rechte-Gewalttaten-am-Tag.html
Zahl rechtsextremer Straftaten auf neuem Höchststand
http://nachrichten.rp-online.de/article/politik/Zahl-rechtsextremer-Straftaten-auf-neuem-Hoechststand/62033
http://www.welt.de/die-welt/politik/article5568034/Rund-20-000-rechtsextreme-Straftaten.html
Und deshalb sind ja auch dauerhafte finanzielle Zuwendungen für „Gegen Rechts“-Projekte nötig ...
Daueraufgabe
Studie: Rechte Gewalt lässt sich nicht beseitigen
http://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article1216683/Studie-Rechte-Gewalt-laesst-sich-nicht-beseitigen.html
Kriminalität
Linksextreme Gewalt stark angestiegen
http://www.focus.de/politik/weitere-meldungen/kriminalitaet-zeitungsbericht-linksextreme-gewalt-stark-angestiegen_aid_463669.html
http://www.stern.de/politik/deutschland/linksextreme-straftaten-das-linke-milieu-schlaegt-zu-1527896.html
Liebe Zündler!
Von Martin Böcker
Danke für Eure Aktivität. Danke, daß Ihr Euch zeigt: Wer Ihr seid, was Ihr macht, wie Ihr Probleme lösen wollt. Ein Stück Grillanzünder auf einem Autoreifen reicht, um fünf bis hunderttausend Euro „abzufackeln“. Benzin, eine Pfandflasche und ein wenig Lust auf Krawall reichen auch für anderthalb Tage „Oh“ und „Ah“ in der Medienlandschaft. Wenig Aufwand, viel Leistung.
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M5e21903dace.0.html
Generalsekretär der NRW-CDU, Hendrik Wüst:
„SPD mitverantwortlich für linksextreme Gewalt“
http://nachrichten.rp-online.de/article/politik/SPD-mitverantwortlich-fuer-linksextreme-Gewalt/61920
ERFURT: Debatte über Links- und Rechtsextremismus
http://www.thueringer-allgemeine.de/ta/ta.thueringenticker.volltext.php?kennung=ontaTICRatgeberMantel1261067711&zulieferer=ta&kategorie=TIC&rubrik=Ratgeber®ion=Mantel&auftritt=TA&dbserver=1
„Arbeit macht frei“-Klau in Auschwitz
„Das ist eine Kriegserklärung“
http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,668002,00.html
60 Millionen Euro
Berlin gibt Geld für Auschwitz
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/aktuell/2150631_60-Millionen-Euro-Berlin-gibt-Geld-fuer-Auschwitz.html
Aktion Sühnezeichen: Der Schuldprotestantismus rekrutiert seinen Nachwuchs ...
Cathérine Schilling verbringt ein Jahr in Polen als kleinen Beitrag zur Verständigung
„Polen ist wirklich ein tolles Land“
http://www.op-online.de/nachrichten/rodgau/polen-wirklich-tolles-land-567601.html
TU Wien ehrte Holocaust-Leugner
Ein goldenes Diplom für einen amtsbekannten Revisionisten stellte die TU Wien aus. Der Geehrte zweifelte am Massenmord in Auschwitz.
http://www.kurier.at/nachrichten/1964006.php
Sinti und Roma: Bundesrat prangert Diskriminierung an
http://www.jesus.de/blickpunkt/detailansicht/ansicht/161081bundesrat-prangert-diskriminierung-an.html
Musikwissenschaftler Eggebrecht an nationalsozialistischen Verbrechen beteiligt?
http://www.klassik.com/aktuell/news/teaser.cfm?ID=7620&nachricht=Musikwissenschaftler%20Eggebrecht%20an%20nationalsozialistischen%20Verbrechen%20beteiligt%3F
Angewandte will Lueger-Statue umgestalten
Die Universität für angewandte Kunst hat einen internationalen Wettbewerb zur Umgestaltung des Lueger-Denkmals in der City in ein Mahnmal gegen Antisemitismus ausgelobt. FPÖ und ÖVP lehnen die Idee ab, die Grünen sind dafür.
http://wien.orf.at/stories/408595/
1973: DER SPIEGEL über die „Invasion der Türken“
Um die Islamisierung Deutschlands besser zu verstehen, lohnt sich zuweilen ein Blick zurück, zum Beispiel ins Jahr 1973. Die Ölkrise, die Watergate-Affäre, der Jom-Kippur-Krieg bestimmen das Weltgeschehen. In Deutschland aber wird – frei von jeder political corrrectness und Neusprech-Terminologie – über die „Invasion der Türken“ diskutiert. Sogar im SPIEGEL, wie nachfolgender Auszug der Ausgabe 31/1973 beweist.
http://www.pi-news.net/2009/12/1973-der-spiegel-ueber-die-invasion-der-tuerken/
Türkische Gemeinde: „Integrations-Agenda“ 2010
Die Türkische Gemeinde in Deutschland fordert ein Integrationsgesetz. Die Debatte um das Zusammenleben mit Migranten sei zunehmend kontrovers, sagte der Bundesvorsitzende Kenan Kolat. In einer Integrations-Agenda 2010 könnte man die unterschiedlichen Ansätze bündeln.
http://www.stern.de/politik/tuerkische-gemeinde-integrations-agenda-2010-1531586.html
http://www.pi-news.net/2009/12/kolat-fordert-integrationsgesetz/#comments
Vorbild Balkanländer
Türkei fordert Aufhebung von Visumspflicht für EU
Serben, Mazedonier und Montenegriner können seit diesem Wochenende ohne Visum in die Europäische Union einreisen. Nun hat auch die Türkei von der EU die Aufhebung der Visumspflicht für ihre Bürger gefordert. Begründung: Die Türkei sei in EU-Fragen schon viel weiter als die Balkan-Länder.
http://www.welt.de/politik/ausland/article5587949/Tuerkei-fordert-Aufhebung-von-Visumspflicht-fuer-EU.html
Prognose für 2010
Asylbewerberzahl steigt zum dritten Mal in Folge
Deutschland muß sich nach Einschätzung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im Jahr 2010 zum dritten Mal in Folge auf einen Anstieg der Asylbewerberzahlen einstellen. Die meisten Flüchtlinge werden auch im kommenden Jahr aus muslimischen Ländern erwartet.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5620972/Asylbewerberzahl-steigt-zum-dritten-Mal-in-Folge.html
Ausländer
2010 mehr Asylbewerber erwartet
Nürnberg/Berlin (dpa) – Deutschland muß sich nach Einschätzung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im Jahr 2010 auf einen leichten (?) Anstieg der Asylbewerberzahlen einstellen.
http://www.zeit.de/newsticker/2009/12/23/iptc-bdt-20091223-169-23381956xml
Mehr als 2000 Irak-Flüchtlinge in Deutschland
http://www.greenpeace-magazin.de/index.php?id=55&tx_ttnews%5Btt_news%5D=69506&tx_ttnews%5BbackPid%5D=23&cHash=15d00da830
Abiturientin (18) in Dresden ermordet
Schock in Dresden: Wenige Tage vor Weihnachten ist die Abiturientin Susanna (18) tot aufgefunden worden. Jetzt sucht die Polizei mit Hochdruck nach einem Pakistani (32). Er soll der Freund der jungen Frau gewesen sein.
http://www.bild.de/BILD/news/2009/12/17/dresden-abiturientin/tot-aufgefunden-worden.html
http://www.bild.de/BILD/regional/dresden/aktuell/2009/12/18/mord-an-gymnasiastin/ihr-freund-soll-sie-erwuergt-haben.html
http://nachrichten.lvz-online.de/nachrichten/mitteldeutschland/tod-von-dresdner-schuelerin-polizei-sucht-32-jahre-alten-pakistaner/r-mitteldeutschland-a-6356.html
http://www.pi-news.net/2009/12/dresden-18-jaehrige-tot-in-asylheim-aufgefunden/
Gießen
Wechsel an der Uni-Spitze
Indischstämmiger Anglistik-Professor Joybrato Mukherjee neuer Uni-Präsident
http://www.fr-online.de/frankfurt_und_hessen/nachrichten/hessen/2147587_Giessen-Wechsel-an-der-Uni-Spitze.html
Ethnomorphose-Propaganda
http://edoc.hu-berlin.de/histfor/5/PHP/mietzner-pil-abb-1.jpg
76jährige Geschäftsfrau beleidigt und bespuckt
Mit 76 Jahren (!) betreibt die tüchtige Geschäftsfrau noch ihren Fischhandel. Doch in letzter Zeit gibt es Probleme mit schwarzafrikanischen Dealern. Sie wird gedemütigt, beleidigt und bespuckt. Ein Polizeibeamter kann dazu nur noch achselzuckend feststellen: „Wenn wir einen Schwarzafrikaner festnehmen, läßt ihn die Justizbehörde schon nach kurzer Zeit wieder laufen. Dann steht er wieder da, verkauft weiter seinen Stoff und zeigt uns den Stinkefinger. Wir sind da genauso hilflos wie sie.“
http://www.pi-news.net/2009/12/76-jaehrige-geschaeftsfrau-beleidigt-und-bespuckt/
Überfall: Polizei erschießt 19jährigen Türken
Im baden-württembergischen Leimen wurde in der Nacht zum Heiligen Abend ein 19jähriger Täter türkischer Nationalität nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Esso-Tankstelle von Polizeikugeln tödlich getroffen. Zwei Mittäter konnten festgenommen werden.
http://www.pi-news.net/2009/12/ueberfall-polizei-erschiesst-19-jaehrigen-tuerken/
Langsame Veränderungen im kulturellen Gefüge ...
Wenn Muslime Geburtshelfer niederschlagen
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/Wenn-Muslime-Geburtshelfer-niederschlagen/story/24584619
Skateboard-Todesfahrer als Straftäter verurteilt
Der Türke, der nach dem tödlichen Skateboard-Unfall in Frankfurt als Halter des Unfallwagens verhaftet worden war, war wohl doch nicht der Fahrer. Verdächtigt wird jetzt sein Sohn, ein verurteilter Straftäter, den ein verständnisvoller Richter zur besseren Wiedereingliederung in die Gesellschaft auf freien Fuß gesetzt hatte. Er ist untergetaucht.
http://www.pi-news.net/2009/12/skateboard-todesfahrer-als-straftaeter-verurteilt/
Migranten verprügeln am liebsten den Schweizer
Viele Ja-Stimmen zum Schweizer Minarettverbot stammten von jungen Bürgern, die sich sonst für Politik wenig interessieren. Sie beteiligten sich an der Volksabstimmung, weil der Islam sie persönlich betrifft: Sie sind die Lieblingsopfer der jugendlichen Migranten mit islamisch-kulturellem Hintergrund. Gemäß Angaben der Polizei sinkt die Hemmschwelle für Gewaltakte, die Brutalität nimmt zu. Die Angriffe erfolgen oft grundlos und ohne Vorwarnung. Sogar wenn die Opfer am Boden liegen, werden sie noch getreten, mit Vorliebe gegen den Kopf.
http://www.pi-news.net/2009/12/migranten-verpruegeln-am-liebsten-den-schweizer/
Vergewaltiger erhält Haftentschädigung
Vom Tatbestand der Vergewaltigung nicht nur freigesprochen wurde in der Schweiz ein Afrikaner, sondern er erhielt auch noch eine ordentliche Haftentschädigung. Grund: Das Opfer war betrunken und hätte sich seine Verletzungen auch anderweitig zuziehen können. Außerdem hatte der Verdächtige von einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gesprochen, was angesichts der Tatumstände sehr wahrscheinlich erscheint.
http://www.pi-news.net/2009/12/vergewaltiger-erhaelt-haftentschaedigung/#more-105824
Weihnachtliche Massenschlägerei auf Schulparty
Was letzte Nacht eine Weihnachtsparty an einem Luzerner Gymnasium hätte werden sollen, endete in einer brutalen Massenschlägerei zwischen zwei „rivalisierenden Gruppen von Jugendlichen“. Lucas Berger, der DJ aus dem Aargau, der Mittwoch nacht auf der „X-Mas-Party 2009“ die Scheiben auflegte, ist geschockt. Was mit einer „echt coolen“ Schülerfete begann, wurde auf einmal bereichert: „Die Leute kletterten zu den Fenstern rein, drängten durch die Türe – es wurde immer aggressiver.“
http://www.pi-news.net/2009/12/weihnachtliche-massenschlaegerei-auf-schulparty/#more-107764
Trebur (Hessen)
Schwarzarbeiter in Kebab-Haus erwischt
http://www.bild.de/BILD/regional/frankfurt/dpa/2009/12/16/schwarzarbeiter-in-kebabhaus-erwischt.html
Vom Wäschetrocknen, der Wilden Jagd und Goethes Einsicht
Von Karlheinz Weißmann
Wenn früher jemand im ländlichen Niedersachsen gefragt wurde, was er zwischen Weihnachten und Dreikönig keinesfalls tun dürfe, so lautete die Antwort: „Wäsche zum Trocknen aufhängen“. Faßte man nach und wollte den Grund wissen, hieß es: „Weil sonst jemand im Hause stirbt.“
Meine Urgroßmutter und meine Großmutter haben sich streng daran gehalten, meine Mutter auch, oder doch beinahe: sie brachte die Wäsche auf den Trockenboden unseres Wohnblocks, – aber es blieb ein Unbehagen. Die jungen Frauen heute kennen nicht einmal mehr das.
http://www.sezession.de/9929/vorweihnachtlich-i-vom-waeschetrocknen-der-wilden-jagd-und-goethes-einsicht.html
Die deutsche Weihnacht
Von Karlheinz Weißmann
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M52c20cd7236.0.html
Friede auf Erden
Von Heinrich Rieker
Sie legten die Waffen nieder, spielten Fußball und rauchten Zigaretten. Zu Weihnachten 1914 verbrüderten sich Deutsche, Briten und Franzosen an der Westfront. Was sie damals erlebten, notierten die Soldaten in Tagebüchern und Feldpostbriefen
http://www.welt.de/print-welt/article359965/Friede_auf_Erden.html
Abstimmung
Wird Guttenberg der „Sprachwahrer des Jahres“?
Er liest Platon im Original, kann eine mitreißende Bierzeltrede halten und spricht das Wort „Krieg“, wenn es um Afghanistan geht, unumwunden aus: Verteidigungsminister zu Guttenberg. Der CSU-Politiker ist jetzt für die Auszeichnung „Sprachwahrer des Jahres“ vorgeschlagen worden.
http://www.welt.de/kultur/article5610205/Wird-Guttenberg-der-Sprachwahrer-des-Jahres.html
http://www.deutsche-sprachwelt.de/berichte/pm-2009-12-22.shtml
Kunstschatz
Kulturstaatsminister will Nofretete behalten
Nofretete bleibt in Berlin, daran lässt Kulturstaatsminister Bernd Neumann keinen Zweifel. Auch wenn Ägypten die Rückgabe der Büste fordert. Der CDU-Politiker will die Königin, die im Neuen Museum zu Hause ist, nicht einmal leihweise herausgeben.
[Wäre ja auch noch schöner. Die Orientalen haben sich doch ursprünglich einen Dreck um ihr Erbe geschert. Und wären die Europäer nicht gewesen, wäre das wohl auch heute noch so ...]
http://www.morgenpost.de/kultur/berlin-kultur/article1227760/Kulturstaatsminister-will-Nofretete-behalten.html
Evolution: Koala-Urahnen verschmähten Eukalyptus
Koalas und Eukalyptusbäume sind praktisch unzertrennlich. Doch das war nicht immer so, wie Forscher jetzt herausgefunden haben: Schädel von Koala-Urahnen beweisen, daß die Beutelbären früher abwechslungsreicher fraßen – bis die Kontinentaldrift dazwischenkam.
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,668249,00.html
Denkmalschutz und Stuttgart 21
Was ist die Stuttgarter Denkart?
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/1789197_0_2147_denkmalschutz-und-stuttgart-21-was-ist-die-stuttgarter-denkart-.html
Jagdbomber zu Backformen
Von Ellen Kositza
Die Klage über die Profanierung der weihnachtlichen Sitten ist seit Jahren – oder länger? – ins Brauchtum eingemeindet. Als wir vor sieben Jahren nach Mitteldeutschland gezogen sind, war manches für uns ein Schock. Bis dahin hatte ich den Offenbacher Weihnachtsmarkt für einigermaßen häßlich gehalten, hier wurde der Rummel an manchen Orten noch übertroffen.
http://www.sezession.de/10238/jagdbomber-zu-backformen.html
Wintergetränke
Der Glühwein ist nicht schuld an seinem Elend
Billiger Glühwein sorgt schon viel zu lange für Kopfschmerzen. Dabei haben heiße Mischgetränke eine längere Tradition als Cocktails – sie sind im Grunde ihres Wesens einfach und gut. Und: Jeder kann sie zu Hause selber machen. Lorraine Haist hat nach Alternativen zum Heißgetränke-Proletariat geforscht.
http://www.welt.de/lifestyle/article5575054/Der-Gluehwein-ist-nicht-schuld-an-seinem-Elend.html
--
Preisknaller: GMX DSL Flatrate für nur 16,99 Euro/mtl.!
http://portal.gmx.net/de/go/dsl02
00:15 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, politique internationale, allemagne, médias, politique, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le destin de Beppo Römer: des Corps Francs au Parti Communiste Allemand
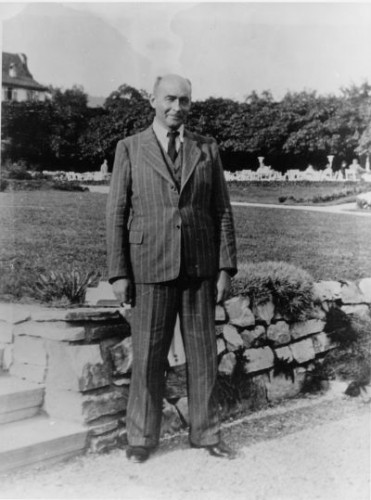 Holger SZYMANSKI :
Holger SZYMANSKI :
Le destin de Beppo Römer : des Corps Francs au Parti Communiste Allemand
Josef Römer, « Beppo » pour ses amis, était un ancien chef des Corps Francs allemands après 1918. Indubitablement, cette personnalité illustre est typique de ces destins troublés qui ont traversé le 20ème siècle.
Ceux qui s’intéressent à l’histoire allemande de la première moitié du 20ème siècle connaissent Römer : il fut l’un des initiateurs de l’assaut contre l’Annaberg en Silésie, une hauteur stratégique qui avait été occupée par des francs-tireurs polonais en mai 1921 ; ensuite, il fut un résistant à l’hitlérisme, exécuté en 1944. Entre l’héroïsme de l’Annaberg et la mort tragique de 1944, s’étend une période moins bien connue, celle où notre Capitaine mis à la retraite s’est d’abord engagé dans les rangs nationalistes puis, par le détour du national-bolchevisme, a fini par devenir un compagnon de route du communisme allemand. Pourtant ceux qui s’intéressent aux phénomènes de la « révolution conservatrice » et du national-bolchevisme ignorent une chose : Römer était déjà dans les années 20 un agent du service de renseignement de la KPD communiste allemande. Il y a déjà une quinzaine d’années, la maison d’édition Dietz de Berlin, inféodée à la SED, le parti unique de l’ex-Allemagne de l’Est, avait fait paraître un livre intitulé « Der Nachrichtendienst der KPD 1919-1937 » (= «Le service de renseignement du parti Communiste Allemande – 1919-1937 ») ; cet ouvrage est passé presque totalement inaperçu dans les milieux généralement intéressés à la « révolution conservatrice » et aux nationalismes allemands, sans doute à cause de sa provenance est-allemande et communiste.
Les auteurs de ce livre ont sans nul doute suscité des hauts le cœur chez les conservateurs et les nationaux : tous étaient jadis enseignants auprès de la « Hauptverwaltung Aufklärung » (« Administration Principale du Renseignement ») du Ministère de la Sécurité de l’Etat (la « Stasi »). Parmi eux, il y avait également le chef d’un département spécialisé « dans les recherches sur les problèmes spécifiques de lutte et de résistance antifascistes » ; lui aussi relevait du ministère du fameux Général Mielke. Pourtant, ces auteurs, contrairement à beaucoup d’autres historiens, avaient accès aux archives est-allemandes et toutes les références qu’ils citent dans leur livre sont vérifiables dans la mesure où leurs sources sont dûment citées. Pour l’essentiel, nos ex-officiers est-allemands se basent sur les archives de la SED et sur celles du « Département IX/11 » de la Stasi. Aujourd’hui, tous ces documents ont été transférés aux Archives Fédérales (« Bundesarchiv »). A l’époque de la RDA, les résultats des recherches de nos auteurs étaient considérés comme « top secrets » et tenus sous le boisseau. La Stasi se voulait l’héritière du « service de renseignement » de la KPD.
D’après les travaux de nos historiens membres de la Stasi, les contacts de Beppo Römer avec les communistes remontaient à 1921 déjà et auraient été rendus possibles par l’entremise d’un député communiste du Landtag de Bavière, Otto Graf. Le service de renseignement du parti finit par prendre contact avec Römer à l’automne 1923. Römer revêtait une grande importance pour les communistes, car il était l’un des dirigeants de la Ligue Oberland (= « Bund Oberland »), issue du Corps Francs du même nom, qui avait joué un rôle important dans les combats de l’immédiat après-guerre. A ce titre, cette Ligue exerçait une grande influence dans le camp nationaliste. Nos auteurs est-allemands en arrivent dès lors à la conclusion suivante, après avoir dépouillé un grand nombre de documents archivés : « Römer fut l’un des informateurs les plus prolixes de la KPD sur le camp des radicaux de droite en Bavière ». La direction de la KPD était donc très bien informée sur la préparation, l’exécution et l’échec du putsch perpétré par Hitler les 8 et 9 novembre 1923.
Cependant, le travail des informateurs ne servait pas seulement à informer la direction de la KPD mais aussi et surtout à travailler à la dislocation des troupes d’auto-défense et de toutes les autres organisations de droite. Le domaine dans lequel ce travail de dislocation devait s’effectuer s’appelait tout simplement celui des « Fascistes » dans le langage des communistes. Travaillant sous la houlette de son chef, Otto Thomas, Beppo Römer, qui avait achevé des études, obtenu un diplôme et trouvé un emploi civil dans le domaine de l’économie, fonde, avec Ludwig Oestreicher, issu comme lui de la Ligue Oberland, et quelques autres amis, la revue « Die neue Front » (= « Le Front nouveau ») dont l’objectif était de promouvoir des volontés activistes d’orientation nationale-bolchevique parmi les anciens des Corps Francs ; remarquons que, dans le chef de Römer, c’est avec le concours de l’appareil de subversion de la KPD que de telles vocations doivent éclore. La revue ne suscite finalement pas grand intérêt et cesse bien vite de paraître.
Römer, libéré de ses tâches de publiciste, s’adonne alors plus intensément à l’espionnage économique et militaire auquel se livrent les communistes allemands pour le bénéfice de leurs camarades soviétiques. Dans ce contexte, Römer est arrêté le 30 septembre 1926 à Berlin. Grâce à une amnistie générale, il ne sera pas jugé. Römer se serait surtout intéressé à la production de gaz toxiques et à fournir des échantillons de produits finis.
Beppo Römer ne réapparaît sur la scène de la politique allemande qu’en 1931, lorsqu’apparaissent les groupes de travail « Aufbruch ». Ces cercles politiques voient le jour au moment où l’ancien lieutenant de la Reichswehr, Richard Scheringer, passe de la NSDAP hitlérienne à la KPD communiste. Scheringer, avec ses camarades Hanns Ludin (plus tard ambassadeur du Reich en Slovaquie pendant la seconde guerre mondiale et, à ce titre, exécuté en 1947) et Hans Friedrich Wendt, avait fait de la propagande pour la NSDAP au sein des forces armées. Les trois hommes avaient voulu mettre sur pied des « cellules NSDAP » dans l’armée. Lors du procès de la Reichswehr, qui s’est tenu à Ulm à l’automne 1931, Hitler a été appelé à la barre comme témoin et c’est là qu’il a prononcé son fameux « serment de légalité », par lequel il proclama que la NSDAP ne cherchait à atteindre le pouvoir que par des moyens légaux.
Scheringer purgea sa peine à Gollnow où, sous l’influence d’un détenu communiste, Rudolf Schwarz, il finit par adhérer à l’idéologie des Rouges. Rudolf Schwarz n’était pas le premier communiste venu mais avait été le responsable du département « Reichswehr » de l’appareil politico-militaire du parti. Le dirigeant actif, à l’époque, de cet appareil « M », Hans Kippenberger, fit sensation le 19 mars 1931 lorsqu’il annonça pendant un débat au Reichstag l’adhésion de Scheringer à la KPD. La démarche de Scheringer a permis à la KPD de pénétrer des strates sociales qui avaient été jusqu’alors sceptiques à son égard.
Pour consolider ces nouveaux contacts, Kippenberger décida de fonder une nouvelle revue, « Aufbruch - Kampfblatt im Sinne des Leutnants a. D. Scheringer » (= « Aufbruch – Feuille de combat selon les idées du Lieutenant e.r. Scheringer »). Dans un premier temps, les éditeurs de la publication furent l’ancien Premier Lieutenant de police Gerhard Giesecke et l’ancien représentant du Gauleiter NSDAP du Brandebourg, Rudolf Rehm. A partir de 1932, le Capitaine e.r. Dr. Beppo Römer prend en mains la rédaction de la revue. On ne peut affirmer avec certitude si Römer avait adhéré de facto à la KPD à cette époque. Il l’a nié plus tard en dépit d’une note émise par le journal communiste « Die Rote Fahne » en date du 22 avril 1932. Autour de la revue naissent les cercles « Aufbruch » : en 1933, il y en avait vingt-cinq, avec quelque 200 à 300 membres. Leur objectif était de recruter dans les cercles d’officiers des combattants contre le national-socialisme. A la tête de ces cercles se trouvait une « Commission dirigeante », composée de « camarades travaillant sur le mode de la conspiration ». Outre Römer, il y avait, parmi ces « camarades », un certain Dr. Karl-Günther Heimsoth, devenu célèbre par des lettres de sa main, très compromettantes pour son ami intime Ernst Röhm et relatives à l’homosexualité de ce dernier. Pour la KPD, l’existence des cercles « Aufbruch » constituait une formidable aubaine : celle de glaner quantité d’informations et de recruter de nouveaux agents. Après la prise du pouvoir par les nationaux-socialistes en 1933, « Aufbruch » et les cercles qui gravitaient autour de la revue sont interdits. Bon nombre de leurs activistes, y compris Beppo Römer, sont placés en garde à vue ou fuient vers l’étranger. Plus tard, Beppo Römer se joindra à divers mouvements de résistance ; le dernier auquel il adhéra fut d’obédience communiste et sous la direction de Robert Uhrig. Cette adhésion constitua le motif de son arrestation au début de l’année 1942, de sa condamnation à mort et de son exécution, le 25 septembre 1944 à Brandenburg-Görden.
Au vu de toutes ces activités au profit du service de renseignement de la KPD, Römer apparaît plutôt aujourd’hui comme un véritable agent communiste et non pas comme un visionnaire rêvant de forger un Axe Berlin-Moscou, comme on l’a cru pendant très longtemps.
Holger SZYMANSKI.
(article paru dans la revue « Deutsche Stimme », février 2008 et sur http://www.deutsche-stimme.de/ - trad.. franc. : Robert Steuckers).
Bibliographie :
Bernd KAUFMANN et al., « Der Nachrichtendienst der KPD – 1919-1937 », Dietz Verlag, Berlin, 1993, 462 pages.
Pour tous les éléments biographiques relatifs à la personnalité de Beppo Römer, se référer au « Taschenkalender des nationalen Widerstandes 2007 », où ses activités d’agent communiste ne sont toutefois pas évoquées.
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, nationalisme révolutionnaire, allemagne, communisme, parti communiste allemand, weimar, années 20, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 26 décembre 2009
Eugen Diederichs et le Cercle "Sera"
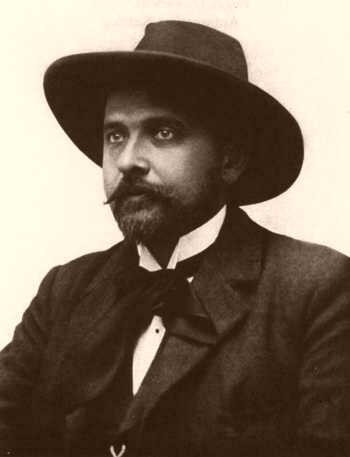 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1999
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1999
Eugen Diederichs et le Cercle «Sera»
Robert STEUCKERS
Analyse: Meike G. WERNER, «Bürger im Mittelpunkt der Welt», in Der Kulturverleger Eugen Diederichs und seine Anfänge in Jena 1904-1914. Katalogbuch zur Ausstellung im Romantikerhaus Jena 15. September bis 8. Dezember 1996, Diederichs, München, 1996, 104 p. (nombreuses ill., chronologie), ISBN 3-424-01342-0.
- Meike G. WERNER, «Die Erneuerung des Lebens durch ästhetische Praxis. Lebensreform, Jugend und Festkultur im Eugen Diederichs Verlag» &
- Friedrich Wilhelm GRAF, «Das Laboratorium der religiösen Moderne. Zur “Verlagsreligion” des Eugen Diederichs Verlags»
tous deux in: Gangolf HÜBINGER, Versammlungsort moderner Geister. Der Eugen Diederichs Verlag - Aufbruch ins Jahrhundert der Extreme, Diederichs, München, 1996, 533 p., ISBN 3-424-01260-2.
- Rainer FLASCHE, «Vom Deutschen Kaiserreich zum Dritten Reich. Nationalreligiöse Bewegungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland», in: Zeitschrift für Religionswissenschaft, 2/93, pp. 28-49, Diagonal-Verlag, Marburg, ISSN 0943-8610.
Editeur allemand, qui a fondé sa maison en 1896, Eugen Diederichs se voulait un “réformateur de la vie” (Lebensreformer). Tout à la fois pragmatique et romantique, ses intentions étaient de briser l'ennui, la positivité matérialiste, l'étroitesse des esprits, qui pesaient comme une chape de plomb sur les dernières années du XIXième siècle et les premières du XXième. Diederichs a perçu, longtemps à l'avance, que ce positivisme sans élan conduirait à de dangereuses impasses. Avec son regard synoptique, il a mis tous les moyens de sa maison d'édition en œuvre pour promouvoir pensées, sentiments et démarches cherchant à sortir de cet enlisement. Diederichs a ainsi rassemblé, dans les collections qu'il publiait, les auteurs réhabilitant le corps (et la “corporéité”), les adeptes du mouvement des cités-jardins en architecture, les réformateurs de la pédagogie qui avaient beaucoup de peine à faire passer leurs suggestions, les pionniers du mouvement de jeunesse, etc. L'objectif de Diederichs était de donner la parole à tous ceux qui se faisaient l'écho des œuvres de “maîtres à penser” incontestés comme Ruskin, Tolstoï, Herder, Fichte et Schiller. Le noyau rénovateur, dynamique et “énergisant” de leur pensée ou de leurs démarches avait été progressivement refoulé hors de la culture dominante, statique et rigidifiée, pour s'exprimer dans des sub-cultures marginalisées ou dans des cénacles tâtonnants, critiques à l'endroit des piliers porteurs de la civilisation occidentale, positiviste et matérialiste. Outre l'art, la voie de l'artiste, trois voies s'offraient, selon Diederichs, à ceux qui voulaient sortir des enfermements positivistes: une rénovation de la tradition idéaliste, un néo-romantisme, une nouvelle mystique.
Esthétique et énergie chez Schiller
Deuxième écueil à éviter dans toute démarche anti-positiviste: le repli sur des dogmes étroits, sur des manies stériles coupées de tout, sur des réductionnismes incapacitants, qui empêchent l'émergence d'une nouvelle culture, dynamique, énergique et plurielle, ouverte sur tous les faits de monde. Dogmatisme et rénovation, dogmatisme et vie, sont en effet incompatibles; Diederichs n'a jamais cessé de vouloir mettre cette incompatibilité en exergue, de la clouer au pilori, de montrer à quelles envolées fécondes elle coupait les ailes. Le projet à long terme de Diederichs a été clairement esquissé lors de la célébration du 100ième anniversaire de la mort du poète Schiller, le 9 mai 1905. Poète et penseur du classicisme allemand, Schiller avait aussi mis l'accent sur l'esthétique et l'art, éléments indispensables dans une Cité harmonieuse. Celle-ci ne devait pas exclusivement mobiliser les ressorts de la politique, ou se préoccuper uniquement d'élections et de représentation, mais insuffler en permanence une esthétique, ciment de sa propre durée et de sa propre continuité. Schiller parie sur l'éducation de la personne et sur le culte de la beauté, afin d'avoir des citoyens “harmonieux et éthiques” (harmonisch-sittlich), portés par une “liberté intérieure”, autant d'individualités créatrices capables de donner forme à l'histoire.
Comment réaliser l'idéal schillerien du citoyen dans l'Allemagne wilhelminienne, où l'éducation n'oriente nullement les élèves vers l'esthétique, la liberté intérieur ou l'harmonie créatrice? Diederichs, attentif à tout ce qui se passait dans sa ville d'Iéna, découvre en 1908, un groupe d'étudiants rebelles à la positivité pédagogique de la “Belle Epoque”. Cette Jenaer Freie Studentenschaft s'était créée en mai 1908; un mois plus tard, Diederichs invite ces jeunes gens et filles à participer à une fête solsticiale qu'il finance et organise sur le Hoher Leeden, une hauteur proche de la ville. C'est ainsi que naît le “Cercle Sera”. L'objectif est une réforme anti-autoritaire et anti-positiviste de la pédagogie, de l'éducation, de la vie en général. La volonté des participants et adeptes de ce mouvement culturel étudiant est de forger un style nouveau, qui évitera l'écueil des encroûtements (stilbildend). Mais pour rendre une telle démarche possible, il faut sortir l'étudiant et l'intellectuel de leur tour d'ivoire, restaurer une socialité culturelle et festive, où l'on rit, chante, s'amuse et échange des idées. Diederichs a plusieurs modèles en tête quand il envisage la restauration de cette socialité intellectuelle et festive: 1) le panthéisme et le mysticisme de la bohème poétique berlinoise (le Friedrichshagener Kreis); 2) les cercles culturels de la Renaissance italienne (dont il a appris l'existence par le livre de Jacob Burckhardt Kultur der Renaissance in Italien); 3) l'accent mis par Nietzsche sur le dionysiaque et sur les chœurs bacchiques en Grèce; 4) les traditions allemandes médiévales des danseurs de la Saint-Jean et de la Saint-Guy (Sanct-Johann- und Sanct-Veittänzer); 5) l'esprit des maîtres-chanteurs de Hans Sachs. Cette culture dionysiaque de l'expression et de l'effervescence permet d'expérimenter la communitas sacrée, de transcender des normes qui, si elles n'étaient jamais transcendées, deviendraient très vite les étouffoirs de la créativité. En effet, la créativité artistique n'est nullement la répétition rituelle des mêmes gestes conventionnels.
Pour une pédagogie nouvelle
Raison pour laquelle les fêtes solsticiales du Cercle Sera n'ont jamais été pareilles ni répétitives: Diederichs voulait qu'elles soient chaque fois l'occasion d'injecter dans les esprits de nouvelles idées ou de nouvelles formes. Ainsi la chanteuse norvégienne Bokken Lasson, innovatrice dans son art, participe en 1905 au solstice de la Lobedaburg. En 1906, des groupes de danseurs suédois présentent leurs danses traditionnelles mais réactualisées. En 1907, les jeunes de Iéna présentent de nouvelles danses de leur composition, inspirées des Minnelieder médiévaux. Chaque fête de mai ou du 21 juin est l'occasion de découvrir une facette de la littérature ou de la pensée panthéiste européenne (François d'Assise, Spiele de Hans Sachs, poésies d'Eichendorff ou de Goethe), mais sous des formes toujours actualisées.
A partir de 1908, l'idéal schillerien, théorisé depuis mai 1905, prend corps et se double de la volonté de promouvoir en Allemagne une pédagogie nouvelle, basée sur la notion d'énergie théorisée par Schiller, sur l'élan vital bergsonien, sur le dionysiaque chanté par Nietzsche, etc. Deux mouvements alimentent en effectifs et en inspirations le Cercle Sera: 1) Les étudiants dissidents de l'Université de Leipzig qui se nommaient les Finken (les pinsons) ou les Wilden (les sauvages) ou encore, plus simplement, les Freie Studenten (Les libres étudiants), dégagés des structures rigides de l'université conventionnelle. 2) Les jeunes du mouvement de jeunesse Wandervogel. Le Cercle Sera recrute une élite étudiante et lycéenne, très cultivée, adepte de la mixité (un scandale pour l'époque!), à la recherche de nouvelles formes de vie et d'une éthique nouvelle. Pour Diederichs, ce groupe “semble enfin réaliser les objectifs sur lesquels l'ancienne génération avait écrit et dont elle avait parlé, mais dont elle espérait l'advenance dans un très lointain avenir”. Désormais, à la suite des fêtes solsticiales et sous l'influence des randonnées des Wandervögel, le groupe pratique les Vagantenfahrten, les randonnées des Vagantes, c'est-à-dire les “escholiers pérégrinants” du moyen âge. On se fait tailler des costumes nouveaux aux couleurs vives, inspirés de cette tradition médiévale. Diederichs espère que cette petite phalange de jeunes, garçons et filles, cultivés et non conformistes va entraîner dans son sillage les masses allemandes et les tirer hors de leurs torpeurs et de leurs misères. Il a conscience de forger une “aristocratie de l'esprit” qui sera un “correctif culturel” visant à transformer les principes politiques dominants, à insuffler le sens schillerien de l'énergie et l'élan vital de Bergson dans la pratique quotidienne de la politique. Mais Diederichs est déçu, après une fête qu'il avait organisée le 7 juin 1913, avec beaucoup d'artistes et d'acteurs: trop de participants s'étaient comporté comme des spectateurs, alors que, se plaignait Diederichs, dans une vraie fête traditionnelle ou hellénique-dionysiaque, il n'y a jamais de spectateurs, mais seulement des participants actifs. Diederichs constatait, non sans amertume, que la fête traditionnelle ne semblait pas pouvoir être restaurée, que la modernité avait définitivement cassé quelque chose en l'homme, en l'occurrence la joie spontanée et créatrice, le sens de la fête.
De toute l'aventure du Cercle Sera, où se sont rencontrés les philosophes Hans Freyer et Rudolf Carnap, émergeront principalement les méthodes pédagogiques d'enseignement aux adultes, avec Alexander Schwab, Walter Fränzel, Hildegard Felisch-Schwab (pédagogie spéciale des orphelins), Elisabeth Czapski-Flitner, Helene Czapski, Hedda Gagliardi-Korsch.
Les hérétiques sont les seuls esprits créateurs
Sur le plan religieux, Diederichs se considérait personnellement comme un grand réformateur, plus exactement comme “l'organisateur du mouvement religieux extra-confessionnel”. Il accusait les théologiens du pouvoir, de l'université et des églises officielles d'avoir bureaucratisé la foi, d'avoir enfoui la flamme de la religion sous les cendres du dogmatisme, des intrigues et du calcul politicien. La religion vivante des traditions et de nos ancêtres s'est muée en “histoire morte”, a été déchiquetée par le scalpel d'un rationalisme sec et infécond. La démarche de Diederichs était dès lors de “revenir aux racines de notre force (= la religion, la foi) la plus profonde”. Le protestantisme, d'où Diederichs est pourtant issu, est grandement responsable, disait-il, de cette crise et de cette catastrophe: il a donné la priorité au discours (le prêche et les commentaires des écritures) plutôt qu'au culte (festif et communautaire), plutôt qu'aux sentiments, à la sensualité ou à l'émotion. Le réel homo religiosus du début du XXième siècle doit avoir la volonté de rebrousser chemin, de retourner à la foi vive, de tourner le dos à la religion étatisée, au cléricalisme et à l'académisme. Dans cette optique, Diederichs ouvrira les portes de sa maison d'édition à tous ceux que les dogmatiques avaient marginalisés, aux non-conformistes et aux innovateurs qui “osent saisir le religieux de manière explorante et expérimentale”. A plus d'une reprise, il déclare: “Les hérétiques sont les esprits créateurs par excellence dans l'histoire des religions”. Et il citait aussi souvent une phrase de Jakob Grimm: «Savez-vous où Maître Eckehart me touche le plus? [...] Là où il sort de l'étroitesse de la religion pour passer à l'hérésie». En 1901, le théologien totalement hérétique Arthur Bonus (cf. infra), un des auteurs favoris de Diederichs, résumait clairement leur optique: «Les autorités sont là pour être combattues».
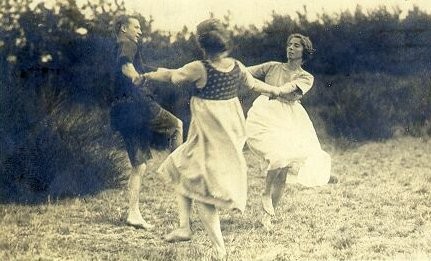
Pour répondre au rationalisme de la théologie officielle et au dogmatisme, Diederichs préconise de faire appel à des modes de pensée holistes, vitalistes et existentialistes. C'est le noyau vital des religions qu'il faut saisir, même au prix d'associations étonnantes, de comparaisons audacieuses, où Zarathoustra va voisiner le Christ, Goethe va se retrouver mêlé à Nieztsche, tout comme Marx à Wagner. Des multiples traditions panthéistes, les auteurs de la maison d'édition de Diederichs vont extraire des motifs et des démarches conceptuelles pour façonner un Dieu qui est tantôt source créatrice de tous les phénomènes de la Vie, tantôt “puissance d'ascension déclenchant une créativité absolue”. Toutes les visions de Dieu chez les auteurs de Diederichs impliquaient un Dieu dynamique, décideur, actif, créatif et animé d'une forte volonté d'action.
Une religion qui dynamise les volontés
En effet, par le terme “religion”, Diederichs n'entendait pas une attitude contemplative, purement intériorisée: son interprétation du phénomène religieux était vitaliste et dynamique, portée par une forte volonté de mener une action dans et sur le monde. Certes, fasciné par la tradition mystique allemande, il n'excluait par l'introspection religieuse, l'importance de l'intériorité et des forces qui y sont tapies, la découverte par la réflexion des profondeurs de la subjectivité, mais ce mouvement de l'esprit vers l'intériorité visait la libération de forces insoupçonnées pour parfaire une action correctrice, esthétisante ou éthique dans le réel extérieur. La religion permet à l'homme d'accroître sa volonté individuelle pour la vie, de rassembler des potentialités pour arraisonner le monde. Dans une brochure commentant ses collections, Diederichs écrivait en 1902: «Une culture religieuse n'est pas tellement dépendante de sa conception de la vie dans l'au-delà [...] Elle veut plutôt réaliser le telos de cette Terre, qui est de créer dans l'en-deça des individualités de plus en plus fines dans une Règne dominé par l'esprit. Les pures spéculations d'idées sur Dieu, l'immortalité [...] et autres doctrines de l'Eglise cèdent le pas, ne sont plus considérées comme essentielles, et font place à la Vie religieuse, qui correspond aux lois du Cosmos et aux lois de la croissance organique; la religion ne peut dès lors plus être reconnue qu'à ses fruits». En 1903, Diederichs écrit au Pasteur Theodor Christlieb qu'il voulait, avec ses livres, “promouvoir une religion sans regard vers le passé, mais dirigée vers l'avenir”. Pour désigner cette religion “futuriste”, Diederichs parlait de “religion du présent”, “religion de la volonté”, “religion de l'action”, “religion de la personnalité”. Avec le théologien protestant en rupture de banc Friedrich Gogarten (“théologien de la crise”, “théologien dialectique”), Diederichs évoquait “une religion du oui à la Vie, bref, une religion qui dynamise les volontés”.
Action et création
La religion (au sens où l'entendaient Diederichs et ses auteurs), la “théosophie” (terme que Diederichs abandonnera assez vite) et le néo-romantisme visent “une saisie immédiate de la totalité de la vie”, afin de dépasser les attitudes trop résignées et trop sceptiques, qui empêchent de façonner l'existence et affaiblissent les volontés. «Plus de savoir mort, mais c'est l'art qui devrait transformer l'âme et les sentiments des hommes et les conduire à l'action pratique» (on reconnait là le thème schillerien récurrent dans la démarche de Diederichs). Parmi les auteurs qui allaient expliciter et répandre cette vision holiste de la vie, Arthur Bonus, autre théologien protestant en rupture de banc, sera certainement le plus emblématique. Dans Religion als Schöpfung (1902; = La religion comme création), Bonus présente la religion comme une “conduite de la vie”, où l'homme se plonge dans la vectorialité réelle du monde, qu'il a d'abord saisie par intuition; il entre ainsi en contact avec la puissance divine créatrice du monde et, fortifié par ce contact, se porte en avant dans le monde sous l'impulsion de ses propres actions. Dans ce sens, la religion est une attitude virile et formatrice, elle est pures action et création. Les églises, au contraire, n'avaient eu de cesse de freiner cette activité créatrice forte, de jeter un soupçon sur les âmes fortes en exaltant la faiblesse et la mièvrerie des âmes transies, incapables de donner du neuf à la vie. Mais Bonus, théologien bien écolé, ne réduit pas son apologie de la vie à un naturalisme voire à certaines tendances maladroites du panthéisme qui dévalorisent —comme les églises mais au nom d'autres philosophades— l'action de l'homme créateur et énergique, sous prétexte qu'elle serait une dérive inhabituelle —et pour cela non fondamentale— ou éphémère de la matière ou d'un fond-de-monde posé une fois pour toute comme stable, immuable. Bonus réclame l'avènement d'une religion qui ne refuserait plus le monde et son devenir perpétuel, mais pousserait les hommes à participer à son façonnage, à agir avec passion pour transformer les simples faits objectifs en principes spirituels supérieurs. Telle est la “germanisation du christianisme” qu'il appelle de ses vœux. Bonus, bien qu'argumentant en dehors des sentiers battus de la théologie protestante, a suscité avec ses thèses bien des émois positifs chez ses pairs.
Autre livre qui fit sensation dans le catalogue de Diederichs: l'essai Rhytmus, Religion, Persönlichkeit (= Rythme, religion, personnalité) de Karl König. Dans la ligne de Bonus, la pensée religieuse de König se résume à ces quelques questions: «Entends-tu dans tout le chaos du présent le rythme secret de la vie? Laisse pénétrer ce rythme dans la profondeur de ton âme. Laisse Dieu travailler ta personne, pour qu'il la modèle et la façonne en toi. Ce n'est que là où l'on trouve un centre de force dans la vie spirituelle et personnelle que quelque chose peut se construire et se développer, qui donnera de la valeur à la vie».
L'objectif de Diederichs, en publiant quelques ouvrages paganisants, plus ceux des théologiens qui abjuraient une foi devenue sans relief, sans oublier les grands textes des traditions européennes (surtout mystiques), chinoises, indiennes etc., était d'opposer à la “phalange du logos” (les néo-kantiens, les phénoménologues et les positivistes logiques), la “phalange des défenseurs de la vie”.
Robert STEUCKERS.
00:05 Publié dans Mouvements de jeunesse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, mouvementsde jeunesse, jeunesse, allemagne, 19ème siècle, paganisme, néo-paganisme, tradition, édition, éditeur, culture |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 21 décembre 2009
Presseschau (Dezember 4)
 PRESSESCHAU
PRESSESCHAU
(Dezember / 4)
Einige Links. Bei Interesse anklicken...
###
Untersuchungsausschuß
Guttenberg fordert Fairneß für seine Frontkämpfer
„Transparenz und Aufklärung“ hat Verteidigungsminister Guttenberg bei seinem Überraschungsbesuch in Afghanistan versprochen. Der Bundestags-Untersuchungsausschuß dürfe die Soldaten aber nicht diskreditieren, mahnte er. Zugleich sagte er den Opfern des Bombardements schnelle Hilfe zu.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,666564,00.html
Bundeswehr in Afghanistan
Luftangriff galt gezielter Tötung von Taliban-Chefs
Immer neue Details des Luftangriffs auf zwei Tanklastzüge in Kundus belasten nun auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ihr Amt soll die gezielte Liquidierung von Taliban-Führern durch die Bundeswehr gebilligt haben. Darauf habe auch der Luftschlag in Kundus gezielt. Der Angriff galt demnach nicht den Fahrzeugen [„nicht nur“ wäre wohl die korrektere Formulierung!].
http://www.welt.de/politik/ausland/article5506968/Luftangriff-galt-gezielter-Toetung-von-Taliban-Chefs.html
Kunduz-Augenzeuge
„Es sah aus, als ob die Erde Feuer spuckt“
Waren die Bomben auf die Tanklaster bei Kunduz gerechtfertigt? Waren die Menschen um die LKW wirklich Taliban? Zum ersten Mal spricht im SPIEGEL-ONLINE-Interview ein Augenzeuge über die Nacht des Bombardements bei Kunduz – Tanklastwagenfahrer Abdul Malek.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,666825,00.html
Kunduz-Affäre
Guttenberg rechnet mit seinen Gegnern ab
Verteidigungsminister Guttenberg geht in die Offensive: Im Bundestag warf der CSU-Politiker der Opposition bei der Aufklärung der Kunduz-Affäre schlechten Stil vor – und kritisierte die gefeuerten Spitzenbeamten Schneiderhan und Wichert. Die SPD lästert über den „Minister der Selbstverteidigung“.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,667496,00.html
Kunduz-Bombardement
Guttenberg lehnt Rücktritt ab
Verteidigungsminister Guttenberg will im Amt bleiben - trotz immer schärferer Vorwürfe, in der Affäre um den Luftangriff bei Kunduz die Unwahrheit gesagt zu haben. Die SPD stellt wegen des fatalen Einsatzes inzwischen offen den Fortbestand der Elitetruppe KSK in Frage.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,666858,00.html
Hierzu ein Kommentar von Generalleutnant a. D. Hans-Heinrich Dieter, der selbst einmal Kommandeur des KSK war
http://www.md-office-compact.de/BeschranktePolitik.htm
http://www.sondereinheiten.de/forum/viewtopic.php?f=10&t=15697&start=2130
Afghanistan
Nato fordert deutlich mehr deutsche Soldaten/Rückendeckung für Oberst Klein durch deutschen Vier-Sterne-General
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,667058,00.html
Schreiben aufgetaucht
So bat Schneiderhan Guttenberg um Entlassung
Welche Umstände führten zur Entlassung des Generalinspekteurs der Bundeswehr? Um diese Frage tobt seit Tagen ein heftiger Streit. Jetzt ist Wolfgang Schneiderhans Schreiben, in dem er Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg um die Entlassung bittet, an die Öffentlichkeit gelangt.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5557581/So-bat-Schneiderhan-Guttenberg-um-Entlassung.html
Konflikte
Taliban planten angeblich Sturm auf Feldlager
Der deutsche Oberst Georg Klein soll den Luftschlag in Kundus unter dem Eindruck von Geheimdienstinformationen über Pläne der Taliban zur Erstürmung des Bundeswehrfeldlagers befohlen haben.
http://www.focus.de/politik/ausland/konflikte-taliban-planten-angeblich-sturm-auf-feldlager_aid_463568.html
Afghanistan
Taliban-Attacken auf Bundeswehr nehmen stark zu
Mehr als 60 Mal haben in diesem Jahr Kämpfer der Taliban die Bundeswehr angegriffen. Die Zahl der Attacken im Norden Afghanistans hat sich damit sprunghaft erhöht – im Jahr 2008 waren es lediglich 31. Verteidigungsminister Guttenberg mahnte eine offene Darstellung der Situation an.
http://www.welt.de/politik/ausland/article5534152/Taliban-Attacken-auf-Bundeswehr-nehmen-stark-zu.html
Und so sieht das dann aus ...
Deutsche Soldaten im Feuerkampf (Video und Fotos)
Germany at war: New offensive in North-Afghanistan
http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?t=170712
Bundeswehrverband
„Wir müssen auch töten, um uns zu schützen“
Von Thorsten Jungholt
Die Bürger und sogar weite Teile des Parlaments wissen nicht, wie ernst die Lage der Bundeswehr in Afghanistan ist, glaubt der Chef des Bundeswehrverbands, Ulrich Kirsch. Die Regierung habe den Einsatz absichtlich beschönigt. Mit WELT ONLINE sprach Kirsch über den Luftangriff von Kundus und das Versagen der Politik.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5539544/Wir-muessen-auch-toeten-um-uns-zu-schuetzen.html
„No Parade for Hans“
Von Martin Böcker
Von Zeit zu Zeit ist es die Sicht eines Außenstehenden, welche dem Selbstbild zu nötigen Korrekturen verhelfen kann. Es bietet vielleicht einen Anhaltspunkt für das, was normal, nicht normal oder auch seltsam ist. Einen Blick auf das deutsche Verhältnis zum Soldaten gibt uns die New York Times: „No Parade for Hans“. Ein Titel, der Spott vermuten läßt.
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M5454c0d5031.0.html
Vorratsdatenspeicherung
Die größte Verfassungsbeschwerde aller Zeiten
Von Thorsten Jungholt
Prävention ist wichtig, Bürgerrechte sind wichtiger: Fast 35.000 Bürger haben Verfassungsbeschwerde gegen die Massenspeicherung von Telefon- und Internetdaten eingereicht. Die Kläger – unter ihnen Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger – haben gute Chancen auf Erfolg.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5540937/Die-groesste-Verfassungsbeschwerde-aller-Zeiten.html
Brüssel
Machtkampf um Gehaltserhöhung für EU-Beamte
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,665746,00.html
http://diepresse.com/home/politik/eu/527064/index.do?_vl_backlink=/home/politik/eu/index.do
http://www.welt.de/die-welt/debatte/article5483035/Bruesseler-Elfenbeinturm.html
Gesundheitsfonds fehlen weitere 2,1 Milliarden
http://www.zeit.de/newsticker/2009/12/11/iptc-hfk-20091211-82-23264128xml
Sozialversicherung
Junge Generation verabschiedet sich vom Sozialstaat
Von der gesetzlichen Sozialversicherung erwarten die 30jährigen nichts mehr, daran ändert auch die neue Regierung nichts. Die junge Generation reagiert auf ihre Weise: Still und leise verabschiedet sie sich aus dem Sozialstaat.
http://www.wiwo.de/politik-weltwirtschaft/junge-generation-verabschiedet-sich-vom-sozialstaat-414604/
Die Klasse und die Abdankung des Staates
Von Felix Menzel
Dieses Jahr lief in einigen kleinen Kinos der Film „Die Klasse“ nach dem gleichnamigen Roman von François Bégaudeau. Der Autor verarbeitet darin seine Erfahrungen als Lehrer in den Pariser Problemvierteln, den banlieues, und schildert die ethnischen und sozialen Bruchlinien, die durch seine Klasse verlaufen und ein Lernen unmöglich machen.
http://www.sezession.de/9984/die-klasse-und-die-abdankung-des-staates.html#more-9984
Schäuble vs. Schönbohm
Von Martin Lichtmesz
Am Montag abend besuchte ich eine Buchpräsentation in der Landesvertretung Brandenburg / Mecklenburg-Vorpommern in Berlin. Vorgestellt wurden die Erinnerungen Jörg Schönbohms mit dem schönen Titel „Wilde Schwermut“, erschienen im Landt-Verlag. Am Podium neben dem Autor: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und als Moderator der ehemalige FAZ-Redakteur Karl Feldmeyer.
http://www.sezession.de/10027/schaeuble-vs-schoenbohm.html#more-10027
FPÖ und Kärntner BZÖ fusionieren
BERLIN. Die FPÖ und der Kärntner BZÖ-Landesverband haben mit sofortiger Wirkung eine politische Kooperation beschlossen. Ziel dieser Zusammenarbeit sei „die Bündelung der politischen Kräfte rechts der Mitte“ als Kampfansage an die „Versagenspolitik von SPÖ und ÖVP“.
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M56c9923b945.0.html
Oberstaatsanwalt Walch belastet Mannichl
Der Passauer Oberstaatsanwalt Helmut Walch hat in einem Gespräch mit stern.de erstmals öffentlich bestätigt, daß es im Fall Mannichl jede Menge Widersprüche gibt und es immer unwahrscheinlicher werde, daß es sich „um einen gezielten Anschlag aus der rechtsradikalen Szene“ gehandelt habe. Mannichl übte sich zuletzt in der BILD in Polizistenschelte. Diese hätten bei den Ermittlungen geschlampt.
http://www.pi-news.net/2009/12/oberstaatsanwalt-walch-belastet-mannichl/#more-105519
Uniformierte Heulsuse
Von Thorsten Hinz
Kommt doch noch Licht in die Mannichl-Affäre? Durch die Hintertür und gegen den Willen von Politik und Medien? Was der zuständige Oberstaatsanwalt Walch gegenüber stern.de äußerte, pfeifen zwar längst die Spatzen von den Dächern, aber aus dem Mund eines hohen Justizbeamten erhält es zusätzliche Plausibilität. Ein taz-Interview, in dem der ehemalige Polizeichef von Passau Ermittlungspannen bei der erfolglosen Tätersuche nicht ausschließen wollte, muß bei Polizei und Staatsanwaltschaft das Faß zum Überlaufen gebracht haben.
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M53cb866512e.0.html
Neue Neonazi-Strategie
Wie Rechtsextreme ihre Gegner drangsalieren
Von Christoph Ruf
Angesichts knapper Kassen und häufiger Demo-Verbote hat die rechtsextreme Szene im Südwesten eine neue Strategie entwickelt: Die Neonazis kapern Veranstaltungen politischer Gegner. Nun ist ein baden-württembergischer SPD-Landtagsabgeordneter ins Visier der NPD geraten. [Gemeint ist der berüchtigte JF-Hasser Stephan Braun. Zitat Braun: „Die haben sich gleich in größeren Gruppen im Raum verteilt und die ganze Zeit über versucht, die Diskussion in ihrem Sinne zu steuern.“ Wie undemokratisch ... ;-)]
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,666440,00.html
Punk durch Bestellschein
Von Claus Wolfschlag
Auf der „Zeitgeist“-Seite der „Jungen Freiheit“ vom 11. Dezember 2009 erschien eine kleine Notiz aus meiner Feder zu einem Versandshop für „Punk“-Utensilien, also für Musik, Bekleidung, Schmuck und Devotionalien. Darin wurde die Verbindung dieses Ladens zur Szene der „autonomen Antifa“ hervorgehoben. So bietet der aus der Politband S.I.K. hervorgegangene „Nix Gut“-Versand, dies sei nur als ein Beispiel genannt, ganz offen Kapuzenpullis und Hosen der recht eindeutigen Serie „autonom streetsports“ an.
http://www.sezession.de/10001/punk-durch-bestellschein.html#more-10001
Immer wieder montags in Potsdam ...
Ungefähr 500 Teilnehmer versammelten sich gestern [14.12.09] um 18 Uhr im Halbdunkel vor dem Nauener Tor in Potsdam, um am zweiten Montag hintereinander gegen die Regierung aus SPD und Linke in Brandenburg zu demonstrieren, deren Start seit Wochen von immer neuen Stasi-Enthüllungen überschattet wird. Viele Menschen trugen brennende Kerzen in den Händen oder hatten selbstgemalte Transparente mitgebracht. „Stasi in die Produktion“ hieß es darauf oder „Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten!“
http://www.pi-news.net/2009/12/immer-wieder-montags-in-potsdam/
Silvio Berlusconi bei Kundgebung attackiert und verletzt
http://www.welt.de/die-welt/politik/article5522684/Silvio-Berlusconi-bei-Kundgebung-attackiert-und-verletzt.html
Neonazis bei der Bundeswehr
Braune Flecken auf der Uniform
Von Joachim F. Tornau und Carsten Meyer
Von einer „bodenlosen Denunziation“ spricht Axel von Baumbach. Der Bundeswehrmajor der Reserve steht in Treue fest zum Vorsitzenden seiner Reservistenkameradschaft. An dessen langjährigem rechtsextremen Engagement stört sich der adelige Forstassessor aus dem nordhessischen Kirchheim nicht: „Er ist eine der anständigsten Personen, die ich kenne.“
Der so Gepriesene heißt Wolfram M. und ist Chef der Kameradschaft in Großropperhausen, einem Ortsteil von Frielendorf im Schwalm-Eder-Kreis.
http://www.fr-online.de/top_news/2147863_Neonazis-bei-der-Bundeswehr-Braune-Flecken-auf-der-Uniform.html
Die Unerträglichkeit des Seins
Von Fabian Schmidt-Ahmad
„Unerträglich“ – da war das Wort wieder. „Unerträglich“ fand es der Würzburger SPD-Bürgermeister Georg Rosenthal, wenn man den „staatlich organisierten und komplett durchbürokratisierten Völkermord“ an den Juden mit anderen Ereignissen in irgendeiner Weise vergleiche.
Ein Modewort macht die Runde. Irgend etwas „unerträglich“ zu finden, ist heute schick. „Ich finde sie erbärmlich und unerträglich“, keifte der Dresdner Oberstaatsanwalt Frank Heinrich den Mörder von Marwa an. „Unerträglich“ findet es auch der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Dieter Wiefelspütz, wenn deutsche Behörden illegale Ausländer erfassen und abschieben. Derartiges gehört wohl zu unserer bundesrepublikanischen „Empörungskultur“.
Der Wunsch hinter dieser öffentlich ausgelebten Entrüstung ist nicht schwer zu verstehen: Zum einen möchte man zeigen, was für ein moralisch empfindsames und sensibles Wesen man doch ist. Zum anderen erinnert man das Publikum an die eigene Wichtigkeit, da es wohl von öffentlichem Interesse sei, wenn der Betreffende irgendetwas „unerträglich“ findet. Eine Tugend, die in bigotten Zeiten wie diesen überlebensnotwendig scheint.
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M54aa6ef771e.0.html
Wer ist Hannes Stein
Von Erik Lehnert
Jemand, der (wie er selbst zugibt) ein „bißchen Philosophie für den Hausgebrauch“ studiert hat. Und dieser jemand, der als (ich muß hier einmal zu diesem Wort greifen) Minusseele noch sehr vorteilhaft beschrieben wäre, maßt sich ein Urteil über Heidegger an. Weil er jetzt gemerkt hat, daß eine andere Minusseele vor Jahren ein unglaublich schlechtes Buch über Heidegger geschrieben hat: Emmanuel Faye. In der Sezession 31 schrieb ich dazu folgende Rezension: (...)
http://www.sezession.de/10074/wer-ist-hannes-stein.html#more-10074
Vertriebenen-Zentrum
Historiker sieht Polen als Tätervolk verunglimpft
Von Gerhard Gnauck
Die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung erlebt einen neuen Eklat. Der einzige Pole im Beirat, der Historiker Tomasz Szarota, wirft hin, weil er an der Ausrichtung des Zentrums zweifelt. Die Deutschen würden in dem Zentrum als „das zweite große Opfer dieses Krieges“ präsentiert, die Polen als Tätervolk.
http://www.welt.de/politik/ausland/article5553159/Historiker-sieht-Polen-als-Taetervolk-verunglimpft.html
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M5273c9c80ad.0.html
Integrationsdebatte
Sarrazin fordert Kopftuchverbot für Schülerinnen
Bundesbank-Vorstand Thilo Sarrazin hat sich auf einer Podiumsdiskussion in Berlin erneut zum Thema Integration geäußert. Er würde Kopftücher im Schulunterricht verbieten, weil sie kein religiöses, sondern ein politisches Symbol seien. „In Europa haben wir steigende Zahlen von Muslimen, was in allen Ländern Probleme macht“, sagte Sarrazin.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5507124/Sarrazin-fordert-Kopftuchverbot-fuer-Schuelerinnen.html
Nordrhein-Westfalen
Rechtspopulisten planen Anti-Minarett-Kampagne
Von Kristian Frigelj
Die nordrhein-westfälische Vereinigung „Pro NRW“ nimmt die Schweiz zum Vorbild: Die rechtspopulistische Organisation will eine große Kampagne gegen Minarette und Moscheen starten und so gegen „muslimische Landnahme“ vorgehen. Dabei will „Pro NRW“ auch eine Klausel im EU-Reformvertrag nutzen.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5529800/Rechtspopulisten-planen-Anti-Minarett-Kampagne.html
Drohungen gegen Ali Kizilkaya
Islamrat erhält Ekel-Paket mit Schweineohr
Von Jörg Säuberlich
In einem Schreiben, das dem Paket an den Islamrat in Köln beilag, wurde das Schweineohr als „kostbare Reliquie aller Muslime“ bezeichnet. Darunter habe gestanden: „Grüße von Michel Friedman – Juden in Deutschland“. Islamrats-Chef Ali Kizilkaya äußerte sich besorgt über die „Islamphobie“ in Deutschland.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5552029/Islamrat-erhaelt-Ekel-Paket-mit-Schweineohr.html
Bamberger Erzbischof Ludwig Schick: Türken sollen sich für Kirchen einsetzen
http://nachrichten.rp-online.de/article/politik/Erzbischof-Tuerken-sollen-sich-fuer-Kirchen-einsetzen/61334
Gewalt gegen Polizisten
„Irgendwann kämpfst du nur noch um dein Leben“
Schläge, Tritte, Beleidigungen, Morddrohungen – Berliner Polizisten schlägt immer öfter im Einsatz pure Aggression entgegen. Und immer öfter fühlen sich die Beamten wie Freiwild, die Gewalt eskaliert. Morgenpost Online hat zwei Polizisten in Wedding begleitet – eine harte Gegend, man fackelt hier nicht lange.
http://www.morgenpost.de/berlin/article1222632/Irgendwann-kaempfst-du-nur-noch-um-dein-Leben.html
Lob und Anerkennung
Von Martin Böcker
Yassin G. und seine Freunde greifen mitten in Berlin in der Nacht einen scheinbar wehrlosen Mann an. Die Gründe dafür sollen an dieser Stelle irrelevant sein, denn: zu fünft auf einen ist – gelinde gesagt – schwer zu rechtfertigen. Vielleicht war dieser Angriff nicht ihr erster, vielleicht fühlten sie sich deshalb besonders sicher. Aber es soll jetzt nicht um Yassin gehen, sondern um den Warnschuß und den Schuß ins Bein.
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M5ece5b61f3f.0.html
http://www.welt.de/vermischtes/article5449705/Ermittlungen-wegen-Schiesserei-in-Jugendpark.html
http://www.morgenpost.de/berlin/article1219119/Berliner-Zivilpolizist-schiesst-auf-Jugendlichen.html
Ausgang für Polizistenmörder?
Sechs Jahre nach dem Mord an dem Berliner Polizisten Roland Krüger und nur fünf Jahre nach seiner Verurteilung zu „lebenslanger“ Freiheitsstrafe sind für den Libanesen und Mörder Yassin Ali K. bereits Hafterleichterungen im Gespräch. Im nächsten Jahr soll er Familie und Freundin besuchen dürfen. Was die Justiz als Routine bezeichnet, macht Freunde und Kollegen fassungslos.
http://www.pi-news.net/2009/12/ausgang-fuer-polizistenmoerder/
Leutkirch: Schlägereien beim Zivilcouragepreis
„Je mehr Bürger mit Zivilcourage ein Land hat, desto weniger Helden wird es einmal brauchen“, heißt es hochtrabend auf der Webseite des Zivilcouragepreises 2009. Wie wahr, wie wahr, kann man da nur sagen. Denn bei der heutigen Vergabe des Preises in der Festhalle Leutkirch (Allgäu) kam es – wie schon im Vorjahr – zu Ausschreitungen und Schlägereien.
http://www.pi-news.net/2009/12/leutkirch-schlaegereien-beim-zivilcouragepreis/
Olpe: Toter und Tumulte nach Hip-Hop-Konzert
Ein Hip-Hop-Konzert in der sauerländischen Kreisstadt Olpe, bei dem eine Vielzahl Migranten türkischer Herkunft zu Gast war, beschäftigte die Polizei noch in der Nacht mit einem Großeinsatz. Die alarmierte Mordkommission sucht nach tödlichen Messerstichen nach einem Täter.
http://www.pi-news.net/2009/12/olpe-toter-und-tumulte-nach-hip-hop-konzert/
14jähriger Skater totgefahren
In Frankfurt ist ein 14jähriger Skateboardfahrer in einer Tempo-30-Zone von einem viel zu schnell fahrenden Auto totgefahren worden. Der Fahrer ließ das Kind sterbend zurück. Jetzt wurde der mutmaßliche Unfallwagen gefunden. Halter ist ein türkischer Familienvater, der sich bei seiner Festnahme völlig überrascht zeigte.
http://www.pi-news.net/2009/12/14-jaehriger-skater-totgefahren/
„Ein Irrtum wie die Rechtschreibreform“
Bologna und die Bachelorisierung
Hierin sind sich „Süddeutsche“ und FAZ einig: Nur die Analogie zur Rechtschreibreform beschreibt adäquat, was von den „Vereinfachungen“ durch die Studienreform zu halten ist.
http://www.sprachforschung.org/index.php?show=news&id=642
Handwerk beklagt vor Bildungsgipfel schlechte Schulbildung
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gDLLjdVkJNoarYly13X3Po_KaAyA
http://www.zeit.de/newsticker/2009/12/14/iptc-hfk-20091214-12-23282094xml
Vorweihnachtlich I: Vom Wäschetrocknen, der Wilden Jagd und Goethes Einsicht
Von Karlheinz Weißmann
Wenn früher jemand im ländlichen Niedersachsen gefragt wurde, was er zwischen Weihnachten und Dreikönig keinesfalls tun dürfe, so lautete die Antwort: „Wäsche zum Trocknen aufhängen“. Faßte man nach und wollte den Grund wissen, hieß es: „Weil sonst jemand im Hause stirbt.“
Meine Urgroßmutter und meine Großmutter haben sich streng daran gehalten, meine Mutter auch, oder doch beinahe: sie brachte die Wäsche auf den Trockenboden unseres Wohnblocks, – aber es blieb ein Unbehagen. Die jungen Frauen heute kennen nicht einmal mehr das.
http://www.sezession.de/9929/vorweihnachtlich-i-vom-waeschetrocknen-der-wilden-jagd-und-goethes-einsicht.html
Geschenktip „Wildes Deutschland“
Amazonas vor der Haustür
Von Stephan Orth
Geheimnisvolle Nebelberge, romantische Märchenwälder: Der Bildband „Wildes Deutschland“ zeigt Naturparks der Republik in poetischen Aufnahmen. Bei manchen von ihnen glaubt man kaum, daß sie nicht in Kanada, Südamerika oder in der Karibik entstanden sind.
http://www.spiegel.de/reise/deutschland/0,1518,666987,00.html
Leipzig
Nach Wiederaufbau
Gottesdienst in Paulinerkirche wird zur Demo
[auf die Leserkommentare achten!]
http://www.welt.de/kultur/article5461879/Gottesdienst-in-Paulinerkirche-wird-zur-Demo.html?page=0#article_readcomments
Humboldt-Forum
Das Aufbau-Team für das Berliner Schloß steht
http://www.welt.de/kultur/article5537959/Das-Aufbau-Team-fuer-das-Berliner-Schloss-steht.html?page=0#article_readcomments
Emanzipation
Wie Frauen sich selbst ruinieren
Von Naomi Wolf
Die feministische Idee gab den Frauen das Gefühl, alles zu können und zu wollen. Genommen hat sie ihnen aber die innere Ruhe. Die Töchtergeneration der Frauenbewegung setzt ihre Ansprüche an sich selbst gnadenlos hoch an. Für andere Formen von Leistung als beruflichen Erfolg ist kaum Platz.
http://www.welt.de/politik/article5548014/Wie-Frauen-sich-selbst-ruinieren.html
Heavy Metal und Gender. Nachtrag zu einer Konferenz an der Musikhochschule Köln
http://www.historyherstory.de/11.html
http://www.zeit.de/kultur/musik/2009-10/metal-gender-kongress
http://www.nmz.de/online/diva-satanica-eine-konferenz-ueber-heavy-metal-and-gender-an-der-koelner-musikhochschule
Alex Kurtagic: Mister
Von Martin Lichtmesz
Abteilung Entdeckungsreisen: Wer ab und zu auf englischsprachigen rechten Onlinemagazinen wie The Occidental Quarterly, The Occidental Observer oder dem superben Takimag surft, wird irgendwann auf den Namen Alex Kurtagic stoßen. Der 1970 geborene Kurtagic ist slowenisch-spanischer Abstammung, und lebt zur Zeit in Großbritannien, wo er ein Label für „Extreme Metal Music“ betreibt. Alternativen Genres der populären Musik wie Black Metal, Neofolk und Martial Industrial, in denen er eine „heidnische und neo-romantische Sensibilität“ fortwirken sieht, spricht Kurtagic eine immense metapolitische Bedeutung zu.
Kurtagic hat nun seinen ersten Roman „Mister“ veröffentlicht, den man genremäßig in den dunkleren Abzweigungen der Science-Fiction ansiedeln könnte. Die dystopische Literatur hatte immer schon einen Drall nach Rechts, aber auch zur Satire: man denke an Klassiker wie Samjatins „Wir“, Huxley’s „Brave New World“, Orwells „1984“ oder Burgess’ „A Clockwork Orange“, die allesamt die Versklavung, totale Kontrolle und letztlich Auslöschung des Individuums unter dem Banner von Kollektivismus, Fortschritt und Modernisierung anprangern. Zur näheren Verwandschaft von „Mister“ zählt allerdings auch der 1973 erschienene Roman „Das Heerlager der Heiligen“ von Jean Raspail, der schilderte, wie sich ein geistig entwaffnetes Europa kampflos einer Flut von Immigranten ergibt.
http://www.sezession.de/9424/alex-kurtagic-mister.html#more-9424
00:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, allemagne, politique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'autre signification de l'Etre
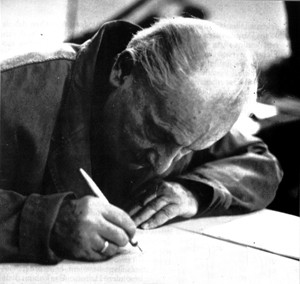 Archives des SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Archives des SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
L'autre signification de l'Etre
Dr. Angelika WILLIG
De qui un homme comme Ernst Jünger se sent-il compris? Certainement pas par ses adversaires qui ne combattent en lui que sa seule projection élitaire et militariste. Mais il ne doit pas se sentir davantage compris de ses épigones, qui sont incapables de le suivre dans les méandres difficiles de sa pensée et qui, au contraire, cherchent la facilité en vouant un culte simpliste à leur idole. Que reste-t-il dès lors, sinon la “grande conversation des esprits” dont a parlé Nietzsche et qui, à travers les siècles, n'est animée que par des hommes isolés, importants et significatifs.
Il est très rare que de tels isolés engagent un dialogue. Ainsi, Ernst Jünger s'est adressé à Martin Heidegger, à l'occasion des 60 ans de ce philosophe de la Forêt Noire, en écrivant à son intention Über die Linie, un opuscule qui aborde “le grand thème de ces cent dernières années”: le nihilisme. Heidegger s'est senti tellement interpellé par ce texte qu'à son tour, il a consacré à l'écrivain un opuscule, également intitulé Über' die Linie, à l'occasion des 60 ans de l'auteur du Travailleur en 1955. Cette rencontre a été très prometteuse, on s'en doute. Mais elle n'a pas promis plus qu'elle ne pouvait tenir, surtout à ceux qui s'en faisaient des idées fausses. Et totalement fausse aurait été l'idée, par exemple, que Jünger et Heidegger avaient pris délibérément la résolution d'écrire à deux un manifeste commun, fondateur d'une “révolution conservatrice” à laquelle nous pourrions encore adhérer aujourd'hui. Telle n'était pas l'intention de Jünger et de Heidegger: ils sont trop intelligents et trop prudents pour oser de tels exercices.
Métaphysique
Jünger part du principe que le nihilisme constitue un défi pour l'individu. L'individu, ici, est bien l'individu et non pas une classe particulière, ou une race, un parti ou un mouvement. En d'autres termes: le nihilisme n'est pas un problème politique mais un problème métaphysique. C'est là la raison essentielle qui motive Jünger quand il s'adresse à Heidegger car celui-ci a vu que la question décisive réside dans la métaphysique et non pas dans l'économie, la biologie ou la psychologie. Dans ce domaine, Jünger est bien sur la même longueur d'onde que le philosophe de la Forêt Noire: tous deux acceptent le fait que l'évolution historique bute contre une limite et qu'il n'est plus possible d'aller au-delà. Telle est la signification de l'image de la “ligne”, que Heidegger reprend à son compte, sans doute en la transformant: tel est bien le diagnostic du nihilisme. Jünger nous en livre une description qui culmine dans cette phrase: . Le nihilisme est dès lors la perte de toute assise solide et de toute durée, sur lesquelles on pourrait encore construire ou reconstruire quelque chose.
On songe tout de suite aux “idées” et aux “valeurs”. Mais Jünger pense sans nul doute aux attaques en règle qui sont perpétrées contre une “base ultime”, une assise primordiale, que nous pourrions parfaitement interpréter dans un sens écologique aujourd'hui. Jünger nous parle du “moment où la rotation d'un moteur devient plus forte, plus significative, que la répétion, des millions de fois, des formules d'une prière”. Ce “moment”, qui pourrait bien durer cent ans ou plus, désigne l'illusion qui veut que toute perfection technique ne peut réussir que sur base de biens donnés par Dieu ou par la nature, biens dont nous dépendons existentiellement et surtout dont nous sommes nous-mêmes une partie. Le “néant” que la modernité nihiliste semble répandre autour d'elle, n'est donc pas néant, rien, mais est en vérité le sol, sur lequel nous nous trouvons, le pain que nous mangeons, et l'âme qui vit en nous. Si nous nous trouvons dans des “paysages arides, gris ou brûlés” (Jünger), il peut nous sembler que rien n'y poussera ni n'y fleurira jamais. Mais plus nos souvenirs des temps d'abondance s'amenuisent, plus forts seront le besoin et le désir de ce dont nous avons réellement besoin et de ce dont nous manquons. Heidegger ne songe à rien d'autre quand il définit la disparition, l'absence, par la présence, ou quand il voit dans la Verborgenheit (l'obscurité, l'occultement) une sorte de “dépôt de ce qui n'est pas encore dévoilé (dés-occulté)”. Car si nous considérons l'homme dans son existentialité, son Dasein, soit sa détermination par son environnement (Umwelt), alors son Etre (Sein) ne peut jamais être mis entièrement à disposition; dès lors, plus le danger le menace, plus grande est la chance d'une nouvelle appropriation. Heidegger appelle cela l'“autre commencement”.
Refus de la conception linéaire de l'histoire
Tous deux s'opposent donc à la conception linéaire de l'histoire, à la conception qui voit l'histoire comme une ligne droite, sur laquelle on ne peut qu'avancer ou reculer, partageant du même coup les esprits en “esprits progressistes” et en “esprits conservateurs”. Pour Heidegger comme pour Jünger la ligne est transversale. “Le franchissement de la ligne, le passage du point zéro”, écrit Jünger, “partage le jeu; elle indique le milieu, mais non pas la fin”. Comme dans un cercle, elle recommence sa trajectoire après une rotation, mais à un autre niveau. Heidegger parle ici de la nécessité d'un "retour” ou d'un “retournement” et non pas d'un “recul vers des temps déjà morts, rafraîchis à titre d'expérimentation par le truchement de formes bricolées”. Jünger, lui aussi, a toujours évité ce fourvoiement, ce que l'on ne peut pas dire de tous ses contemporains! “Le retour”, signifie pour Heidegger, le lieu ou la pensée et l'écriture “ont toujours déjà été d'une certaine façon”.
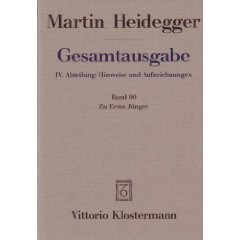 Heidegger estime aussi que “les idées s'embrasent” face à “cette image d'un sens unique”, impliquée par la ligne: c'est là que surgit la problématique du nihilisme —aujourd'hui nous parlerions plutôt de la problématique de la société de consommation ou de la société du throw away. Pourtant le philosophe émet une objection, qui est déjà perceptible dans une toute petite, mais très significative, transformation du titre: chez Jünger, ce titre est Über die Linie, et il veut désigner le franchissement de la ligne; chez Heidegger, c'est Über' die Linie. Il veut par l'adjonction de cette minuscule apostrophe expliciter à fond ce qu'est la zone, le lieu, de cette ligne. Ce qui chez Jünger est invite à l'action, demeure chez Heidegger contemplation. Il est clair que l'objet de la philosophie n'est pas de lancer des appels, mais d'analyser. Et Heidegger, bien qu'il critique fortement les positions de l'idéalisme platonicien, est assez philosophe pour ne pas laisser passer sans sourciller la volonté activiste de participation de l'écrivain, son vœu et sa volonté de dépasser aussi rapidement que possible le nihilisme.
Heidegger estime aussi que “les idées s'embrasent” face à “cette image d'un sens unique”, impliquée par la ligne: c'est là que surgit la problématique du nihilisme —aujourd'hui nous parlerions plutôt de la problématique de la société de consommation ou de la société du throw away. Pourtant le philosophe émet une objection, qui est déjà perceptible dans une toute petite, mais très significative, transformation du titre: chez Jünger, ce titre est Über die Linie, et il veut désigner le franchissement de la ligne; chez Heidegger, c'est Über' die Linie. Il veut par l'adjonction de cette minuscule apostrophe expliciter à fond ce qu'est la zone, le lieu, de cette ligne. Ce qui chez Jünger est invite à l'action, demeure chez Heidegger contemplation. Il est clair que l'objet de la philosophie n'est pas de lancer des appels, mais d'analyser. Et Heidegger, bien qu'il critique fortement les positions de l'idéalisme platonicien, est assez philosophe pour ne pas laisser passer sans sourciller la volonté activiste de participation de l'écrivain, son vœu et sa volonté de dépasser aussi rapidement que possible le nihilisme.
Sujet & Objet
Heidegger admoneste Jünger, et cette admonestation se justifie théoriquement. A juste titre, Heidegger pense: «L'homme non seulement se trouve dans la zone critique de la ligne, mais il est lui-même, non pas pour soi et certainement pas par soi seulement, cette zone et ainsi cette ligne. En aucun cas cette ligne est... telle qu'elle serait un tracé franchissable placé devant l'homme». En écrivant cette phrase, Heidegger se rapporte à une idée fondamentale de Sein und Zeit, jamais abandonnée, selon laquelle l'homme n'est pas un “sujet”, placé devant un “objet”, mais est soumis à une détermination existant déjà avant tout rapport sujet/objet. L', tel qu'évoqué ici, acquiert une signification si différente de celle que lui conférait la métaphysique traditionnelle, que Heidegger, dans son essai, biffe toujours le mot (Sein), afin qu'on ne puisse plus le lire dans le sens usuel.
Pour le philosophe, une telle précision dans les termes est absolument indispensable, mais, quand on lit l'écrivain, cette précision conduit à des mécompréhensions ou des quiproquos. Jünger, en effet, ne s'en tient pas à la terminologie forgée par Heidegger, mais raisonne avec des mots tels “valeur”, “concept”, “puissance”, “morale”, “décision” et reste de ce fait dans le “langage de la métaphysique” et surtout dans celui du “métaphycisien inversé” que fut Nietzsche. Pourtant, l'écrivain ne peut pas être jugé à l'aune d'une philosophie du sujet, manifestement dépassée. C'est cependant ce que Heidegger tente de faire. Mais son jugement pose problème quand on repère le passage où Jünger se rapproche le plus de cet “autre” dans sa formulation: . Une fois de plus, Heidegger, après avoir lu cette phrase, pose une question très précise: l'Etre peut-il être quelque chose pour soi? Et le philosophe de la Forêt Noire corrige: .
Jünger complète Heidegger
De telles remarques nous aident à mieux comprendre Heidegger, mais ne sont presque d'aucune utilité quand nous interprétons l'écriture de Jünger. Le philosophe nous dit bien que “de tels doutes ne peuvent nullement égratigner la force éclairante des images”, mais cela ne le conduit pas à un examen plus précis du langage de Jünger. Par coquetterie, Heidegger évoque la confusion et l'imprécision de Jünger mais reste, lui, ferme sur sa propre voie, dans sa propre logique de penser, et ne cherche pas à comprendre les autres possibles. Quand Heidegger constate: “Votre jugement sur la situation trans lineam et mon explication de linea sont liés l'un à l'autre”, il reste finalement assez laconique.
Quoi qu'il en soit, la position de Jünger complète la pensée de Heidegger. Nous avons dit, en début d'exposé, que le nihilisme était une attitude de l'individu: en effet, toute question métaphysique ne concerne que chaque individu personnellement. Aucun ordre socio-politique ne peut changer quoi que ce soit au fait que chacun d'entre nous soit exposé aux dangers du monde, soit soumis à l'angoisse que cette exposition, cette Ausgesetzheit, suscite. Voilà pourquoi cela ne fait pas une grosse différence —à ce sujet Jünger et Heidegger sont d'accord— si le nihilisme se présente à nous sous la forme ou l'expression d'une dictature fasciste, ou sous celle d'un socialisme réel ou d'une démocratie de masse. Dans de tels contextes, la démarche de Heidegger a été la suivante: Heidegger a travaillé sur l'isolement de l'homme avec une précision jusqu'alors inégalée, en utilisant tout spécialement les ressorts de la critique du langage; ensuite, sa philosophie a constitué une tentative de transposer l'angoissante dépendance du moi, soi-disant “libre”, dans une sorte de “sécurité” (Geborgenheit), site d'apaisement des tensions, site de sérénité, où s'épanouit enfin la vraie liberté. En opérant ce retournement, il nous semble, que Heidegger perçoit l'homme comme sur le point de disparaître, écrasé sous le poids d'un sombre destin planétaire, et donne l'impression de devenir fataliste.
Mais cela, Heidegger ne l'a pas voulu, et ne l'a pas dit de cette façon. Et c'est pourquoi, nous apprécions ce discours post-idéaliste de Jünger insistant sur la “force chevaleresque de l'individu”, sur sa “décision” et sur la volonté de l'homme libre de se maintenir envers et contre tout. Car si le moi n'est même plus autorisé à formuler des projets, il est contraint de résister à son propre “empêtrement”, résistance qui, seule, appelera le démarrage d'un nouveau mouvement historique.
“Le poète et le penseur habitent des sommets voisins”, a dit un jour Heidegger. Leurs demeures sont haut perchées mais séparées par un gouffre. C'est bien ce que nous avons pu constater en comparant les positions de Jünger et de Heidegger. Mais ne se pourrait-il pas que ce soit précisément ce gouffre qui fait tout l'intérêt de la rencontre Jünger/Heidegger. l'on délibère, dit Jünger dans Le recours aux forêts, un ouvrage très proche d'Über die Linie, .
Dr. Angelika WILLIG.
(article paru dans Junge Freiheit, n°12/1995; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:09 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, ernst jünger, heidegger, métaphysique, révolution conservatrice, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 19 décembre 2009
Annotation sur le "Travailleur"
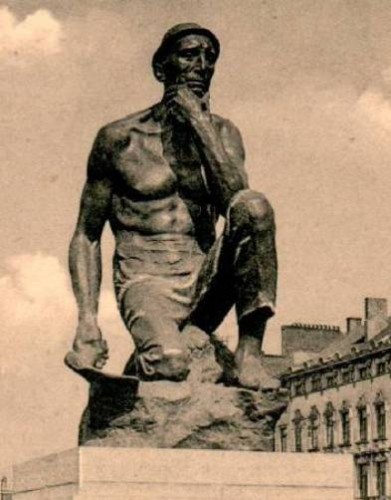 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Annotation sur le «Travailleur»
Dr. Karlheinz WEISSMANN
Ernst Jünger a toujours voulu que l'on inclue son Travailleur dans l'édition de ses œuvres complètes, surtout contre les “bien-pensants” qui l'exhortaient à prendre distance à l'endroit de ce “faux-pas” littéraire. Déjà dans une “Troisième lettres aux amis”, datée du 1er septembre 1946, Jünger insistait: il ne reniait rien de son œuvre, celle-ci devait être considérée comme un tout; il ne prenait ses distances d'aucun fragment de ce travail. Le rapport qui existe entre des écrits tels La mobilisation totale ou Le Travailleur, d'une part, et d'autres tels Jardins et Routes, est comparable à celui qui unit l'Ancien et le Nouveau Testament. Plus tard, il a répété cette formule de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais cela ne nous dit rien de clair, finalement, sur la valeur qu'il faut attribuer actuellement aux premiers écrits de Jünger. La seconde version du Cœur aventureux déjà, la décision de publier en 1934 une édition des œuvres complètes mais sans les textes nationalistes du début des années 20 ensuite, signale la volonté de Jünger de marquer une césure entre la partie purement politique de ses premiers écrits et ses livres ultérieurs. Mais il fit tout de même une exception de taille: les deux ouvrages que nous venons de mentionner, La Mobilisation totale et Le Travailleur. Mais au prix d'une interprétation qui rend presque méconnaissable l'intention initiale. Voilà pourquoi il m'apparaît opportun de poser une nouvelle fois la question: quelle est l'“assise dans la vie” que possèdent ces textes? Ce qui doit nous permettre de tourner notre regard vers un fragment de l'histoire des impacts obtenus par ses livres-clefs, histoire au demeurant peu connue, mais ô combien instructive et éclairante.
La Mobilisation totale et Le Travailleur étaient tous deux des livres apocalyptiques. Depuis le début des années 30 la crise s'accentuait considérablement en Allemagne; simultanément augmentait le besoin de “grandes solutions”. Les modèles technocratiques, les “Plans” de réorganisation de l'Etat et de la société bénéficiait d'une incontestable conjoncture, puisque le jeu libre des libéraux, en politique comme en économie, avait incontestablement failli. Pour les extrémistes de gauche, le modèle était les plans quinquennaux soviétiques, tandis qu'une fraction des économistes professionnels autour de John M. Keynes imaginait une politique interventionniste du plein-emploi. Enfin, des cercles de non-conformistes, où se rencontraient, pour échanger des idées, hommes de gauche et de droite, libéraux, sociaux-démocrates, des banquiers, des conservateurs et des nationaux-socialistes. Ces idées ont trouvé une écho dans le fameux “Plan WTB” (d'après les noms de ses inventeurs: Wladimir Woytinski, Karl Baade et Fritz Tarnow), édité par la fédération des syndicats (Gewerkschaftsbund), de même que dans le Wirtschaftliches Sofortprogramm der NSDAP (= “Programme économique tout-de-suite de la NSDAP”) de Gregor Strasser ou dans le Sofortprogramm de Günther Gereke qui devint par la suite Commissaire du Reich pour la politique de l'emploi dans le Cabinet von Schleicher. En lançant son appel à la “nostalgie anti-capitaliste”, Strasser a pu transformer en triomphe pour la NSDAP les élections de juillet 1932; ailleurs, le Président de l'ADGB, Theodor Leipart, tentait de rassembler tous les partisans de l'autarcie nationale, qui voulaient délivrer les syndicats libres du carcan de la SPD. Dans son célèbre discours de Bernau, le 14 octobre 1932, Leipart expliquait que la tâche du travailleur était de se mettre au service de son peuple; il évoquait l'«esprit soldatique de l'imbrication dans le Tout et du don de soi au Tout», qui devait animer le prolétariat dans l'avenir.
On peut avancer la thèse que Leipart a été inspiré par Le Travailleur de Jünger. A une époque aussi chaotique, les ennemis d'hier se rassemblent dans de nouveaux groupements: Le Travailleur avait incontestablement touché une corde sensible dans l'air du temps. Mais ce livre mythique et apocalyptique a également suscité une série d'incompréhensions. Les uns considéraient Le Travailleur comme un ouvrage “bolchévique”, d'autres y voyaient le résultat d'un culte impolitique de la technique, d'autres encore en interprétaient le contenu comme l'expression d'une philosophie nihiliste, née sous la pression des faits. Ce sont précisément les admirateurs de Jünger dans les ligues de jeunesse nationales-révolutionnaires et le mouvement Widerstand d'Ernst Niekisch qui se sont sentis interpellés et irrités. Une irritation qui s'est encore accrue quand Jünger, sans ambages, accepte la modernité et insiste sur le rapport unissant la “mobilisation allemande” et la “domination planétaire du Travailleur”. Si Jünger a voulu faire du Travailleur un écrit programmatique du “nouveau nationalisme”, alors il n'a pas été compris de son public ou n'a été accepté qu'avec réserve. En 1933, les dernières possibilités d'organiser des discussions fructueuses disparaissent.
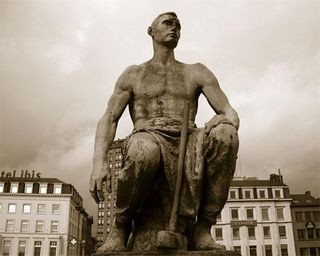 Mais, dans l'Allemagne nationale-socialiste, on comptait un petit nombre d'admirateurs de Jünger qui considéraient toujours que Le Travailleur était un manifeste et, en même temps, un manuel de politique pratique. Ce groupe se rassemble dans les années 30 autour de Meinhard Sild et Edgar Traugott. Tous deux appartenaient à la NSDAP clandestine d'Autriche et sont passés à la SS après l'Anschluß. Pourtant leurs idées étaient en ultime analyse bien différentes des directives principales qu'énonçaient les idéologues officiels de la NSDAP. Ils s'étaient doter d'un petit forum dans la revue Zeitgeschichte. La couverture de cette publication présentait un aigle et un serpent, les animaux du Zarathoustra de Nietzsche; la tonalité des articles et des poèmes publiés était franchement nietzschéenne. Ensuite, les jeunes hommes rassemblés autour de Sild et de Traugott se sentaient fidèles à un “socialisme” qui, tout-à-fait dans le sens du Travailleur de Jünger, voulait organiser la “mise au travail totale” et élever l'Allemagne au rang d'une puissance capable “d'intervenir de la façon la plus vigoureuse qui soit dans les rapports de force régissant le monde”. Pour eux, il ne s'agissait nullement de “totalitarisme” ou d'une justification folciste (= völkisch) des guerres pour l'espace vital: mais bien plutôt des effets de cette logique froide qui a tant fasciné Jünger lui-même. Traugott et Sild, à leur façon, tirent les leçons du “réalisme héroïque”, dont ils attendent qu'il “compénètre totalement le monde d'esprit guerrier, de réalisme et de paganisme”. Dans l'état actuel des recherches, on ne peut pas affirmer exactement quelle a été la nature du rapport entre Jünger, d'une part, et Traugott et Sild, d'autre part. Quoi qu'il en soit, leurs idées se sont différenciés dès que la guerre a éclaté. Sild a encore patronné l'édition de campagne de Feuer und Blut en 1941, mais déjà dans un article de juin 1939 pour les Nationalsozialistische Monatshefte, il exprime ses réserves quant à l'amitié qui lie Jünger au dessinateur Alfred Kubin, qui plonge son regard dans les abîmes les plus glauques de l'âme humaine et que Jünger considérait comme un “frère en esprit”. Cette amitié ne correspondait pas à ce que l'on attendait de Jünger, en qui on voyait, à l'époque, le “type même de l'activiste technique et le chef efficace”. La version finale des Falaises de marbre était, elle aussi, en contradiction avec cette image que l'on se faisait de Jünger. Traugott a consacré une longue recension à ce livre, dès sa parution, dans les colonnes de Zeitgeschichte: il y louait les qualités littéraires, tout en indiquant clairement ce qui le séparait de l'auteur. L'essai de Traugott, paru en 1941, Von der Führung (= Du Commandement) ne contient plus aucune allusion à Jünger; le contenu de cet ouvrage s'aligne largement sur l'orthodoxie nationale-socialiste.
Mais, dans l'Allemagne nationale-socialiste, on comptait un petit nombre d'admirateurs de Jünger qui considéraient toujours que Le Travailleur était un manifeste et, en même temps, un manuel de politique pratique. Ce groupe se rassemble dans les années 30 autour de Meinhard Sild et Edgar Traugott. Tous deux appartenaient à la NSDAP clandestine d'Autriche et sont passés à la SS après l'Anschluß. Pourtant leurs idées étaient en ultime analyse bien différentes des directives principales qu'énonçaient les idéologues officiels de la NSDAP. Ils s'étaient doter d'un petit forum dans la revue Zeitgeschichte. La couverture de cette publication présentait un aigle et un serpent, les animaux du Zarathoustra de Nietzsche; la tonalité des articles et des poèmes publiés était franchement nietzschéenne. Ensuite, les jeunes hommes rassemblés autour de Sild et de Traugott se sentaient fidèles à un “socialisme” qui, tout-à-fait dans le sens du Travailleur de Jünger, voulait organiser la “mise au travail totale” et élever l'Allemagne au rang d'une puissance capable “d'intervenir de la façon la plus vigoureuse qui soit dans les rapports de force régissant le monde”. Pour eux, il ne s'agissait nullement de “totalitarisme” ou d'une justification folciste (= völkisch) des guerres pour l'espace vital: mais bien plutôt des effets de cette logique froide qui a tant fasciné Jünger lui-même. Traugott et Sild, à leur façon, tirent les leçons du “réalisme héroïque”, dont ils attendent qu'il “compénètre totalement le monde d'esprit guerrier, de réalisme et de paganisme”. Dans l'état actuel des recherches, on ne peut pas affirmer exactement quelle a été la nature du rapport entre Jünger, d'une part, et Traugott et Sild, d'autre part. Quoi qu'il en soit, leurs idées se sont différenciés dès que la guerre a éclaté. Sild a encore patronné l'édition de campagne de Feuer und Blut en 1941, mais déjà dans un article de juin 1939 pour les Nationalsozialistische Monatshefte, il exprime ses réserves quant à l'amitié qui lie Jünger au dessinateur Alfred Kubin, qui plonge son regard dans les abîmes les plus glauques de l'âme humaine et que Jünger considérait comme un “frère en esprit”. Cette amitié ne correspondait pas à ce que l'on attendait de Jünger, en qui on voyait, à l'époque, le “type même de l'activiste technique et le chef efficace”. La version finale des Falaises de marbre était, elle aussi, en contradiction avec cette image que l'on se faisait de Jünger. Traugott a consacré une longue recension à ce livre, dès sa parution, dans les colonnes de Zeitgeschichte: il y louait les qualités littéraires, tout en indiquant clairement ce qui le séparait de l'auteur. L'essai de Traugott, paru en 1941, Von der Führung (= Du Commandement) ne contient plus aucune allusion à Jünger; le contenu de cet ouvrage s'aligne largement sur l'orthodoxie nationale-socialiste.
Tout ce que je viens d'écrire sur le groupe rassemblé autour de Traugott et Sild permet de comprendre le Jünger “politique”. L'engagement de Jünger dans les années 20 n'a pas été une marotte: sans aucun doute, il a appartenu aux têtes pensantes de la droite révolutionnaire allemande. Mais sa participation au débat politique n'autorise aucune simplification extrême, comme celles de l'historiographie boîteuse qui se pare du label d'“antifascisme”, en répétant ses arguments à satiété. Jünger était un nationaliste à l'époque mais il a toujours été plus que cela. Mais, après avoir écrit Le Travailleur, il tire une conclusion: la politique n'est qu'un phénomène superficiel qui n'influe en rien sur les processus titaniques à l'œuvre dans notre monde; Jünger n'a pas voulu s'exposer aux coups de cette “titanisation”, parce qu'il la croyait inévitable. Cette attitude est sans doute le résultat d'un moment de faiblesse, mais elle est aussi empreinte de sagesse. Car l'un des messages les plus forts de Jünger demeure le suivant: il est bon “de deviner que derrière les excès de dynamisme de notre temps se trouve caché un centre immobile”.
Dr. Karlheinz WEISSMANN.
(article paru dans Junge Freiheit, n°12/95; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, ernst jünger, philosophie, théorie politique, politologie, sciences politiques, nationalisme révolutionnaire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 18 décembre 2009
Presseschau (Dezember / 3)
 Presseschau
Presseschau
Dezember (3)
Einige Links. Bei Bedarf anklicken...
###
Minarettverbot: Türkischer Minister fürchtet Religionskrieg
Istanbul – Bislang hat das Schweizer Minarettverbot keine weltweite Krise nach sich gezogen, wie etwa einst der Streit über die Mohammedkarikaturen.Aber wenn man dem türkischen Außenminister Ahmet Davutoglu zuhört, dann war der Karikaturenstreit ein Kinderspiel gegen das, was nun auf Europa zukommt: „Wer kann sagen, daß Moscheen in Europa noch sicher sind?“, sagte er nach einem Besuch in Athen.Und er fuhr fort: „Vor 15 Jahren wurden Hunderte Moscheen in Bosnien niedergebrannt.“Zum wiederholten Male warnt er vor einer „globalen Krise“ und „globalen Zusammenstößen“ nach dem Schweizer Referendum und fühlt sich erinnert an die europäischen „Religionskriege des Mittelalters“. Er bietet die Hilfe der Türkei an, um diese „globale Krise“ abzumildern; aber ein wenig klingt es so, als wolle er die Krise erst herbeireden, um sich erneut als Wortführer der muslimischen Welt zu profilieren und die Türkei zugleich in die Rolle des Konfliktlösers zu manövrieren.
http://www.welt.de/die-welt/politik/article5432166/Minarettverbot-Tuerkischer-Minister-fuerchtet-Religionskrieg.html
Der dumme Junge Westerwelle
Von Thorsten Hinz
In der Wochenendausgabe der FAZ war ein ganzseitiges Interview mit Außenminister Guido Westerwelle zu lesen. Natürlich geht es um das Zentrum gegen Vertreibungen und Westerwelles Veto gegen einen Kuratoriumssitz für Erika Steinbach, wobei die Journalisten – unter ihnen Herausgeber Berthold Kohler, der seit Wochen Steinbach konsequent verteidigt – energisch nachfassen. Westerwelle wiederholt seinen Standpunkt im gewohnt schneidigen Tonfall, den er dem gerade verstorbenen FDP-Ehrenvorsitzenden Otto Graf Lambsdorff abgelauscht haben muß.
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M5c348fd0628.0.html
Du sollst nicht stehlen
Deutschland wird an die Angehörigen der bei einem Militäreinsatz gegen die Vorbereitung eines schweren Anschlags auf deutsche Aufbauhelfer getöteten afghanischen Raubmörder Entschädigung für die entgangene Beute zahlen. Die Verbrecher hatten zuvor zwei zivilen Fahrern zweier Tanklastzüge die Köpfe abgeschnitten und waren anschließend bei der Durchquerung eines Flusses steckengeblieben.
Befreundete Dorfbewohner waren zu Hilfe geeilt, um die Laster für den geplanten Anschlag zu mobilisieren und sich ihren Anteil an der Beute des Raubmordes zu sichern. Der blutige Deal mit der Bundesregierung wird vom Bremer Rechtsanwalt Karim Popal eingefädelt.
http://www.pi-news.net/2009/12/du-sollst-nicht-stehlen/#more-103622
Herr Rechtsanwalt Popal ist seit mehr als 3 Jahren nebenbei für den Justiz-Aufbau in Afghanistan tätig. Er unterrichtet Staatsanwälte, Richter und Anwälte in Afghanistan und trägt zum Aufbau der Justiz bei.
Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften in Bremen ist er seit 1992 als Rechtsanwalt zugelassen.
Er ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Aufenthaltsrecht des Bremischen Anwaltsvereins, Mitglied im Deutschen Anwaltsverein, Justitiar mehrerer ausländischer Vereine – u.a. auch der Dachorganisation Schura Bremen und des Moslemrats – und vertretungsberechtigt an allen Gerichten in der Bundesrepublik Deutschland.
http://www.anwalt.de/kanzlei-popal
Konflikte
Bundeswehrverband verteidigt Angriff von Kundus
Bundeswehrverbandschef Ulrich Kirsch hat den umstrittenen Luftangriff auf zwei Tanklastzüge nahe der nordafghanischen Stadt Kundus am 4. September verteidigt.
http://www.focus.de/politik/ausland/konflikte-bundeswehrverband-verteidigt-angriff-von-kundus_aid_457939.html
Bundeswehr sieht sich durch Nato-Bericht entlastet
Berlin – Die Bundeswehr sieht sich entgegen anderslautenden Darstellungen durch den geheimen Nato-Bericht über den Luftangriff auf zwei Tanklastzüge bei Kundus entlastet.Die deutschen Soldaten hätten eine massivere Bombardierung abgelehnt, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Montag. So hätten die Piloten der US-Kampfflugzeuge den Abwurf von mehr als sechs Bomben auf die von Taliban gekaperten Tanklaster angeboten. Die deutschen Befehlshaber hätten sich dann mit den Fliegern auf den Abwurf von zwei der kleinsten Bomben geeinigt.
http://www.welt.de/die-welt/politik/article5460424/Bundeswehr-sieht-sich-durch-Nato-Bericht-entlastet.html
Afghanistan
Elite-Einheit KSK war am Luftangriff beteiligt
Die Bundeswehr-Elite-Einheit KSK war einem Zeitungsbericht zufolge maßgeblich am umstrittenen Tanklasterangriff in Kundus beteiligt. Der gesamte Einsatz wurde demnach aus einem Kommandostand einer geheimen Einheit geführt. Chef der Task Force 47 soll der verantwortliche Oberst Georg Klein gewesen sein.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5483082/Elite-Einheit-KSK-war-am-Luftangriff-beteiligt.html
Eliteeinheit in Kunduz
KSK unterstützte Oberst Klein in der Bombennacht
Die Spekulationen über die Hintergründe des Luftangriffs von Kunduz bekommen neue Nahrung. Die geheime Bundeswehr-Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte spielte möglicherweise eine Rolle bei dem endgültigen Befehl zum Abwurf der Bomben.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,666249,00.html
USA
Bush und Blair beschlossen Irak-Invasion schon im April 2002
http://www.focus.de/politik/weitere-meldungen/usa-bush-und-blair-beschlossen-irak-invasion-schon-im-april-2002_aid_459869.html
Weinerliche Rechte?
Von Thorsten Hinz
Die Larmoyanz, welche die deutschen Rechten angeblich pflegen – was ist damit gemeint? Soll das heißen, daß sie die allgemeine Weinerlichkeit in Deutschland (auch „German Angst“ genannt) teilen und folglich keine besseren Menschen sind als die Objekte ihrer Kritik? Oder zielt der Spott auf eine spezifische, eben „rechte“ Larmoyanz-Variante? Diese Spezifik müßte dann aber auch genau definiert werden.
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M5f00bc2087b.0.html
http://www.sezession.de/9471/larmoyanz-und-verwesung.html#more-9471
http://www.sezession.de/9662/deutsche-taeter-deutsche-opfer-eine-antwort-auf-martin-boecker.html
http://www.sezession.de/9891/larmoyanz-und-verwesung-ii.html
Die jungen Männer
Von Götz Kubitschek
Junge Leute haben das Recht zur Rüge, sie haben das Recht zur Attacke, zur Anmaßung, zur Arroganz des Neubeginns. Manchmal holen sie sich dabei eine blutige Nase – oder man versteht ihre Verve nicht ganz: War es nötig, so zu poltern? Qualitätssicherung und Zurückweisung sollte auf dem Felde der Publizistik streng betrieben werden – zumal, wenn es sich um das Netz-Tagebuch der schönsten, besten und wahrsten Rechten handelt.
Warum also darf Martin Böcker, 1981, hier bei uns den Binnenpluralismus bis an die Grenze der Respektlosigkeit strapazieren und unter dem selbstgewählten, übertrieben forschen Titel „Larmoyanz und Verwesung“ zweimal sich selbst und seine Vorsätze mit denen der Normalbürger verwechseln – und uns Jammerei und Defätismus vorwerfen?
http://www.sezession.de/9911/die-jungen-maenner.html
Le Pen
Enkelin strebt in die Politik
http://www.focus.de/politik/ausland/le-pen-enkelin-strebt-in-die-politik_aid_460288.html
Studie
„Verfassungsschutzberichte sind verfassungswidrig“
Fast alle Verfassungsschutzberichte der vergangenen Jahre sind verfassungswidrig. Zu diesem Schluß kommt eine Untersuchung des Freiburger Staatsrechtslehrers Dietrich Murswiek. Mit Ausnahme der Verfassungsschutzberichte Berlins und Brandenburgs genügen demnach alle in den letzten vier Jahren publizierten Verfassungsschutzberichte von Bund und Ländern nicht den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts.
http://www.faz.net/s/Rub594835B672714A1DB1A121534F010EE1/Doc~E710831AE96244C9C94507C2D998A56A6~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_googlenews
Brief an Innenminister
Paulis Stellvertreter fordern Verbot der eigenen Partei
Eine Partei warnt vor sich selbst. Gibt’s nicht? Gibt’s doch. Bei Gabriele Paulis Freier Union. Führende Köpfe wollen nach SPIEGEL-Informationen ein Verbot der eigenen Gruppierung. Die Partei sei verfassungsfeindlich und Pauli habe diktatorische Züge, schrieben sie dem Innenminister. Die Chefin reagierte prompt.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,665356,00.html
Neuer Polizei-Wasserwerfer
Der Naßmacher
Aus St. Augustin berichtet Sven Stillich
400 PS unter der Haube, 10.000 Liter Wasser an Bord und fast eine Million Euro teuer: Die Polizei hat ihre neueste Waffe im Kampf gegen Randalierer vorgestellt. Der „Wasserwerfer 10.000“ ist eine rollende Hightech-Festung, die Beamten sind begeistert.
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,665006,00.html
Finanzkrise
Der Bankrott der Griechen streift auch Deutschland
Von J. Dams, J. Eigendorf u. C. B. Schiltz
Griechenland bedroht die Zukunft der Europäischen Union. Seit Jahren geben die Hellenen weit mehr Geld aus als sie erwirtschaften. Jetzt steht das Land vor dem Staatsbankrott. Wenn die EU mit Milliardenhilfen einspringt, müßte Deutschland als finanzstärkstes Land der EU den Löwenanteil tragen.
http://www.welt.de/politik/Krise/article5479669/Der-Bankrott-der-Griechen-streift-auch-Deutschland.html
Sorge über hohe Schulden Griechenlands
http://www.dw-world.de/dw/function/0,,12356_cid_4997973,00.html
http://www.dw-world.de/dw/function/0,,12356_cid_4995548,00.html?maca=de-de_na-2225-xml-atom
Griechenlands Finanzkatastrophe
Ein Land bekommt die Rechnung
Von Susanne Amann
Alarm in der Euro-Zone: Griechenland ist hoffnungslos verschuldet. Pessimisten sprechen von drohendem Bankrott, die Kreditwürdigkeit verfällt, jetzt beraten die Staats- und Regierungschefs der EU über eine hochbrisante Frage – wie kann man ein abgewirtschaftetes Land zur Selbstsanierung zwingen?
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,666404,00.html
Bankrott und Straßenschlachten
Griechen empfinden den eigenen Staat als Feind
Von Berthold Seewald
Griechenland steht vor dem Ruin, doch die protestierenden Studenten wollen die Verantwortlichen überhaupt nicht zur Rechenschaft ziehen. Sie demonstrieren, weil sie den Staat nicht mehr so ausnehmen können wie die Generationen vor ihnen. Die Gründe der Misere der Griechen liegen in der Geschichte.
http://www.welt.de/politik/article5479779/Griechen-empfinden-den-eigenen-Staat-als-Feind.html
Staatsverschuldung
S&P verwarnt Spanien
http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/anleihen-devisen/:staatsverschuldung-s-p-verwarnt-spanien/50048346.html
ZDF-Magazin „Frontal 21“: Bundesligaclubs verschleiern ihre Schulden
http://www.presseportal.de/pm/7840/1526447/zdf
Niedersächsische Städte sehen sich vor dem Ruin
http://www.welt.de/die-welt/vermischtes/hamburg/article5471867/Niedersaechsische-Staedte-sehen-sich-vor-dem-Ruin.html
Schulden
Bittere Zeiten für den Kreis Offenbach
http://www.op-online.de/nachrichten/frankfurt-rhein-main/bittere-zeiten-kreis-552513.html
Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck, schließt Bündnis mit Linkspartei nicht mehr aus
http://www.op-online.de/nachrichten/politik/beck-schliesst-buendnis-linkspartei-nicht-553164.html
Braune Blätter wollen an den Kiosk
Nicht nur, daß bereits mehrere Zeitungen („Deutsche Stimme“, „National-Zeitung“, „Junge Freiheit“, „Der Schlesier“) und Magazine („Deutsche Geschichte“, „Deutsche Militär-Zeitschrift“, „eigentümlich frei“) im Kiosk-Handel existieren und zusätzlich noch unappetitliche rechtslastige irrationale Periodika („Matrix2000“, „Trojaburg“). Zwei weitere braune Blätter planen den Sprung in den Kiosk-Handel: Die revanchistische „Preußisch Allgemeine Zeitung“ und das neugegründete Monatsmagazin „Zuerst“.
http://de.indymedia.org/2009/12/268189.shtml
[Bln] Nazitreffen im Ratskeller Schmargendorf
Wie der „Tagesspiegel“ am 21.11 berichtete fanden im Ratskeller Schmargendorf im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf seit Jahren regelmäßige, von Neonazis, Rechtskonservativen und neurechten Ideologen besuchte „Dienstagsgespäche“ statt. Organisator der „Gespräche“ war fast immer Hans-Ulrich Pieper.
http://de.indymedia.org/2009/12/268438.shtml
Polizei räumt in Frankfurt Uni-Casino von Chaoten-Studenten
http://www.faz.net/s/RubFAE83B7DDEFD4F2882ED5B3C15AC43E2/Doc~E947C22DF75D74F31AF2BEB06896837E0~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_googlenews
http://www.ad-hoc-news.de/hochschulleitung-frankfurter-studenten-distanzieren-sich--/de/Regional/Hessen/20770704
http://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article1294230/AStA-Sexuelle-und-rassistische-Uebergriffe-durch-Polizisten.html
http://www.rf-news.de/2009/kw49/04.12.09-2013-asta-fordert-ruecktritt-des-frankfurter-uni-praesidenten
http://www.fr-online.de/frankfurt_und_hessen/nachrichten/frankfurt/2119886_Nach-Casinoraeumung-Dozent-spricht-von-bedrohlichem-Auftritt.html
http://www.zeit.de/studium/hochschule/2009-12/schavan-studenten-gewalt-proteste
http://www.faz.net/s/Rub3DFC0DABC5664C30AC70700DD10A965D/Doc~E3FF00FA7CCBD40D78E9E7FE881B7B03C~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_googlenews
„Besetzer beschädigen Casino“
Frankfurter Uni-Präsident rügt Studenten und Land
http://www.faz.net/s/RubFAE83B7DDEFD4F2882ED5B3C15AC43E2/Doc~E3A116DAA275E491CAB05A7EED796B188~ATpl~Ecommon~Scontent.html
Griechenland
Zum Jahrestag der Unruhen erschüttern Straßenschlachten Athen
http://www.welt.de/news/article5446472/Zum-Jahrestag-der-Unruhen-erschuettern-Strassenschlachten-Athen.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/art771,2968757
Wer’s glaubt, wird selig. Was hat Athen mit Hamburg zu tun? Nein, das sind nur Vorwände, für die Medien offiziell vorgetragene Begründungen für die generelle Aggressionslust der „Autonomen“ ...
Bekennerbrief: Hamburger Anschläge Rache für Athen
http://www.zeit.de/newsticker/2009/12/6/iptc-bdt-20091206-293-23210756xml
http://www.news.de/politik/855035501/athen-randale-in-hamburg/1/
Körting kündigt neue Studie zu linksextremistischer Gewalt an
http://www.berlinonline.de/aktuelles/berlin/detail_ddp_2601865810.php
Körting nennt linke Chaoten „rot lackierte Faschisten“
http://www.bz-berlin.de/archiv/koerting-nennt-linke-chaoten-rot-lackierte-faschisten-article667410.html
http://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article1219927/Koerting-spricht-von-rot-lackierten-Faschisten.html
Faschismusvergleich verärgert die Linke
http://www.tagesspiegel.de/berlin/art270,2970657
Die Linke
Partei distanziert sich von linksextremer Gewalt
http://www.focus.de/politik/weitere-meldungen/die-linke-partei-distanziert-sich-von-linksextremer-gewalt_aid_461192.html
Schröder geschichtspolitisch ganz auf Merkel-Linie ...
Altkanzler zum Minarettverbot
Schröder verteidigt den Islam gegen die Schweizer
Jetzt hat der Schweizer Minarett-Streit auch Altkanzler Gerhard Schröder erreicht. Der SPD-Politiker wirft dem Schweizer Volk vor, es wolle den im Kern „friedlichen Islam“ in die Hinterhöfe verbannen. Schröder mahnt, nicht die islamischen Staaten hätten „die beiden Weltkriege“ verbrochen.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5476784/Schroeder-verteidigt-den-Islam-gegen-die-Schweizer.html
Erster Weltkrieg
Deutschland zahlt noch immer Kriegsschulden
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/Deutschland-zahlt-noch-immer-Kriegsschulden_aid_790598.html
Anonym bleibende Besitzer von Anleihen bekommen indes den Rachen nicht voll und klagen vor einem New Yorker Gericht ...
Deutsche Schulden aus dem Weltkrieg
Der lange Schatten von Versailles
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/Der-lange-Schatten-von-Versailles_aid_791008.html
Nach den Kurras-Enthüllungen hoffen die 68er nun, ihr in Unordnung gebrachtes Welt- und Geschichtsbild doch noch retten zu können, in dem die Bundesrepublik als „faschistisches Schweinesystem“ (RAF-Diktion), zumindest jedoch als „faschistoider Staat“ erschien ...
Enthüllung über Dutschke-Attentäter
Schrecken aus dem braunen Sumpf
Von Reinhard Mohr
Schon wieder muß die 68er-Geschichte in neuem Licht gesehen werden: Dutschke-Attentäter Josef Bachmann war kein Einzelgänger, wie lange behauptet. Er hatte nach SPIEGEL-Informationen enge Kontakte zu Neonazis, die von der Stasi beobachtet und der Polizei gedeckt wurden – es gab ihn doch, den braunen Sumpf.
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,665421,00.html
Ein etwas differenzierterer Artikel ...
Der Dutschke-Attentäter und die Neonazis
Von Sven Felix Kellerhoff
Josef Bachmann war offenbar kein Einzeltäter – Laut Stasi-Akten hatte der Mann, der auf den Studentenführer schoß, Kontakte zu Rechtsradikalen
http://www.welt.de/die-welt/politik/article5448661/Der-Dutschke-Attentaeter-und-die-Neonazis.html
Studentenbewegung
Dutschke-Attentäter ein Neonazi?
http://www.focus.de/panorama/vermischtes/studentenbewegung-dutschke-attentaeter-ein-neonazi_aid_460409.html
Dutschke-Attentat
Springers Gewaltfantasien
„Schlagt ihn tot, hängt ihn auf“
http://www.taz.de/1/politik/deutschland/artikel/1/schlagt-ihn-tot-haengt-ihn-auf/
Der Spiegel, 17. Februar 1960 (Fundstücke 6)
Von Martin Lichtmesz
Stefan Scheil hat in einer interessanten Glosse für die JUNGE FREIHEIT an die „Kölner Hakenkreuzschmiereien“ im Dezember 1959 und deren politische Folgen erinnert. Auch Armin Mohler sah in seinem Buch „Der Nasenring“ in diesem Vorfall eine entscheidende Etappe in der Entwicklung der „Vergangenheitsbewältigung“ (VB).
http://www.sezession.de/9760/der-spiegel-17-februar-1960-fundstuecke-6.html
Amoklaufende Gutmenschen
Von Werner Olles
Es war vorauszusehen, daß das klare Votum der Schweizer für ein Verbot von Minaretten ein Wüten und Toben der herrschenden politischen und medialen Klasse hervorrufen würde. Tatsächlich war in den meisten Prognosen eine Ablehnung der von der nationalkonservativen Schweizer Volkspartei (SVP) und der christlich orientierten Eidgenössisch-Demokratischen Union (EDU) initiierten Volksabstimmung vorhergesagt worden, doch entsprach dies wohl eher dem Wunschdenken der elitären Kaste aus Linksintellektuellen und politisch korrekten Multikulturalisten, die anschließend den „sonntäglichen Wahn“ geißelten und die Bürger als „intolerant“ und „fremdenfeindlich“ beschimpften.
http://www.pi-news.net/2009/12/amoklaufende-gutmenschen/#more-104226
Aufklärer, Schönredner und Prediger
Die Islam-Debatte rückt auch die Rolle der Journalisten in den Blickpunkt
http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/medien/aufklaerer_schoenredner_und_prediger_1.4130173.html
Minarett-Verbot belebt Diskussion in Frankreich
http://www.infranken.de/nc/nachrichten/lokales/artikelansicht/article/minarett-verbot-belebt-diskussion-in-frankreich-41321.html
Vural Öger: „Die Schweiz darf uns nicht infizieren“
„Das, was Kamuni Sultan Süleyman 1529 mit der Belagerung Wiens begonnen hat, werden wir über die Einwohner, mit unseren kräftigen Männern und gesunden Frauen, verwirklichen“, sagte Vural Öger (Foto) vor fünf Jahren. Nach der Schweizer Minarett-Abstimmung sieht der türkischstämmige Vorzeige-Unternehmer sein Projekt anscheinend in Gefahr. In einem „Offenen Brief an die Deutschen“ warnt der Nationalist vor „Fremdenhaß der Ewiggestrigen“.
http://www.pi-news.net/2009/12/vural-oeger-die-schweiz-darf-uns-nicht-infizieren/
Kolumne
Liebe Rechtspopulisten!
Von Mely Kiyak
Wenn ich mich heute entscheiden würde, Deutschland zu verlassen, weil ich die hier geschürte Atmosphäre gegen Menschen von nichtdeutschen und nichtchristlichen Eltern nicht gutheiße, ich wüßte nicht wohin. Der Rechtspopulismus hat mich in Europa umzingelt. Dänemark und die Niederlande sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Spanien, Italien, England, es ist ganz gleich, wohin ich schaue, überall sind sie völlig hysterisch mit dem „anderen Kulturkreis“. Scheißminarette. Scheißkirchtürme. Scheißländergrenzen. Scheiß-Alles. Ich habe keine Angst vor Menschen, die an einen Gott glauben. Ich selber habe es nicht so mit Gott, aber egal.
http://www.fr-online.de/top_news/2121843_Kolumne-Liebe-Rechtspopulisten.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Mely_Kiyak
Auch hier kommen wieder einmal nur dreiste Forderungen an die deutsche „Restgesellschaft“ (wie Frau Cindik es in dem Interview so schön ehrlich ausdrückt) ...
„Nur auf Deutsche ausgerichtet“
Gesundheitssystem
Das deutsche Gesundheitssystem ist mit den Anforderungen von Migranten überfordert, beobachtet Psychiaterin Elif Duygu Cindik.
http://www.sueddeutsche.de/wissen/95/495421/text/
Wer ist der Koch?
Von Thorsten Hinz
Eine Integration von Ausländern hat es in Deutschland immer gegeben. Ein Beispiel dafür sind jene beiden Herren, die ihr Ausbleiben zur Zeit am schärfsten kritisieren: Heinz Buschkowsky, Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, und Bundesbankvorstand Thilo Sarrazin. Beider Familiennamen verweisen auf ethnische Anteile, die nicht eben kerndeutschen Ursprungs sind. So war es immer: Leute kamen her (oder gingen weg), weil sie sich anderswo bessere Chancen ausrechneten.
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M5d999bd3488.0.html
Im Maschinenraum kann Frankfurts CDU den Kurs des Tankers „Integration“ gewiß nicht bestimmen
Partei legt zehn Thesen ohne klare Positionierung vor
http://www.freie-waehler-im-roemer.de/index.php?id=44&tx_ttnews%5Btt_news%5D=420&tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&cHash=12281c1398
Sarrazin wirkt
Von Michael Paulwitz
Öffentliche Verkehrsmittel in Großstädten sind eine Universität der rauhen Wirklichkeit. Redakteur Rainer Wehaus von den „Stuttgarter Nachrichten“ ist bodenständig genug, um auch mal die Stadtbahn zu nehmen. Der „Fall Sarrazin“ hat ihn scheint’s ermuntert, die dort gemachten Erfahrungen mit seinen Lesern zu teilen.
http://www.sezession.de/9863/sarrazin-wirkt.html#more-9863
Der Siegerfilm des Videowettbewerbs unter der Schirmherrschaft von Frau Merkel steht nun fest.
Toleranz Team // 361° Toleranz
[Man beachte auch die Kommentare!]
http://www.youtube.com/watch?v=zs6fxy3TZ2M&feature=player_embedded
Eine Antwort auf Merkels 361 Grad – Schluß mit der falschen Toleranz!
http://www.youtube.com/watch?v=IVSZJRzxzJQ
Kriminalität: Die deutsche Opfergesellschaft
„Drohen, dealen und im Zweifel schießen: Tagtäglich fordern ethnisch abgeschottete Clans den Rechtsstaat heraus.“ Diesen Satz schreibt diesmal nicht PI, sondern Spiegel Online in einem Artikel über die organisiert kriminellen türkisch-arabischen Großfamilien in Bremen. In diesem Artikel wird einmal mehr deutlich, wie hilflos eine „kaputtgesparte“ Polizei ohne jeglichen Rückhalt von Politik und Justiz der bestens „Organisierten Kriminalität“ rein gar nichts entgegenzusetzen hat.
http://www.pi-news.net/2009/12/kriminalitaet-die-deutsche-opfergesellschaft/
Berliner Polizist schießt in Notwehr auf Angreifer
Eine Gruppe Jugendlicher hat in der Nacht zu Sonntag einen Berliner Polizisten in Friedrichshain attackiert. Der Mann war nicht in Uniform unterwegs, doch die Angreifer hatten ihn als Polizisten erkannt. In Reaktion auf die Attacke griff der Beamte schließlich zu seiner Waffe.
http://www.morgenpost.de/berlin/article1219119/Berliner-Polizist-schiesst-auf-Angreifer.html
In diesem Artikel findet sich die Information, daß es sich bei dem verletzten Angreifer um einen „Deutsch-Türken“ handelt ...
Gewalt
Friedrichshain: Polizist schießt auf Angreifer
Von Michael Behrendt, Hans H. Nibbrig und Steffen Pletl
Schwerer Zwischenfall bei einem Polizeieinsatz in Friedrichshain. Ein von einer Gruppe Jugendlicher angegriffener Polizist zückte in der Nacht zu gestern die Pistole und schoß einem seiner fünf Angreifer in den Unterschenkel. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der 33jährige Zivilbeamte mit Kollegen am Forckenbeckplatz im Einsatz.
http://www.morgenpost.de/printarchiv/titelseite/article1219306/Friedrichshain-Polizist-schiesst-auf-Angreifer.html
Angriff auf Polizist
Ermittlungen wegen Schießerei in Jugendpark
Nach dem Angriff auf einen Polizisten in Berlin-Friedrichshain wird jetzt gegen zwei junge Männer wegen Körperverletzung ermittelt. Der Beamte, der als Zivilstreife unterwegs war, hatte einem 19jährigen ins Bein geschossen, um den Angriff abzuwehren. Ermittlungen wurden eingeleitet.
http://www.welt.de/vermischtes/article5449705/Ermittlungen-wegen-Schiesserei-in-Jugendpark.html
André Lichtschlag und Helmut Matthies erhalten Gerhard-Löwenthal-Preis
BERLIN. Der Herausgeber der Zeitschrift „eigentümlich frei“, André Lichtschlag, und der Gründer des evangelischen Wochenmagazins „Idea Spektrum“, Helmut Matthies sind am Sonnabend im Beisein von 300 Gästen aus Medien, Wissenschaft und Politik mit dem diesjährigen Gehrhard-Löwenthal-Preis ausgezeichnet worden.
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M5dc742a0551.0.html
Herumdoktern am Bachelor
„Wir haben zwei Studentengenerationen verschlissen“
Professoren haben überall in Deutschland neue Studiengänge erfunden und eingeführt. Jetzt wettert ihr oberster Vertreter gegen die Bachelor-Misere: zu kurz, zu verschult und zu speziell, sagt Bernhard Kempen, Präsident des Hochschulverbandes – und er ruft auf zum Boykott der Bachelor-Bürokratie.
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,665567,00.html
Sascha Lobos Gegenrede zu Schirrmacher ...
Intelligenz
Die bedrohte Elite
von Sascha Lobo
http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,665806,00.html
Humboldt-Forum
Auf dem Weg zum Louvre von Berlin
http://www.faz.net/s/RubCF3AEB154CE64960822FA5429A182360/Doc~E54A073E5B2634F82BAFCCF72D1DA052E~ATpl~Ecommon~Scontent.html
Rekonstruktionsdebatte
Dem Fachwerk eine Gasse
Zum Beispiel Frankfurt am Main: Der Streit um den Wiederaufbau zerstörter Altstadtviertel wird schärfer
http://www.welt.de/die-welt/kultur/article5471482/Dem-Fachwerk-eine-Gasse.html
Spinnereien in einer bankrotten Stadt ...
ARCHITEKTUR: Tegel ist für alles offen
Die Stadtplaner haben viele Ideen dafür, was aus dem Flughafen nach seiner Stilllegung in zwei Jahren einmal werden soll
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11679215/62249/Die-Stadtplaner-haben-viele-Ideen-dafuer-was-aus.html
Aktueller denn je ...
Ausschmitt aus „Ein Mann sieht rot“
Charles Bronson vs. Muggers
http://www.youtube.com/watch?v=of-57Ivfwz8
00:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, allemagne, politique internationale, europe, affaires européennes, politique, médias |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Jünger Wandervogel

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Jünger Wandervogel
Patrick NEUHAUS
Dans bon nombre de publications, Ernst Jünger témoigne de ses ancrages personnels dans le monde d'avant la première guerre mondiale.
Ceux qui connaissent la biographie de Jünger savent que l'adolescent détestait la rationalité, se sentait étranger à elle, tout comme à la quotidienneté du monde de son époque. Il était un rêveur qui ne connaissait rien du monde des autres et n'y cherchait pas son chemin. Cette attitude d'“anarque”, nous ne cessons de la découvrir dans toute l'œuvre d'Ernst Jünger. A la même époque, Franz Kafka ou Thomas Mann affichaient une même distance par rapport au monde de la majorité. Les intérêts du jeune Jünger résident tout entiers dans son monde onirique individuel. Le monde dans lequel évolue l'adolescent Jünger est marqué par tous ces facteurs sociaux qui orientaient la vie de la plupart des fils de la société bourgeoise: une maison parentale reposant sur des fondements solides, une vie quotidienne à l'école obnubilée par les bonnes notes, l'idéal d'une profession stable. C'est dans ce type de monde que le jeune homme de la Belle Epoque devait trouver sa voie. L'écrivain Ernst Jünger sera le contraire de son père, Ernst Jünger sen. (1868-1943). En 1901, le père quitte, avec sa famille, la pittoresque cité de Heidelberg pour émigrer à Hannovre, ensuite à Schwarzenberg dans l'Erzgebirge, enfin à Rehberg: au fil de ces transplantations, le fils Ernst Jünger jun., se détache de plus en plus nettement de la vision du monde positiviste du 19ième siècle. Son père ne réussit qu'à lui communiquer sa passion pour l'entomologie. Mais au-delà de cela, s'est rapidement évanouie l'influence intellectuelle que le père, chimiste et pharmacien doué, exerçait sur son fils épris d'indépendance. Dès l'âge de 13 ans, nait dans le cœur de Jünger un enthousiasme et un émerveillement pour l'agencement des choses dans la nature, pour le sens qu'elles nous communiquent.
Les séjours en pleine nature, la collection de ces petites pierres, de ces petites mosaïques, aux formes diverses, leur agencement en images aux couleurs châtoyantes, les voyages imaginaires du jeune Jünger féru de lectures dans des mondes lointains, aventureux, ont fait en sorte que les journées d'école sont vite apparues fort mornes. Dans Le cœur aventureux, Jünger dépeint ses aspirations avec une indéniable volupté: «Mes parents possédaient une serre... et, souvent, lorsque l'air brûlant frémissait sur le toit de verre, je songeais, avec un plaisir étrange, qu'il ne devait pas faire plus chaud en Afrique. Mais il devait sans doute y faire un peu plus chaud, car c'est ce qui était quasi insupportable, ce qui n'avait jamais encore été vécu, qui était le plus attirant».
Comme des milliers d'autres garçons, Jünger, à seize ans, en 1911, rejoint le Wandervogel. Une des raisons qui l'ont poussé dans les rangs de ce mouvement de jeunesse: le recul de ses résultats scolaires. Comme l'avait déjà constaté Gerhard Ille dans son livre Es begann in Steglitz (Berlin, 1987), le développement du mouvement de jeunesse est étroitement lié à l'augmentation rapide du nombre d'élèves dans les grandes écoles. Le nombre des adhérents du Wandervogel s'est multiplié. Les temps d'apprentissage étaient devenus plus long, le corps des enseignants tendait à s'enfler démesurément et à se bureaucratiser; tout cela contribuait à diminuer sensiblement la qualité de l'enseignement dans les Gymnasia. Pour beaucoup d'élèves, l'école devenait aliénante; elle les préparait à des professions qui n'étaient plus, en dernière instance, que des “fonctions” dans les structures de la société allemande, de plus en plus technologisée et bureaucratisée.
Jünger ne se sentait pas exposé à la pression sociale, qui poussait les jeunes gens à terminer la seconde moitié de leurs humanités afin d'obtenir le droit d'effectuer un service militaire volontaire d'un an seulement (en 1912, Jünger décrochera finalement ce diplôme). Ce type de service militaire prévoyait un temps réduit à une seule année, permettait aux jeunes de gagner du temps et de l'argent et autorisait le volontaire à postuler le statut d'officier de réserve. Mais si le jeune homme ne réussissait pas à atteindre cette position sociale tant briguée, il restait tenaillé par la crainte des examens; s'il ne les passait pas ou s'il n'obtenait pas l'affectation désirée, cela pouvait se terminer en tragédie. Les statistiques de 1883-1888 nous signalent le suicide de 289 élèves, dont 110 dans les grandes écoles. Chez les Wandervögel, qui cultivaient un ressentiment certain à l'égard de la société qu'ils détestaient, ces considérations n'avaient pas leur place. L'officier de réserve issu du Wandervogel envisageait toujours une réforme “par le haut”, et, plus tard, pendant la guerre, il cherchait à promouvoir une réforme globale de la vie dans le corps même des officiers. Ce fut un échec. Mais le scepticisme de ces jeunes officiers à l'égard de l'armée en tant que forme d'organisation, à l'égard de sa technicisation et de sa rationalisation, est demeuré: c'était un scepticisme pour une part plus “progressiste” que celui qui règnait dans d'autres secteurs de la société.
Ernst Jünger, lui, n'a jamais songé au suicide, car il ne prenait pas l'école au sérieux. «Je rêvais sans tenir compte de rien, avec passion... et je me cherchais chaque nouvelle année un nouveau chef droit aux épaules larges, derrière lesquelles je pouvais opportunément me réfugier» (Das abenteuerliche Herz, 1ière version).
La fantaisie juvénile influencée par la lecture de livres d'aventures, comme ceux de Karl May, ou de récits coloniaux ou d'ouvrages de géographie, l'a conduit à rêver à de longs voyages dans des contrées inexplorées. La notion de “communauté” qui, pour d'autres, est la clef de l'aventure, ne constitue pas l'essentiel pour Jünger. A ce moment-là de son existence, comme plus tard, pendant la guerre, elle n'est qu'un moyen pour compléter son univers d'ivresse et de rêves. L'énergie pour l'aventure, Jünger la porte en lui, il n'a pas besoin d'une dynamisation complémentaire, qui lui serait transmise par d'autres. Jünger ne s'est jamais entièrement soumis à un groupe ni n'a adhéré exclusivement à un mouvement précis. C'est ce qui ressort des quelques rares descriptions que nous livre Jünger sur le temps où il était Wandervogel: beuveries vespérales à la manière des étudiants des corporations. Sur les visites hebdomadaires aux brasseries de Hameln, où Jünger était lycéen en 1912, nous avons un récit, publié seulement en 1970 dans Approches, drogues et ivresse: «Les chansons et toute sorte de cérémonies telles que la “salamandre” (1) étaient ordonnées après un silentium préparatoire; un moment de détente, la fidelitas, suivait l'exécution du rituel. On buvait dans des pots à couvercle; parfois aussi un hanap circulait à la ronde. Il avait la forme d'une botte qu'on ne cessait de remplir à nouveau, aux frais de celui qui avait été l'avant-dernier à la tenir. Quand la bière tirait à sa fin, il fallait, ou bien en boire de toutes petites gorgées, ou bien faire “cul sec” d'un trait (...) Il existait toute une série de délits qu'on expiait en vidant une petite ou grande quantité de liquide — ce qu'on appelait “descendre dans le pot”. Souvent des étudiants, ex-membres du club, étaient nos hôtes; ils louaient notre zèle gambrinesque». (note (1): Salamandre: rite qui consiste à frotter trois fois la table en rond du fond de son pot avant de faire “cul sec”).
 Par la suite, Jünger a essayé de traduire en actes ce que d'autre n'évoquaient qu'en paroles. A la recherche de la vie dans sa pureté la plus limpide, avec la volonté de se plonger dans l'ivresse extrême de l'aventure et dans l'émerveillement intense de nouvelles découvertes, de nouvelles couleurs, odeurs et plantes, de nouveaux animaux, Jünger décide de franchir le pas, un pas extraordinairement courageux pour un adolescent, un pas dangereux: à Verdun, en Lorraine, sans avoir averti son père, il s'engage dans la Légion Etrangère française. Un an seulement avant la Grande Guerre, avant même d'avoir passé son “examen de maturité” (ndt: qui correspond plus ou moins au bacchalauréat français), le jeune Jünger amorce une aventure audacieuse, mais qui sera de très courte durée. La même année, au moment où Ernst Jünger part, un revolver dans la poche, pour rejoindre la prestigieuse phalange des professionnels de l'armée française, le mouvement Wandervogel réunit ses adeptes allemands sur une montagne d'Allemagne centrale, le Hoher Meißner. Un Wandervogel autrichien avait appelé les Germains au “Combat contre les Slaves”; les Allemands veulent prendre position et répondent, par la voix de leur porte-parole: «La guerre? Cette manifestation de la folie des hommes, cette destruction de la vie, ce massacre en masse des hommes, faut-il la réactiver de nos jours? Qu'un destin bienveillant, que notre œuvre quotidienne, exécutée en toute fidélité à nos idéaux, nous en préservent!».
Par la suite, Jünger a essayé de traduire en actes ce que d'autre n'évoquaient qu'en paroles. A la recherche de la vie dans sa pureté la plus limpide, avec la volonté de se plonger dans l'ivresse extrême de l'aventure et dans l'émerveillement intense de nouvelles découvertes, de nouvelles couleurs, odeurs et plantes, de nouveaux animaux, Jünger décide de franchir le pas, un pas extraordinairement courageux pour un adolescent, un pas dangereux: à Verdun, en Lorraine, sans avoir averti son père, il s'engage dans la Légion Etrangère française. Un an seulement avant la Grande Guerre, avant même d'avoir passé son “examen de maturité” (ndt: qui correspond plus ou moins au bacchalauréat français), le jeune Jünger amorce une aventure audacieuse, mais qui sera de très courte durée. La même année, au moment où Ernst Jünger part, un revolver dans la poche, pour rejoindre la prestigieuse phalange des professionnels de l'armée française, le mouvement Wandervogel réunit ses adeptes allemands sur une montagne d'Allemagne centrale, le Hoher Meißner. Un Wandervogel autrichien avait appelé les Germains au “Combat contre les Slaves”; les Allemands veulent prendre position et répondent, par la voix de leur porte-parole: «La guerre? Cette manifestation de la folie des hommes, cette destruction de la vie, ce massacre en masse des hommes, faut-il la réactiver de nos jours? Qu'un destin bienveillant, que notre œuvre quotidienne, exécutée en toute fidélité à nos idéaux, nous en préservent!».
Cette attitude pacifiste a été celle de la majorité dans le mouvement de jeunesse bourgeois avant le déclenchement de la Grande Guerre. La volonté d'action de Jünger, d'une parfaite cohérence, ne pouvait pas se concrétiser dans sa patrie. Son départ pour la Légion fit la une dans les quotidiens de sa région. Par voies diplomatiques, le père de Jünger obtient assez rapidement le rapatriement de son fils fugueur, qui se trouvait déjà en Afrique. Détail intéressant: le père lui ordonne par télégramme de ne pas revenir sans s'être laissé photographier en uniforme de légionnaire.
Jünger eut en Afrique des expériences plutôt dégrisantes. Il nous décrit par exemple comment il a été cueilli par des policiers militaires français, peu après son arrivée au Maroc, et exposé à la risée des indigènes. Les chambres sont pareilles à celles des détenus. Dès ce moment, l'aventure africaine laissait à désirer. Mais son livre Jeux africains demeure un récit légendaire, qui ne cesse de captiver ses lecteurs. En 1939, le Meyers Lexikon, pourtant fidèle à la ligne imposée par le régime, fait tout de même l'éloge de ce texte: Jünger, écrit le rédacteur, prouve avec ce livre «qu'il est doué d'une grande capacité poétique à décrire et à contempler», surtout «après avoir approché dangereusement un retournement, celui qui mène du réalisme héroïque au nihilisme sans espoir».
Après avoir passé un Abitur accéléré, Jünger se porte volontaire dès le début de la guerre. Sa jeunesse était définitivement passée. Le monde obsolète de sa ville natale, endormi et médiéval, moisi et vermoulu, il l'abandonnait définitivement. Il appartiendra désormais au petit nombre de ceux qui abandonnent le romantisme sans une plainte, pour adopter le pas cadencé, pour troquer le béret de velour des Wandervögel pour le casque d'acier de l'armée impériale. Numquam retrorsum, semper prorsum!
Patrick NEUHAUS.
(article extrait de Junge Freiheit, n°12/95; trad. franç.: Robert Steuckers).
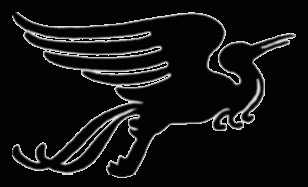
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, ernst jünger, mouvements de jeunesse, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 17 décembre 2009
Botho Strauss ist 65
 Botho Strauß ist 65
Botho Strauß ist 65
von Thorsten Hinz
Von Botho Strauß, der heute fünfundsechzig wird, ist ein neues Buch erschienen: Vom Aufenthalt enthält Szenen, die ein Selbstbild des Autors nahelegen. Im ersten Abschnitt ist von einem Mann die Rede, der nach vielen Jahren aus der Fremde heimkehrt, die Reise aber unterbrechen muß, weil in seinem Land ein Putsch stattgefunden hat und die Grenzen geschlossen sind. Nun hockt er im Wartesaal des Grenzbahnhofs.
Die wenigen Mitreisenden sind zu jung, als daß er sie kennen oder von ihnen gekannt werden könnte. »Das ist dann der Aufenthalt, er könnte länger dauern.« Eine andere Passage handelt vom Botschafter eines vergessenen Landes, den niemand mehr einlädt und der Verklärungen über den versunkenen, zum Fabelreich gewordenen Staat verfaßt. »Er bleibt auf seinem Posten, der letzte der Vereinzelung. Nach ihm nur noch: die Minderheiten.«
Die Eigenarten des Denkens, der Poetik und der öffentlichen Position des Botho Strauß sind damit angedeutet: die Vorliebe für die Parabel; das Wissen um den verlorenen Posten, das die Wahrnehmung um so luzider macht; die dialektische Aufhebung einer Gesellschaftskritik, die institutionalisiert und dogmatisch geworden ist und trotzdem auf ihrem vermeintlichen kritischen Potential beharrt; das Vertrauen in den abgesonderten Einzelnen und parallel dazu die Distanz zur ausdifferenzierten Gesellschaft, die im Lobgesang auf die Minderheiten sich selber feiert. Denn deren Bedeutung erschöpft sich längst in der Perfektionierung der Interessenvertretung, der Subventionsjagd, des Gruppendrucks.
Geschichtliche und deutschlandpolitische Dimensionen eröffnen sich, wenn Strauß zweihundert Seiten später über das Gros der DDR-Autoren schreibt: »Vergeblicher Streit um ein vergebliches Land. Ärmelschoner-Existenz, geistig gesehen. Gleichwohl: Welch ein Aufenthalt. Welch eine Versammlung wider die Zeit! Welch ein Dilatorium!« Die Präzisierung des »Aufenthalts« als »Aufschub« gilt auch rückwirkend, und der Befund, in einer gestundeten Zeit zu leben, somit für den Westen. Die im Kalten Krieg feindlich verbundenen Systeme waren zwei Formen des Nachkriegsinterregnums im geschichtlichen Niemandsland. Als die DDR ohne es zu wissen in den letzten Zügen lag, geriet Volker Brauns Drama Die Übergangsgesellschaft zum Triumph. Die andere Übergangsgesellschaft, das Generalthema von Strauß, dauert an.
Wer aus solcher Perspektive auf die Gegenwart blickt, zieht Befremdung und Vereinsamung auf sich. Immerhin ist die Eingangsszene des Aufenthalts nicht ganz ohne Hoffnung. Die Möglichkeit bleibt offen, daß die jungen Mitreisenden – »die vielleicht aus seinem Geburtsort stammen« – eines Tages in ihm jenen Einzelnen erkennen und schätzen werden, der die Sezession gewagt hat. Sezession bedeutet hier: Strauß zählt zu den wenigen Intellektuellen, die als Kinder der Bundesrepublik auf- und souverän über sie hinausgewachsen sind.
Das Geburtsjahr 1944 stellt ihn in die Generation der 68er. Das Studium der Soziologie, Germanistik, Theatergeschichte, der Studienabbruch, die Arbeit bei der Zeitschrift Theater heute passen in den Rahmen. Peter Steins legendäre Schaubühne in Berlin, wo Strauß seit 1970 als Dramaturg wirkte, war ursprünglich ebenfalls von der 68er-Bewegung inspiriert. Durch die Mitsprache der künstlerischen Mitarbeiter bei der Stückauswahl und Spielplanpolitik sollte eine Alternative zum herkömmlichen Stadttheater entstehen. Politische Akzente wurden mit Enzensbergers Verhör von Habana oder mit dem Revolutionsstück Optimistische Tragödie von Wsewolod Wischnewski gesetzt. Das heißt: Der »Dichter der Gegen-Aufklärung« (Michael Wiesberg) kennt das soziale Biotop, die Denkstrukturen und Funktionsweise der bundesdeutschen Aufklärer-Szene aus eigener, intimer Anschauung.
Das Personal seiner Dramen, Romane, tagebuchartigen Reflexionen und Betrachtungen sind Intellektuelle, Akademiker, Künstler und Studenten, die ihre Komplexe, Reizbarkeiten, Gesinnungen ausleben. In ihrer Beschränktheit können sie nicht anders, als selbst Viscontis geniale »Leopard«-Verfilmung »an ihrem eigenen herunterdemokratisierten, formlosen Gesellschaftsbewußtsein (zu) messen. Dabei spürt man zugleich, wie wenig noch an Kraft, Zorn, Richtung hinter solchen Entwürfen steckt.« (Paare, Passanten, 1981) Im Bühnenstück Trilogie des Wiedersehens (1977) werden die entsprechenden Figuren durch Oxymora bezeichnet: »Wißbegierig gleichgültig, erstaunt erschöpft, nachdenklich dumm.« Letzte Menschen halt. Die Kritik an der Gesellschaft steigert sich von Werk zu Werk bis zum Bewußtsein ihrer Ausweg- und Zukunftslosigkeit. Im Bühnenstück Die eine und die andere (2004) trägt das Juste milieu mittlerweile Kompressionsstrümpfe, zeigt seine Wunden vor, ohne sie zu begreifen. Die Tochter der »einen« läßt sich in Kunstaktionen verwunden, um in der Zombiewelt überhaupt mal etwas zu spüren. In magischen Momenten verwandelt ihre Kunst sich in eine mythische Figur, die aus tieferen Sphären schöpft. Ihr Name: Elaine, ein Anagramm aus »Alien«. Soll heißen: Die Erlösung muß von anderswoher kommen!
Folgerichtig widmete sich Strauß verstärkt der Essayistik. Im Nachwort zu George Steiners Von realer Gegenwart (1990) deutete er den Zusammenbruch des Kommunismus als »die negative Offenbarung einer verfehlten, weltlichen Soteriologie: Alles falsch von Anbeginn!«, und er vermutete, daß die Konkurrenzlosigkeit der westlichen Welt »sich in Zukunft gegen ihr eigenes Prinzip« wenden würde.
Im Februar 1993 veröffentlichte der Spiegel den Anschwellenden Bocksgesang. Im ersten Satz gesteht Strauß seine Bewunderung für die Komplexität der »freien Gesellschaft«, um dann ihre – vielleicht letale – Systemkrise zu diagnostizieren. Als größte der inneren Gefahren erscheint die Schrumpfung des westlichen »Menschen« zum aufgeklärten, den Massenwohlstand voraussetzenden »Staatsbürger«, der ohne kulturelle und religiöse Fernerinnerung dahindämmert. Dem amputierten Geschichtsbewußtsein entspricht seine geschrumpfte Vorstellung künftiger Möglichkeiten. Sie schließt den Ernstfall aus und erschöpft sich in Sozialtechnik. Bis hierher war die Argumentation für die Öffentlichkeit noch tolerabel. Mit dem Vorwurf aber, ein »immer rücksichtsloserer« Liberalismus verhöhne und demontiere das »Eigene« – Eros, Soldatentum, Kirche, Autorität, Tradition –, überschritt der Dichter eine Frontlinie, desgleichen mit der Frage, woraus denn die »freie Gesellschaft« im Konflikt mit dem »Fremden« ihre Kraft zur Selbstbehauptung noch schöpfen wolle.
Mit dem Angriff auf die »Totalherrschaft der Gegenwart« schrieb er Novalis’ Kritik am »modernen Unglauben« fort. Dessen Anhänger, so der Frühromantiker, seien unablässig damit beschäftigt, »die Natur, den Erdboden, die menschlichen Seelen und die Wissenschaften von der Poesie zu säubern, – jede Spur des Heiligen zu vertilgen, das Andenken an alle erhebenden Vorfälle und Menschen durch Sarkasmen zu verleiden« und »die Zuflucht zur Geschichte abzuschneiden«.
Der Vorwurf der Moderne- und Geistfeindlichkeit, der deswegen gegen Stauß vorgebracht wird, läßt sich leicht mit Adornos und Horkheimers Feststellung widerlegen, daß der Mythos, gegen den die Aufklärer angehen, ja bereits ein Stück Aufklärung darstellt. Eine mechanisierte Aufklärung ist also »totalitär«, denn je weiter durch sie »die magische Illusion entschwindet, um so unerbittlicher hält Wiederholung unter dem Titel Gesetzlichkeit den Menschen in jenem Kreislauf fest, durch dessen Vergegenständlichung im Naturgesetz er sich als freies Subjekt gesichert wähnt«. Im Grunde zieht Strauß die Konsequenz aus der Dialektik der Aufklärung, wenn er schreibt: »Der Reaktionär ist eben nicht der Aufhalter oder unverbesserlicher Rückschrittler, zu dem ihn die politische Denunziation macht – er schreitet im Gegenteil voran, wenn es darum geht, etwas Vergessenes wieder in die Erinnerung zu bringen.«
Während noch die Fukuyma-These vom Ende der Geschichte diskutiert wurde, die der westliche Sieg im Kalten Krieg markiere, konstatierte Strauß angesichts der massenhaften Armutswanderung nach Deutschland: »Da die Geschichte nicht aufgehört hat, ihre tragischen Dispositionen zu treffen, kann niemand voraussehen, ob unsere Gewaltlosigkeit den Krieg nicht bloß auf unsere Kinder verschleppt.« Die Tumulte vor Asylantenheimen und die in Brand gesetzten Wohnstätten muslimischer Ausländer, für die man Neonazis verantwortlich machte, seien der »Terror des Vorgefühls«. Das emblematisch hochgehaltene »Deutsche« sei die Chiffre für die »weltgeschichtliche Turbulenz, den sphärischen Druck von Machtlosigkeit«, für »Tabuverletzung und Emanzipation in später Abfolge und unter umgekehrten Vorzeichen«, mithin ein Reflex auf den indoktrinierten »Vaterhaß« und den »libertären bis psychopathischen Antifaschismus«. Gegen die Medien, die von »gut schreiben könnenden Analphabeten« beherrscht würden, insistierte er, »daß die magischen Orte der Absonderung, daß ein versprengtes Häuflein von inspirierten Nichteinverstandenen für den Erhalt des allgemeinen Verständigungssystems unerläßlich ist«.
Der Aufsatz löste einen Mediensturm aus, der sich noch steigerte, als er 1994 in den Sammelband Die selbstbewußte Nation aufgenommen wurde, den konservative Publizisten, Historiker und Journalisten veröffentlichten. Der Soziologe Stefan Breuer, der sich mit der Konservativen Revolution beschäftigte, sah Botho Strauß durch »verzerrende Effekte eines gestörten und dadurch pathogenen Narzißmus«, durch »quasireligiöse und sektenförmige Züge« bestimmt. Der Spiegel setzte über ein Foto des Schriftstellers die suggestive Überschrift »Lehrmeister des Hasses«, ohne allerdings im Text auf die Totschlagzeile zurückzukommen. Im medialen Aufruhr spiegelten sich die historischen, politischen, geistig-kulturellen Besonderheiten der Bundesrepublik wider, die am auffälligsten und lautesten von einem Intellektuellen- und Schriftstellertypus repräsentiert werden, der ab Ende der fünfziger Jahre dominierte und – zumindestens institutionell – bis heute dominiert.
Für Walter Jens, der als Schriftsteller, Kritiker, Literaturprofessor, Mitglied der »Gruppe 47« und Akademiepräsident über großen Einfluß im Kulturbetrieb verfügte, war als Intellektueller nur einer denkbar, der sich in die Traditionen der Aufklärung und der Französischen Revolution stellte. Als Prototypen machte er Heinrich Heine sowie Rosa Luxemburg, Heinrich Mann und Carl von Ossietzky namhaft. Auf Heinrich Heine bezog sich auch Jürgen Habermas. Diesen habe an den Frühromantikern das soziale Protestpotential interessiert, Kunst und Wissenschaft seien für ihn autonom, aber nicht esoterisch gewesen; daher habe er keine Scheu gehabt, gezielt in die politische Willensbildung einzugreifen. Erst in der Bundesrepublik habe sein intellektuelles Selbstverständnis sich durchsetzen können, weil »1945« eine »geschichtliche Distanz« erzwungen und ein »reflexiv gebrochenes Verhältnis zu den identitätsbildenden Überlieferungen und geistigen Formationen« mit sich gebracht habe. Während Heines Zeitgenossen noch ein emphatisches Verhältnis zur deutschen Nation pflegten, erkannte der jüdische Emigrant aus der Distanz seines Pariser Exils »das Monströse und das Unheimliche«, das »auch in unseren besten, den unverlierbaren Traditionen« brütete. – Schärfer konnte die Frontstellung gegen das »Eigene«, auf das Strauß sich berief, nicht sein.
Laut Arnold Gehlen betrieben Intellektuelle vom Zuschnitt Heines lediglich die radikale gesinnungsethische Zuspitzung der Politik, um sie nach den Maßstäben der Familienmoral neu zu erfinden. Das Individuum unmittelbar zur Menschheit in Beziehung zu setzen und die Staatsnation als Zwischeninstanz auszuschalten, bedeutete die Zerstörung des politischen Denkens, wie sie nur in definitiv besiegten Ländern möglich war. Die Links-Intellektuellen betrieben demnach die Inversion, Ästhetisierung und geschichtsphilosophische Überhöhung der deutschen Grundtatsache nach dem Zweiten Weltkrieg – durchaus im Einverständnis mit der Mehrheit der Bürger. Denn diese fühlten eine schwere politische Verantwortung von ihren Schultern genommen, zweitens war der politische Dispens mit Massenwohlstand verbunden. Von den gebrochenen Autoritäten des Staates gab es kaum Gegenwehr, die antifaschistisch aufgeladene Kritik an ihnen blieb gefahrlos und verhieß gesellschaftlichen und sozialen Aufstieg. Und wenn den Künstlern und Intellektuellen dabei die »hochsensible, differenzierte Kultiviertheit, wie sie bei Proust oder Musil vorgeführt wurde« (A. Gehlen), abhanden kam, konnte dies sogar zur kulturrevolutionären und antielitären Emanzipation umgewertet werden.
Helmut Schelsky fügte hinzu, die Intellektuellen seien in die Funktion von »Sinnproduzenten« gerückt, die mit einer Synthese aus Soziologie, Psychologie und Wissenstheorie und dank ihrer Monopolstellung im Bildungs-, Öffentlichkeits- und Informationsbetrieb eine »Priesterherrschaft« errichtet hätten, um der Gesellschaft einen theologischen Weg vom »Seelenheil zum Sozialheil« zu weisen. Diese neuen Priester mußten sich von Strauß bloßgestellt und in Frage gestellt fühlen: »Es ziehen aber Konflikte herauf, die sich nicht mehr ökonomisch befrieden lassen; bei denen es eine nachteilige Rolle spielen könnte, daß der reiche Westeuropäer sozusagen auch sittlich über seine Verhältnisse gelebt hat, da hier das Machbare am wenigsten an eine Grenze stieß.«
Strauß hat keinen der Befunde zurückgenommen, sondern sie verschärft. Zum 11. September 2001 schrieb er: »Die Blindheit der Glaubenskrieger und die metaphysische Blindheit der westlichen Intelligenz scheinen einander auf verhängnisvolle Weise zu bedingen.« 2006 reflektierte er im Aufsatz »Der Konflikt« offen über eine Zukunft, in der die christlichen Autochthonen bzw. ihre säkularisierten Nachfahren in Europa nur noch eine Minderheit bildeten, was von den Intellektuellen in ihrer »aufrichtigen Verwirrung« gar nicht begriffen würde. Die »Parallelgesellschaften« konstituierten in Wahrheit eine »Vorbereitungsgesellschaft«. Als Aufforderung an die Europäer nämlich, sich auf vorstaatliche und -gesellschaftliche Gemeinschaftlichkeit und auf europäische Tugenden: Differenzierungs- und Reflexionsvermögen, an Kunst geschultem Schönheitsverlangen, Sensibilität, zu besinnen und ihnen in der »geistlosen« Gegenwart des Westens neue Geltung zu verschaffen. Er sieht uns in eine Entscheidungssituation gestellt. Die Zeit der »neuen Unübersichtlichkeit« (Jürgen Habermas) sei jedenfalls zu Ende: »Wir haben sie hinter uns. Es war eine schwache Zeit.« Wie kein anderer hat Botho Strauß die Innenseite dieser Schwäche beschrieben.
Article printed from Sezession im Netz: http://www.sezession.de
URL to article: http://www.sezession.de/9571/botho-strauss-ist-65.html
URLs in this post:
[1] pdf der Druckfassung: http://www.sezession.de/wp-content/uploads/2009/12/Sez33-Strauß.pdf
[2] Image: http://www.sezession.de/wp-content/uploads/2009/12/bothostrauß.jpg
00:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, littérature allemande, lettres allemandes, lettres, littérature |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Ernst Jünger face à la NSDAP (1925-1934)
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
 Ernst Jünger face à la NSDAP (1925-1934)
Ernst Jünger face à la NSDAP (1925-1934)
Werner BRÄUNINGER
«Nous souhaitons du fond de notre cœur la victoire du national-socialisme, nous connaissons le meilleur de ses forces, l'enthousiasme qui le porte, nous connaissons le sublime des sacrifices qui lui sont consentis au-delà de toute forme de doute. Mais nous savons aussi, qu'il ne pourra se frayer un chemin en combattant... que s'il renonce à tout apport résiduaire issu d'un passé révolu» (1).
Ces phrases, Ernst Jünger les a écrites pendant l'été 1930. Pourquoi, se demande-t-on aujourd'hui, Jünger n'a-t-il pas trouvé la voie en adhérant au mouvement de cet homme, apparamment capable de transposer et d'imposer les idées de Jünger et du «nouveau nationalisme» dans la réalité du pouvoir et de la politique? Mon propos, ci-après, n'a pas la prétension d'être une analyse méticuleuse, profonde, systématique de l'histoire des idées. Il ne vise qu'à montrer comment une personnalité individuelle et charismastique de la trempe d'Ernst Jünger, qui a fêté ses 100 ans en mars dernier, a pu maintenir son originalité à l'ère du Kampfzeit de la NSDAP.
1. Ernst Jünger et Adolf Hitler
Le jugement posé par Jünger sur Hitler a varié au cours des années: «Cet homme a raison», puis «Cet homme est ridicule» ou «Cet homme est inquiétant» ou «sinistre» (2). En 1925, Jünger pensait encore que la figure de Hitler éveillait indubitablement, tout comme celle de Mussolini, «le pressentiment d'un nouveau type de chef» (3). La description par Jünger d'un discours du jeune Hitler nous communique très nettement ce “fluide”: «Je connaissais à peine son nom, lorsque je l'ai vu dans un cirque de Munich où il prononçait l'un de ses premiers discours... A cette époque, j'ai été saisi par quelque chose de différent, comme si je subissais une purification. Nos efforts incommensurables, pendant quatre années de guerre, n'avaient pas seulement conduit à la défaite, mais à l'humiliation. Le pays désarmé était encerclé par des voisins dangereux et armés jusqu'aux dents, il était morcelé, traversé par des corridors, pillé, pompé. C'était une vision sinistre, une vision d'horreur. Et voilà qu'un inconnu se dressait et nous disait ce qu'il fallait dire, et tous sentaient qu'il avait raison. Il disait ce que le gouvernement aurait dû dire, non pas littéralement, mais en esprit, dans l'attitude, ou aurait dû faire tacitement. Il voyait le gouffre qui se creusait entre le gouvernement et le peuple. Il voulait combler ce fossé. Et ce n'était pas un discours qu'il prononçait. Il incarnait une manifestation de l'élémentaire, et je venais d'être emporté par elle» (4).
Après que Jünger ait reçu de Hitler un exemplaire de son livre autobiographique et programmatique, le fameux Mein Kampf, Jünger lui a expédié tous ses livres de guerre. L'un de ces exemplaires d'hommage, plus précisément Feuer und Blut, contient une dédicace datée du 9 janvier 1926: «A Adolf Hitler, Führer de la Nation! - Ernst Jünger». Plus tard, la même année, Hitler annonce sa visite chez Jünger à Leipzig; celle-ci n'a toutefois pas eu lieu, à cause d'une modification d'itinéraire. Plus tard, Jünger écrit, à propos de cet événement: «Cette visite se serait sans doute déroulée sans résultat, tout comme ma rencontre avec Ludendorff. Mais elle aurait certainement apporté le malheur» (5). En 1927, Hitler lui aurait offert un mandat de député NSDAP au Reichstag. Jünger a refusé. Il considérait que l'écriture d'un seul vers avait davantage d'intérêt que la représentation de 60.000 imbéciles au Parlement.
Les relations entre les deux hommes se sont nettement rafraîchies par la suite, surtout après que Hitler ait prêté le “serment de légalité” en octobre 1930 devant la Cour du Reich à Leipzig: «Je prête ici le serment devant Dieu Tout-Puissant. Je vous dis que lorsque je serai arrivé légalement au pouvoir, je créerai des tribunaux d'Etat sous le houlette d'un gouvernement légal, afin que soient jugés selon les lois les responsables du malheur de notre peuple». A cela s'ajoute que Jünger et Hitler ne jugeaient pas de la même façon la question des attentats à la bombe perpétrés par le mouvement paysan du Landvolk dans le Schleswig-Holstein.
Jünger critiquait Hitler et son mouvement parce qu'ils étaient trop peu radicaux; au bout de quelques années, l'écrivain jugeait finalement le condottiere politique comme un «Napoléon du suffrage universel» (6). Pourtant, ils restaient tous deux d'accord sur l'objectif final: le combat inconditionnel contre le Diktat de Versailles et aussi contre la décadence libérale, ce qui impliquait la destruction du système de Weimar.
Jünger: «Nous nous sommes mobilisés de la façon la plus extrême dans cette grande et glorieuse guerre pour défendre les droits de la Nation, nous nous sentons aujourd'hui aussi appelés à combattre pour elle. Tout camarade de combat est le bienvenu. Nous constituons une unité de sang, d'esprit et de mémoire, nous sommes “l'Etat dans l'Etat”, la phalange d'assaut, autour de laquelle la masse devra serrer les rangs. Nous n'aimons pas les longs discours, une nouvelle centurie qui se forge nous apparait plus importante qu'une victoire au Parlement. De temps à autre, nous organisons des fêtes, afin de laisser le pouvoir parader en rangs serrés, et pour ne pas oublier comment on fait se mouvoir les masses. Des centaines de milliers de personnes viennent d'ores et déjà participer à ses fêtes. Le jour où l'Etat parlementaire s'écroulera sous notre pression et où nous proclamerons la dictature nationale, sera notre plus beau jour de fête» (7). Mais quand un parti national a réellement pris le pouvoir et renverser le système de Weimar, Jünger s'est arrogé le droit de dire oui ou non au cas par cas, face à ce qui se déroulait en face de lui.
En 1982, Jünger répond à une question qui lui demandait ce qu'il reprochait réellement à Hitler: «Son attitude résolument contraire au droit après 1938. Je suis encore pleinement d'accord avec Hitler pour sa politique dans les Sudètes et pour son Anschluß de l'Autriche. Mais j'ai reconnu bien vite le caractère de Hitler...» (8). Le souci de Jünger était le salut du Reich et non pas le sort d'une personne. Un an après l'effondrement du national-socialisme, il écrit: «... Peu d'hommes dans les temps modernes n'ont suscité autant d'enthousiasme auprès des masses, mais aussi autant de haine que lui. Quand j'ai entendu la nouvelle de son suicide, un poids m'est tombé du cœur; parfois j'ai craint qu'il ne soit exposé dans une cage dans une grande ville étrangère. Cela, au moins, il nous l'a épargné» (9).
2. Le «nouveau nationalisme»
Favorisé par ses hautes décorations militaires, gagnées lors de la première guerre mondiale, ainsi que par la notoriété de ses livres de guerre, Jünger est devenu la figure sympbolique du «nouveau nationalisme». Autour de ce concept, se sont rassemblés entre 1926 et 1931 quelques revues, dans lesquelles Jünger non seulement écrit de nombreux articles, mais dont il est le co-éditeur. Ces revues s'appellent Standarte, Arminius, Der Vormarsch et Die Kommenden. Les autres éditeurs étaient Franz Schauwecker, Helmut Franke, Wilhelm Weiss, Werner Lass, Karl O. Paetel, etc. Parmi les autres auteurs de ces publications, citons, par exemple, Ernst von Salomon, Friedrich Hielscher, Friedrich Wilhelm Heinz, Hanns Johst, Joseph Goebbels, Konstantin Hierl, Ernst von Reventlow, Alfred Rosenberg et Werner Best. Au cours de ces dernières années de la République de Weimar, il est typique de noter que ces “Rebelles”, situés entre l'extrême-droite et l'extrême-gauche, se sont rencontrés en permanence avec des “Communards” officiels ou oppositionnels, ou avec des nationaux-socialistes fidèles ou hostiles au parti. Parmi ces cercles obscurs de débats, il y avait la «Gesellschaft zum Studium der russischen Planwirtschaft» (= Société pour l'étude de l'économie planifiée russe). On espérait là surtout apprendre l'opinion d'Ernst Jünger.
 Il est intéressant de connaître le destin ultérieur de ces hommes qui entouraient alors Ernst Jünger et qui étaient les principaux protagonistes des fondements théoriques de ce «nouveau nationalisme»: Helmut Franke est tombé au combat, en commandant une cannonière sud-américaine; Wilhelm Weiss a été promu chef de service dans la rédaction du Völkischer Beobachter et, plus tard encore, chef de l'Association nationale de la presse allemande; Karl O. Paetel a préféré émigrer; Friedrich Wilhelm Heinz est devenu Commandeur du Régiment “Brandenburg”, auquel était notamment dévolu la garde de la Chancelerie du Reich; et le Dr. Werner Best est devenu officiellement, de 1942 à 1945, le ministre plénipotentiaire du Reich national-socialiste au Danemark, après avoir occupé de hautes fonctions au Reichssicherheitshauptamt. On s'étonne aujourd'hui de constater comme étaient variés et différents les caractères et les types humains de ces idéologues du «nouveau nationalisme». Tous étaient unis par un sentiment existentiel, celui du “réalisme héroïque”, terme qu'a utilisé maintes fois Ernst Jünger pour définir l'attitude fondamentale de sa vision du monde (10). De fait, une telle attitude se retrouve chez la plupart des théoriciens de cette époque, y compris, par exemple, chez un Oswald Spengler (Preußentum und Sozialismus, Der Neubau des Deutschen Reiches), Arthur Moeller van den Bruck (Das Dritte Reich) et Edgar Julius Jung (Die Herrschaft der Minderwertigen).
Il est intéressant de connaître le destin ultérieur de ces hommes qui entouraient alors Ernst Jünger et qui étaient les principaux protagonistes des fondements théoriques de ce «nouveau nationalisme»: Helmut Franke est tombé au combat, en commandant une cannonière sud-américaine; Wilhelm Weiss a été promu chef de service dans la rédaction du Völkischer Beobachter et, plus tard encore, chef de l'Association nationale de la presse allemande; Karl O. Paetel a préféré émigrer; Friedrich Wilhelm Heinz est devenu Commandeur du Régiment “Brandenburg”, auquel était notamment dévolu la garde de la Chancelerie du Reich; et le Dr. Werner Best est devenu officiellement, de 1942 à 1945, le ministre plénipotentiaire du Reich national-socialiste au Danemark, après avoir occupé de hautes fonctions au Reichssicherheitshauptamt. On s'étonne aujourd'hui de constater comme étaient variés et différents les caractères et les types humains de ces idéologues du «nouveau nationalisme». Tous étaient unis par un sentiment existentiel, celui du “réalisme héroïque”, terme qu'a utilisé maintes fois Ernst Jünger pour définir l'attitude fondamentale de sa vision du monde (10). De fait, une telle attitude se retrouve chez la plupart des théoriciens de cette époque, y compris, par exemple, chez un Oswald Spengler (Preußentum und Sozialismus, Der Neubau des Deutschen Reiches), Arthur Moeller van den Bruck (Das Dritte Reich) et Edgar Julius Jung (Die Herrschaft der Minderwertigen).
Jünger voulait se joindre à cette phalange olympienne en publiant à son tour une sorte d'“ouvrage standard”. Dans la publicité d'un éditeur, on découvre l'annonce d'un livre de Jünger qui se serait intitulé Die Grundlage des Nationalismus, mais qui n'est jamais paru. Si le livre avait été imprimé, il serait aujourd'hui sans nul doute la source par excellence. L'ouvrage aurait aussi dû comporter un essai intitulé «Nationalismus und Nationalsozialismus», qui n'est paru qu'en 1927 dans la revue Arminius. Le comble dans cet essai, c'est la proposition de faire du national-socialisme un instrument de l'action politique pratique («dans le mouvement de Hitler se trouve plus de feu et de sang que la soi-disant révolution a été capable de susciter au cours de toutes ses années»), et de faire du nationalisme, que Jünger réclamait pour lui, le laboratoire idéologique. Dès 1925, Jünger exhortait dans son appel «Schließt euch zusammen!» (Resserrez les rangs!), les groupes rivaux à former un «Front nationaliste final» (11). Mais ce front n'a jamais vu le jour, «l'appel est resté sans écho, s'est évanoui dans les discours mesquins des secrétaires d'association qui voulaient absolument avoir le dernier mot» (Karl O. Paetel).
Au fur et à mesure que son aversion contre la démocratie grandissait, son refus de Hitler augmentait aussi. Tandis que ces hérétiques développaient entre eux un grand nombre de «thèses spéciales sur le nationalisme», tant et si bien qu'aucune unité réelle ne pouvait émerger, la NSDAP de Hitler courait de victoire électorale en victoire électorale. En formulant et en fignolant leurs spéculations, beaucoup d'intellectuels du «nouveau nationalisme» avaient vraiment perdu le contact avec les réalités. Ernst von Salomon décrit les faiblesses du nationalisme théorique de façon fort colorée dans son Questionnaire: «... On n'insistera jamais assez pour dire que les émotions intellectuelles de ces hommes combattifs appartenant au “nouveau nationalisme” se sont évanouies en silence. Outre le nombre ridiculement faible d'abonnés à ces quelques revues, personne ne les remarquait, et nous atteignions un degré élevé d'excitation, quand, par hasard, un grand quotidien de la capitale, évoquait en quelques lignes l'une ou l'autre production de l'un d'entre nous» (12).
3. Le Dr. Goebbels
Les rapports entre Jünger et le Dr. Joseph Goebbels méritent un chapitre particulier. Les deux hommes se rencontraient à l'occasion dans les sociétés berlinoises patronnées par Arnolt Bronnen ou dans des soirées privées entre nationaux-révolutionnaires. Dans la plupart des cas, ils s'échangeaient des coups de bec ou des boutades cyniques. Jünger fit comprendre à Goebbels qu'il préférait de loin le type du «soldat-travailleur prusso-allemand» que celui du «petit bourgeois en chemise brune» qui proliférait dans les rangs de la NSDAP et des SA. Plusieurs décennies plus tard, Jünger se souvient: «... Goebbels m'invita. Notamment en 1932 à assister à l'un de ses discours, devant des travailleurs à Spandau. Je n'ai pas attendu la fin de son discours, je suis sorti avant, et j'ai appris plus tard qu'il y avait eu une formidable bagarre dans la salle. Goebbels était déçu: nous avons donné à cet Ernst Jünger une place d'honneur, mais quand ça a commencé à chauffer et que les chaises ont volé, il n'était plus là. Goebbels oubliait intentionnellement de dire que j'avais vécu de toutes autres batailles que cette bagarre de salle» (13).
Dans ces journaux, Goebbels fait souvent part de sa déception à l'égard de Jünger, qu'il aurait bien voulu voir adhérer à la NSDAP. Le 20 janvier 1926, le futur ministre de la propagande écrivait: «... Je viens de terminer hier la lecture des Orages d'acier d'Ernst Jünger. C'est un grand livre, brillant. La puissance de son réalisme suscite en nous de l'épouvante. De l'allant. De la passion nationale. De l'élan. C'est le livre allemand de la guerre. C'est un homme de la jeune génération qui prend la parole pour nous parler de la guerre, événement profond pour l'âme, et qui réalise un miracle en nous décrivant ce qui se passe dans son intériorité. Un grand livre. Derrière lui, un gaillard entier». Cinq mois plus tard, on perçoit déjà une déception: «... me suis préoccupé du “nouveau nationalisme” des Jünger, Schauwecker, Franke, etc. On parle et on passe à côté des vrais problèmes. Et il y manque la chose la plus importante, en dernière instance: la reconnaissance de la mission du prolétariat» (Goebbels, Journaux, 30 juin 1926).
Trois ans plus tard, Goebbels rejette définitivement Jünger: «... Mes lectures: Das abenteuerliche Herz de Jünger. Ce n'est plus que de la littérature. Dommage pour ce Jünger, dont je viens de relire les Orages d'acier. Ce livre était vraiment une grand livre, un livre héroïque. Parce que derrière lui, il y avait un vécu de sang, un vécu total. Aujourd'hui, Jünger s'enferme et se refuse à la vie, et ses écrits ne sont plus qu'encre, que littérature» (Goebbels, Journaux, 7 octobre 1929). Ce règlement de compte durera jusqu'à l'effondrement du Troisième Reich, quand, en dernière instance, Goebbels interdit à la presse allemande, de faire mention du cinquantième anniversaire de Jünger.
4. Le retrait
Hans-Peter Schwarz écrit dans son livre consacré à Jünger, Der Konservative Anarchist: «... Un phénomène qui mérite réflexion: dans les années 1925-1929, quand aucun observateur objectif n'aurait donné la moindre chance au nationalisme révolutionnaire en Allemagne, Jünger a joué le héraut de cette idée, mais quand, coup de sort fatidique, un Etat nationaliste, socialiste, autoritaire et capable de se défendre, a commencé à s'imposer, avec une évidence effrayante, ses intérêts pour les activités concrètes diminuent à vue d'oeil. En effet, après les élections de septembre 1930, il n'y avait plus qu'un seul mouvement politique qui pouvait revendiquer le succès et prétendre réaliser cette vision de l'Etat: la NSDAP d'Adolf Hitler» (14).
Le retrait de Jünger hors de la politique n'était pas dû immédiatement à la montée en puissance de la NSDAP. Plusieurs facteurs ont joué leur rôle. Parmi eux, le résultat de ses études sur le fascisme italien. Le fascisme n'aurait, à ses yeux, plus rien été d'autre «qu'une phase tardive du libéralisme, un procédé simplifié et raccourci, simultanément une sténographie brutale de la conception de l'Etat des libéraux, qui, pour le goût moderne, est devenue trop hypocrite, trop verbeuse et surtout trop compliquée. Le fascisme tout comme le bolchévisme ne sont pas faits pour l'Allemagne: ils nous attirent, nous séduisent, sans pourtant pouvoir nous satisfaire, et on doit espérer pour notre pays qu'il soit capable de générer une solution plus rigoureuse» (15). Jünger a-t-il deviné cette évolution pour le Reich?
Avec l'installation de Jünger à Berlin, commence son retrait. Depuis lors, il n'a plus cessé de se donner le rôle d'un observateur à distance. Dès le déclin des revues Vormarsch et Die Kommenden dans les années 1929 et 1930, il abandonne très ostensiblement la rédaction d'articles politiques. En se rémémorant cette tranche de sa vie, il a commenté le travail éditorial comme suit: «Les revues sont comme des autobus, on les utilise, tant qu'on en a besoin, et puis on en sort». Et: «On ne peut plus se soucier de l'Allemagne en société aujourd'hui; il faut le faire dans la solitude, comme un homme qui ouvrirait des brèches à l'aide d'un couteau dans la forêt vierge et qui n'est plus porté que par un espoir: que d'autres, quelque part sous les frondaisons, procèdent au même travail» (16). Jünger avait perçu que ses activités de politique quotidienne n'avaient plus de sens; il se consacrait de plus en plus à ses livres. Des ouvrages tels Das abenteuerliche Herz, Der Arbeiter et Die totale Mobilmachung (dont on n'a malheureusement retenu qu'un slogan) l'ont rendu célèbre en dehors des cercles étroits qui s'intéressaient à la politique.
Autre motif justifiant sans doute le retrait de Jünger: son amitié avec le national-bolchévique Ernst Niekisch, dont la revue, Widerstand, avait publié quelques articles de Jünger. Niekisch était un solitaire de la politique, fantasque et excentrique, mis sur la touche par l'Etat national-socialiste, pour des raisons de sécurité intérieure (sans avec raison, du point de vue des nouvelles autorités). Dans un article intitulé «Entscheidung» (= Décision), Niekisch plaide très sérieusement pour «l'injection de sang slave dans les veines allemandes, afin de guérir la germanité des influences romanes venues d'Europe du Sud et de l'Ouest». Ou: «... Celui qui vit conscient de sa responsabilité pour le millénaire d'histoire et de destin allemands à venir, ne s'effondre pas, effrayé, devant les remous d'une migration des peuples, s'il n'y a pas d'autre voie pour nous conduire à une nouvelle grandeur allemande» (17). Cette idée bizarre ne nécessite pas de commentaires de ma part. Mais Jünger n'était sans doute pas attiré par l'orientation à l'Est, prônée par Niekisch, ou par son anti-capitalisme lapidaire; ce qui l'attirait secrètement chez cet homme inclassable, c'est l'opiniâtreté avec laquelle il défendait la «pureté de l'idée».
Comme s'il voulait clarifier les choses pour lui-même, Jünger, dans Les Falaises de marbre (qui contiennent des traits auto-biographiques incontestables), nous expliquer pourquoi il a été travaillé par un désir de participer à la politique active: «Il y a des époques de déclin, pendant lesquelles la forme s'estompe, la forme qui est un indice très profond, très intériorisé, de la vie. Lorsque nous nous enfonçons dans ses phases de déclin, nous errons dans tous les sens, titubants, comme des êtres à qui manque l'équilibre... Nous voguons en imagination dans des temps reculés ou dans des utopies lointaines, où l'instant s'estompe... C'est comme si nous sentions la nostalgie d'une présence, d'une réalité et comme si nous avions pénétré dans la glace, le feu et l'éther, pour échapper à l'ennui».
5. La «zone des balles dans la nuque»
La rupture définitive entre les nationaux-socialistes et Jünger a eu lieu après la parution de Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt (1932). Dans bon nombre d'écrits nationaux-socialistes, ce livre a été critiqué avec une sévérité inouïe; il se serait agi d'un «bolchévisme crasse». Thilo von Trotha écrivit dans le Völkischer Beobachter: «... Eh oui! Les voilà, les interminables parlottes de la dialectique! On joue pendant trois cents pages avec tous les concepts possibles et imaginables, on les répète indéfiniment, on accumule autant de contradictions et, à la fin, il ne reste, surtout pour notre jeune génération, qu'une énigme insaisissable: comment un soldat du front comme Ernst Jünger a-t-il pu devenir cet homme qui, sirotant son thé et fumant ses cigarettes, acquiert une ressemblance désespérante avec ces intellectuels russes de Dostoïevski qui, pendant des nuits entières, discutent et ressassent les problèmes fondamentaux de notre monde». Thilo von Trotha ajoute, que Jünger ne voit pas «la question fondamentale de toute existence, ..., le problème du sang et du sol». En Jünger, pense von Trotha, s'accomplit la tragédie d'une homme «qui a perdu la voie vers les fondements promordiaux de tout Etre». Conclusion de von Trotha: ce n'est pas l'ère du Travailleur qui est en train d'émerger, mais l'ère de la race et des peuples.
Pourtant, malgré cette critique sévère et violente, von Trotha affirme que Jünger reste «un des meilleurs guerriers de sa génération», mais c'est pour ne pas lui pardonner son attitude fondamentalement individualiste: «... [les littérateurs nationaux-révolutionnaire, note de W.B.] passent leur existence à côté du grand courant de la vie allemande, marqué par le sang; ils cherchent toujours des adeptes mais restent condamnés à la solitude, à demeurer face à eux-mêmes et à leurs constructions, dans leur tour d'ivoire... et on observera sans cesse et avec étonnement qu'ils continuent à vouloir représenter la jeunesse allemande, en méconnaissant les faits réels, de façon tout-à-fait incompréhensible. L'“élite spirituelle” de la jeunesse allemande n'est pas littéraire, elle suit fidèlement le véritable Travailleur et le véritable Paysan: Adolf Hitler» (18). La critique atteint son sommet dans une formulation pleine de fantaisie: Jünger se rapprocherait, avec son ouvrage, de la «zone des balles dans la nuque». Dans la conclusion d'un article d'Angriff, un journal animé par Goebbels, on trouve une phrase plus concrète et plus mesurée, mais néanmoins exterminatrice: «Monsieur Jünger, avec cet ouvrage, est fini pour nous».
Ces critiques émanent pourtant des nationaux-socialistes les plus intelligents; mais elles ne tombaient du ciel, par hasard. Elles reflètent un constat politique posé dorénavant pas les autorités du parti: les nationaux-révolutionnaires sont rétifs à toute discipline de parti et veulent mener une vie privée opposée aux critères édictés par les nationaux-socialistes. Friedrich Hielscher dans son livre autobiographique Fünfzig Jahre unter Deutschen (= «Cinquante ans parmi les Allemands») évoque quelques anecdotes de l'époque. Nous y apprenons que la vie privée de nombreux “nationaux-révolutionnaires” ne respectait aucun dogme ni aucune rigueur comportementale. Ainsi, au cœur de l'hiver très froid de 1929, cette joyeuse bande s'était réunie dans l'appartement de Jünger à Berlin. Aux petites heures, ils buvaient tous du rhum dans des tasses de thé et voilà que le poêle vient à s'éteindre faute de bois. Jünger, sans hésiter, casse à coups de pied une vieille commode de son propre mobilier, la démonte et en empile les morceaux près du feu, permettant ainsi à la compagnie de gagner encore un peu de chaleur et de confort» (19).
6. Dans le Royaume de Léviathan
A cette époque, les critiques des nationaux-socialistes ne touchaient plus Jünger. Il s'était bien trop éloigné de la politique quotidienne. La “révolution nationale” de janvier 1933 ne lui avait fait aucun effet. La réalité du IIIième Reich n'était pour lui que les ultimes soubresauts du monde bourgeois, n'était qu'une “démocratie plébiscitaire», dernière conséquence néfaste des «ordres nés de 1789» (20). Pour pouvoir poursuivre son travail dans l'isolement, il quitte Berlin et s'installe à Goslar. Avant ce départ, le nouvel Etat ne put s'empêcher de commettre quelques perquisitions chez la famille Jünger.
Sur l'une de ces perquisitions, un écho est passé dans la presse de l'époque; dans les Danziger Neuesten Nachrichten du 12 avril 1933, on peut lire: «Comme on l'a appris par la suite, sur base d'une dénonciation, il a été procédé à une perquisition au domicile de l'écrivain nationaliste Ernst Jünger, qui a gagné au feu, en tant qu'officier, l'Ordre Pour le Mérite pendant la guerre mondiale, qui a écrit plusieurs livres sur cette guerre, parmi lesquels un ouvrage de grand succès, Orages d'acier, et qui, dans son dernier livre de sociologie et de philosophie, Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt, se réclame d'idées collectivistes. La perquisition n'a pas permis de découvrir objets ou papiers compromettants». La dernière livraison de la revue Sozialistische Nation n'épargnait pas ses sarcasmes: «... On n'a rien trouvé, si ce n'est l'Ordre Pour le Mérite». Jünger ne laissa planer aucun doute: il fit savoir clairement qu'il n'entendait participer d'aucune façon aux activités culturelles du Troisième Reich, comme auparavant à celles de la République de Weimar. Ses lettres de refus à l'Académie des Ecrivains de Prusse sont devenues célèbres, de même que sa réponse brève et sèche à la Radio publique de Leipzig, qui l'avait invité pour une émission. Il souhaitait tout simplement «ne pas participer à tout cela». Le 14 juin 1934, il écrit à la rédaction du Völkischer Beobachter: «Dans le supplément “Junge Mannschaft” du Völkischer Beobachter des 6 et 7 mai 1934, j'ai constaté que vous aviez reproduit un extrait de mon livre Das abenteuerliche Herz. Comme cette reproduction ne comporte aucune mention des sources, on acquiert l'impression que j'appartiens à votre rédaction en tant que collaborateur. Ce n'est pas le cas: depuis des années je n'utilise plus la presse comme moyen [d'expression]. Dans ce cas particulier, il convient encore de souligner que nous sommes face à une incongruité: d'une part, la presse officielle m'accorde le rôle d'un collaborateur attitré, tandis que, d'autre part, on interdit par communiqué de presse officiel la reproduction de ma lettre à l'Académie des Ecrivains du 18 novembre 1933. Je ne vise nullement à être cité le plus souvent possible dans la presse, mais je tiens plutôt à ce qu'il ne subsiste pas la moindre ambigüité quant à la nature de mes convictions politiques. Avec l'expression de mes sentiments choisis, Ernst Jünger».
Fait significatif: de 1933 à 1945, Ernst Jünger n'a pas reçu la moindre distinction honorifique ou bénéficié du moindre hommage officiel. «... Ne trouvez-vous pas curieux que je n'ai pas obtenu le moindre prix sous le IIIième Reich, alors qu'on prétend que j'aurais été si précieux pour les nazis. Si tel avait été le cas, j'aurais été couvert de prix et de distinctions», remarque Jünger près de soixante ans après les événements.
La vie de Jünger fut relativement paisible de 1934 à la guerre. Nous lui devons plusieurs livres immortels, datant de cette période, pendant laquelle il a consolidé son constat: le national-socialisme a sa phase héroïque derrière lui. Sans retour. Qu'en restait-il? Sa prédilection pour les structures hiérarchiques, clairement délimitées. En 1982, Jünger reconnaissait: «Certes, j'ai un faible pour les systèmes d'ordre, pour l'Ordre des Jésuites, pour l'armée prussienne, pour la Cour de Louis XIV... De tels ordres m'en imposent» (22).
Ernst Jünger est resté fidèle à lui-même pendant toute son existence. C'est ainsi que Karl O. Paetel, jadis militant “nationaliste social-révolutionnaire”, dans une excellent biographie consacrée à son ami immédiatement après la dernière guerre, répond aux critiques de façon définitive, pour les siècles des siècles: «Le guerrier est-il devenu pacifiste? L'admirateur de la technique, un ennemi du progrès technique? Le nihiliste, un chrétien? Le nationaliste, un bourgeois cosmopolite? Oui et non: Ernst Jünger est devenu dans une certaine mesure le deuxième homme sans jamais cesser d'être le premier. A aucune étape dans le cheminement de son existence, Ernst Jünger ne s'est converti, jamais il n'a brûlé ce qu'il adorait hier. Les transformations ne sont pas rejets chez lui, mais fruits d'acquisitions, d'élargissements d'horizons, de complètements; il ne s'agit jamais de se retourner, mais de poursuivre le même chemin en mûrissant, sans se fixer dans les aires de repos. C'est ainsi que Ernst Jünger a trouvé son identité, est devenu le diagnostiqueur de notre temps, éloigné de tout dogme dans son questionnement comme dans les réponses qu'il suggère».
Werner BRÄUNINGER.
Notes:
(1) Ernst JÜNGER, «Reinheit der Mittel», in Die Kommenden, 27 déc. 1929.
(2) Ernst JÜNGER, Strahlungen. Die Hütte im Weinberg. Jahre der Okkupation, p. 615 (éd. DTV, 1985).
(3) Ernst JÜNGER, «Abgrenzung und Verbindung», in Standarte, 13 sept. 1925.
(4) (5) (6) Voir remarque 2, p. 612, 617 et 444 (Jünger cite ici un mot de Valeriu Marcu).
(7) Ernst JÜNGER, «Der Frontsoldat und die innere Politik», in Standarte, 29 nov. 1925.
(8) Ernst JÜNGER, Interview accordé à Der Spiegel, n°33/1982.
(9) Voir rem. 2, p. 616.
(10) La formule «réalisme héroïque» provient de l'article «Der Krieg und das Recht» du Dr. Werner Best (publié dans le volume collectif Krieg und Krieger, édité par Ernst Jünger à Berlin en 1930). Quant à savoir si cette formule, utilisée par Jünger, provient originellement de Best, rien n'est sûr à 100%.
(11) Ernst JÜNGER, «Schließt Euch zusammen», in Die Standarte, 3 juin 1926.
(12) Ernst von SALOMON, Der Fragebogen, p. 244 (7), 1952.
(13) voir rem. 8.
(14) Hans-Peter SCHWARZ, Der konservative Anarchist. Politik und Zeitkritik Ernst Jüngers, Verlag Rombach, 1982, p. 107.
(15) Ernst JÜNGER, «Über Nationalismus und Judenfrage», Süddeutsche Monatshefte, 27, n°12, 1930.
(16) Ernst JÜNGER, Das abenteuerliche Herz.
(17) Ernst NIEKISCH, Entscheidung, p. 180 ss.
(18) Ex Völkischer Beobachter (édition bavaroise), 22 oct. 1932.
(19) Description de mémoire de Werner Bräuninger, ex: Friedrich HIELSCHER, Fünfzig Jahre unter Deutsche, Rowohlt Verlag, 1950.
(20) Ernst JÜNGER, Strahlungen. Kirchhorster Blätter, p. 298 (DTV n°10.985).
(21) (22) Voir rem. 8.
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, allemagne, années 20, années 30, histoire, nationalisme révolutionnaire, national-socialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 16 décembre 2009
Sarrazin wirkt
 Sarrazin wirkt
Sarrazin wirkt
Öffentliche Verkehrsmittel in Großstädten sind eine Universität der rauhen Wirklichkeit. Redakteur Rainer Wehaus von den „Stuttgarter Nachrichten“ ist bodenständig genug, um auch mal die Stadtbahn zu nehmen. Der „Fall Sarrazin“ hat ihn scheint’s ermuntert, die dort gemachten Erfahrungen mit seinen Lesern zu teilen.
Woran denkt die „schweigende Mehrheit“, wenn sich im Stadtbahnwagen „ein paar junge Männer mit Migrationshintergrund“ lärmend, brüllend und rempelnd breitmachen, daß die anderen Fahrgäste stumm die Köpfe einziehen? – fragt Wehaus im Leitartikel der „Stuttgarter Nachrichten“ [1] vom 5. Dezember und mutmaßt:
„An den altklugen Zeitungskommentar von gestern, der zu mehr Verständnis und zu mehr Hilfe für bildungsferne Schichten aufrief? Oder an die salbungsvollen Worte aus der Politik, derzufolge man doch bitte schön andere Kulturen als Bereicherung empfinden und den Dialog suchen solle?“
Eine Dame, die es damit versucht und die Halbstarken um Ruhe bittet, wird wüst angepöbelt. Die Störenfriede steigen aus, die Mehrheit schweigt erleichtert weiter. „Wer Stadtbahn fährt, erlebt so etwas öfter“, weiß Wehaus und findet zur treffenden Lageanalyse:
„Es sind die Erlebnisse des gemeinen Volks, die so gar nicht zu dem passen wollen, was die Politik mit Hilfe der Medien gerne präsentiert: Vorzeigeprojekte zur besseren Integration ausländischer Jugendlicher – die heile Welt im Kleinen. Oder Islamkonferenzen mit großen, leeren Worten. In der Stadtbahn sieht die Welt etwas anders aus. Und die schweigende Mehrheit beschleicht das unbestimmte Gefühl, daß die Politik ihnen nicht die ganze Wahrheit sagt.“
Von dieser Lagebeschreibung aus bringt Wehaus die Sarrazin-Kampagne auf den Punkt –
„Der Stammtisch darf auch dann nicht recht haben, wenn er recht hat.“
– und zieht mit Sarrazins Kommentar zum Schweizer Minarettverbot im Handelsblatt die Quintessenz aus der „Kluft zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung“, die ihm in beiden Fällen ins Auge springt:
„ ‚Das Schweizer Volksbegehren zeigt, daß in der Tiefe der Gesellschaft anders gedacht wird, als die politische Klasse und die Mehrheit der Medien glauben wollen.’ Da hilft nur eins: Öfter mal Stadtbahn fahren.“
Kein Zweifel: Sarrazin wirkt. Die Debatte, die der Ex-Senator aus der Flasche gelassen hat, geht weiter; seine Art, Klartext zu reden, wirkt ansteckend. Die Breschen in der politisch korrekten Schweigemauer um das Multikulti-Luftschloß werden größer. Es passen schon immer mehr Redakteure etablierter Tageszeitungen hindurch.
(Foto: flickr/kaffeeeinstein)
Article printed from Sezession im Netz: http://www.sezession.de
URL to article: http://www.sezession.de/9863/sarrazin-wirkt.html
URLs in this post:
[1] im Leitartikel der „Stuttgarter Nachrichten“: http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1405184
00:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, europe, affaires européennes, immigration |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 12 décembre 2009
Joseph Roth e il mito dell'impero
Roberto Alfatti Appetiti
http://robertoalfattiappetiti.blogspot.com/
 Joseph Roth e il mito dell’impero
Joseph Roth e il mito dell’impero
Il grande scrittore austriaco, lo strenuo difensore dei valori tradizionali in rivolta contro il suo tempo, era morto da poco più di dieci anni (il 27 maggio del 1939) ma era stato già dimenticato, per non dire rimosso, dalla storia letteraria europea. Ancora negli anni Sessanta il suo nome, ad eccezione degli ambienti accademici e di pochi pionieri (in Italia Claudio Magris), era quasi sconosciuto. Prima che Adelphi rendesse giustizia a Roth, pubblicando negli anni Settanta e Ottanta le sue opere, nel passato solo pochi editori fieramente controcorrente come Longanesi e Vallecchi avevano proposto qualche suo titolo, restituendogli una temporanea e circoscritta popolarità. La grande editoria preferiva investire quasi esclusivamente su autori “politicamente corretti” e certo la «gloria letteraria dei monarchici» (come lo ha definito Soma Morgenstern nel suo Fuga e fine di Joseph Roth, Adelphi 2001), l’antidemocratico Roth, non poteva considerarsi organico al verbo progressista. Per Roth la democrazia altro non era che «lo stratagemma» che le dittature, il proletariato e i nazionalismi volevano utilizzare per raggiungere le proprie mire, generando «solo brutalità in un mondo in trasformazione».
Galiziano di Brody, era nato il 2 settembre 1894 da genitori ebrei, aveva studiato germanistica a Vienna e partecipato alla prima guerra mondiale. Giornalista prolifico e apprezzato (oltre mille articoli scritti tra le due guerre), ha vissuto la sua travagliata vita di pendolare delle lettere tra Berlino, Vienna, Francoforte e Parigi, dove si stabilì in esilio dal 1933 e morì che non aveva neanche quarantacinque anni. Roth era cresciuto nel mito unificante e multiculturale dell’impero austroungarico, nel quale «non si distinguevano uomini di diverse nazionalità perché ognuno parlava tutte le lingue». La struttura antinazionalista della monarchia asburgica aveva lasciato un segno indelebile nella sua formazione. Il mescolarsi per le strade di tedesco, polacco, ucraino, yiddish, e le differenze etniche, rappresentavano una ricchezza, un patrimonio da custodire gelosamente e di cui il tutore era il vecchio imperatore Francesco Giuseppe, «onnipresente tra i suoi sudditi come Dio nell’universo». Il cuore pulsante dell’impero non era Vienna, che pure ospitava la residenza imperiale, ma le grandi periferie, come quella orientale da cui lui proveniva. Era proprio il «tragico amore» dei Paesi della Corona per l’Austria a nutrire la capitale. Bastava che suonasse la Marcia e in qualsiasi angolo dell’impero ci si trovasse l’identità comune si affacciava in tutti i cuori: «Tutti i concerti in piazza cominciavano con la marcia di Radetzky. Gli arcigni tamburi rullavano, i dolci flauti zufolavano e i benigni piatti squillavano. Sui visi di tutti gli ascoltatori spuntava un sorriso compiacente e trasognato, mentre nelle loro gambe il sangue frizzava. Erano fermi e credevano di marciare».
Come ha scritto Maria Sechi nel suo Invito alla lettura di Roth (Mursia 1994), Roth rimproverava alla borghesia occidentale di aver commesso «un vero crimine: aver distrutto la tradizione, la legge e l’ordine» di quella che riteneva una grande civiltà. Nell’industrializzazione, capace solo di produrre «imbrogli e illusioni» e nell’offensiva della tecnica vedeva un «un’ulcera» che finiva per ridurre l’uomo ad automa, a pedina, ad ingranaggio di un processo massificante. Il mondo era irreversibilmente malato, minato nelle sue fondamenta dalla spinta dei nascenti nazionalismi, come denuncia nella Radetzkymarsh: «L’epoca non ci vuole più! Questa epoca vuole creare degli Stati nazionali indipendenti! La gente non crede più in Dio. La nuova religione è il nazionalsocialismo. I popoli non vanno più nelle Chiese. Vanno nei circoli nazionalisti. La nostra monarchia è fondata sulla religiosità: sulla credenza che Dio abbia eletto gli Asburgo a regnare su tali e tanti popoli cristiani».
Da giovane aveva provato simpatia per il socialismo, non per convinzioni marxiste ma per un sentimento di naturale vicinanza ai poveri. “Joseph il rosso”, era stato soprannominato, ma un viaggio in Russia nel 1926-27, come inviato del Frankfurter Zeitung, gli aveva aperto gli occhi, tanto da fargli commentare: «E’ una grande fortuna che io abbia fatto questo viaggio in Russia: altrimenti non avrei mai conosciuto me stesso». «Sono partito bolscevico e sono tornato monarchico», ironizzava. Il suo era un «anticomunismo patologico», sentenziò sprezzantemente Ludwig Marcuse. Trovò l’URSS un deserto spirituale, «tutte le sue simpatie per quel paese erano di colpo svanite», ha scritto Soma Morgenstern. «Mai ho sentito così intensamente di essere un europeo, un mediterraneo se vuole, un romano e un cattolico, un umanista e un uomo del rinascimento», scrisse ad un amico al suo ritorno. «Detestava apertamente le convinzioni politiche ed il fanatismo» dei comunisti. Ai suoi occhi il socialismo si era macchiato di una imperdonabile colpa: aver contagiato di materialismo la Russia, creando le premesse per l’affermazione in quella regione della società e dei valori borghesi e trasformando un popolo religioso in una massa anonima di piccoli borghesi ambiziosi: «Ebbene questo è proprio il caso in cui la beffa della storia è palese. Questa storia che dovrebbe liberare il proletariato, che ha come scopo la creazione dello Stato e dell’umanità senza classi, questa teoria, la dove viene applicata per la prima volta, fa di tutti gli uomini dei piccoli borghesi. E, per colmo di sfortuna, fa le sue prime prove proprio in Russia, dove i piccoli borghesi non sono mai esistiti. In Russia, appunto, il marxismo si presenta soltanto come una componente della civiltà borghese europea. Anzi, sembra quasi che la civiltà borghese abbia affidato al marxismo il compito di farle da battistrada in Russia».
Il suo individualismo lo portava a respingere ogni forma di collettivismo. In una lettera all’amico e mentore Stephan Zweig accusò il socialismo di aver generato il fascismo e il nazionalsocialismo, anticipando così con grande lungimiranza le successive tesi di Ernst Nolte. Il suo era un profondo risentimento verso la modernità incalzante, nei confronti della quale si sentiva profondamente estraneo, se non dichiaratamente ostile. Lo scrive senza equivoci nelle prime pagine de La Cripta dei Cappuccini: «Io non sono un figlio del mio tempo, anzi, mi riesce difficile non definirmi addirittura suo nemico. Non che io non lo capisca, come tante volte sostengo. Questa è solo una scusa di comodo. Per indolenza, semplicemente, non voglio essere aggressivo o astioso, e perciò dico che una cosa non la capisco quando dovrei dire che la odio o la disprezzo. Ho l’orecchio fine, ma faccio il sordo. Mi pare più elegante fingere un difetto che ammettere di aver sentito rumori volgari».
E probabilmente, fosse stato ancora in vita, avrebbe ignorato anche lo sprezzante giudizio che di lui diede Italo Alighiero Chiusano nel 1979 su La Repubblica: «Ormai si può parlare da noi di un’ondata Roth, con entusiasmi che sarà bene lasciar sfogare per la simpatia che il personaggio merita e per il suo indubbio valore letterario, ma che più tardi bisognerà ridurre ai limiti reali. Chi mette Joseph Roth alla pari di Kafka, Mann, Brecht, Musil, lo costringe ad un confronto che egli non può sostenere». Niente di più falso, quel confronto Roth lo ha sostenuto e continua a sostenerlo con grande dignità, nonostante la diffidenza di buona parte del mondo editoriale e culturale “che conta”. La dimostrazione più lampante è offerta dal fatto che persino La Repubblica abbia recentemente inserito nella sua “Biblioteca” una delle opere di questo grande scrittore reazionario, e proprio La Cripta dei Cappuccini (1938), che con La Milleduesima notte e il Leviatano (queste ultime pubblicate solo postume) può essere considerata una delle opere maggiormente nichiliste e antimoderne per eccellenza.
La Cripta è un romanzo aspro, amaro, struggente. E’ il libro dell’addio ad un’epoca che sembrava eterna e che invece andava incontro ad un repentino tramonto: «La morte incrociava già le sue mani ossute sopra i calici dai quali noi bevevamo, lieti e puerili». Il protagonista è Francesco Ferdinando Trotta, un giovane rampollo di una famiglia di recente nobiltà, che attraversa l’esperienza bellica trovando al suo ritorno una Vienna irriconoscibile. E’ un personaggio in buona parte autobiografico. Anche Roth ha partecipato alla Grande Guerra come volontario e come ufficiale. Era andato in guerra per «uno strano motivo che solo Conrad potrebbe spiegare […] come i vecchi scapoli, che, non potendo sopportare la solitudine, contraggono matrimonio». Anche Roth aveva provato un forte senso di smarrimento appena tornato dal fronte, nell’accorgersi di come tutto attorno a lui fosse cambiato, e suoi sono senz’altro i sentimenti espressi dal giovane Trotta: «Tutti noi avevamo perso rango, posizione e nome, casa e denaro e valori: passato, presente, futuro. Ogni mattina quando aprivamo gli occhi imprecavamo alla morte che invano ci aveva attirato alla sua festa grandiosa. E ognuno di noi invidiava i caduti. Riposavano sottoterra e la primavera ventura dalle loro ossa sarebbero nate le violette. Noi invece eravamo tornati a casa disperatamente sterili, coi lombi fiaccati, una generazione votata alla morte, che la morte aveva sdegnato». I valori in cui aveva creduto non avevano più cittadinanza: «Allora, prima della Grande Guerra […] non era ancora indifferente se un uomo viveva o moriva. Se uno era cancellato dalla schiera dei terrestri non veniva subito un altro al suo posto per far dimenticare il morto ma, dove quello mancava, restava un vuoto, e i vicini come i lontani testimoni del declino di un mondo ammutolivano ogni qual volta vedevano questo vuoto». Si sentiva a disagio in quel nuovo sistema politico che andava affermandosi. Trotta si trova in un caffè quando apprende la notizia della costituzione di un nuovo governo popolare tedesco. «Da quando ero rimpatriato dalla guerra mondiale, rimpatriato in un paese pieno di rughe, mai avevo avuto fiducia in un governo: figuriamoci poi, in un governo popolare. Io appartengo ancora oggi – nell’imminenza della mia probabile ultima ora, io, un uomo, posso dire la verità – a un mondo palesemente tramontato, nel quale pareva naturale che un popolo venisse governato e che, dunque, se non voleva cessare di essere popolo, non poteva governarsi da solo. Ai miei orecchi – spesso avevo sentito che li chiamavano reazionari – suonò come se una donna amata mi avesse detto che non aveva affatto bisogno di me, che poteva fare l’amore con sé sola, e che anzi doveva farlo, e invero al solo scopo di avere un bambino». Non resta altro da fare al protagonista, e Roth sceglie per lui un finale simbolico. Trotta, come ultimo atto, si reca a portare l’ultimo omaggio al suo imperatore: «La Cripta dei Cappuccini, dove giacciono i miei imperatori, sepolti in sarcofaghi di pietra, era chiusa. Il frate cappuccino mi venne incontro e chiese: Che cosa desidera? Voglio visitare il sarcofago del mio imperatore Francesco Giuseppe, risposi. Dio la benedica, disse il frate e fece sopra di me il segno della croce. Dio conservi!, gridai. Zitto!, disse il frate. Dove devo andare, ora, io, un Trotta?».
Lo stato d’animo del giovane Trotta è lo stesso degli altri personaggi dei romanzi “politici” di Roth, Hotel Savoy, La ribellione, Fuga senza fine, Zipper e suo padre. Sono reduci incapaci di affrontare la nuova esistenza, animati da delusione, risentimento, rabbia, senso di impotenza. Il Conte Xaver Morstin, nella novella Il busto dell’imperatore (1934) esprime tutta la sua amarezza: «I capricci della storia hanno distrutto anche la gioia personale che veniva da ciò che io chiamavo patria. Ai loro occhi io sono considerato un cosiddetto Vaterlos, un senza patria. Lo sono sempre stato. Ahimè! C’era una volta una patria, una vera, una cioè per i senza patria, l’unica possibile. Era la vecchia monarchia; ora sono un senza patria che ha perduto la vera patria dell’eterno viandante». Anche dopo la caduta dell’impero il vecchio imperatore restava «una figura al di fuori di tutto ciò che è normale», e come tale da venerare. «Nessuna virtù ha stabilità in questo mondo eccettuato una sola: l’autentica devozione. La fede non ci può ingannare perché non ci promette nulla sulla terra. Applicato alla vita dei popoli ciò significa che invano essi ricercano le cosiddette virtù nazionali. Per questo io odio le Nazioni e gli stati nazionali. La mia vecchia patria, la monarchia sola era una grande casa con molte porte e molte stanze per molte specie di uomini. La casa è stata suddivisa, spaccata, frantumata. Là io non ho più nulla da cercare. Io sono abituato a vivere in una casa, non in una cabina».
Analogo destino di «senza patria» è quello di Franz Tunda, protagonista di Fuga senza fine (1928). Il giovane ufficiale asburgico, dopo essere stato prigioniero di guerra dei russi, lasciata con la divisa l’identità militare, si sente fuori posto ovunque. Fuggito rocambolescamente da un lager siberiano, capita casualmente tra i guerriglieri comunisti. Lì conosce una giovane militante, Natascha. Per amore ne sposa la causa, anche se la rivoluzione socialista «non gli era simpatica, gli aveva rovinato la carriera e la vita». Ma Natascha «non voleva saperne della sua bellezza, si ribellava contro se stessa, riteneva la sua femminilità una ricaduta nella concezione borghese della vita e l’intero sesso femminile un residuo ingiustificato di un mondo vinto, agonizzante». Tunda si accorge presto che la rivoluzione è diventata prassi burocratica, una «disciplina senza sentimento». Finisce per stabilirsi a Parigi, «senza nome, senza credito, senza rango, senza titolo, senza soldi e senza professione: non aveva né patria né diritti». Dice Tunda, e a parlare è naturalmente Roth: «Io so soltanto che non è stata, come si dice, la inquietudine a spingermi, ma al contrario un’assoluta quiete. Non ho nulla da perdere. Non sono né coraggioso né curioso di avventure. Un vento mi spinge, e non temo di andare a fondo». Significativo è anche qui il finale scelto da Roth per chiudere il romanzo: «A quell’ora il mio amico Franz Tunda, trentadue anni, sano e vivace, un uomo giovane, forte, dai molti talenti, era nella piazza davanti alla Madelaine, nel cuore della capitale del mondo, e non sapeva cosa doveva fare. Non aveva nessuna professione, nessun amore, nessun desiderio, nessuna speranza, nessuna ambizione e nessun egoismo. Superfluo come lui non era nessuno al mondo». L’unica possibilità è la “fuga”, una “fuga senza fine”. Non c’è alcun velleitarismo in Roth, non c’è speranza di improbabili rivalse, la partita è persa, ma la resa non significa accettazione e omologazione. La sua narrazione non è politica in senso stretto, è più che altro sentimentale: «tutti i cambiamenti della carta geografica d’Europa non avevano cambiato i sentimenti dei popoli», dice Morstin/Roth.
A partire dagli anni Trenta, deluso dall’attualità, Roth si è limitato a rievocare con nostalgia e grande capacità suggestiva il mondo di ieri, una civiltà europea «frantumata», per affermare la sua identità, per crearsi un rifugio individuale. Più tardi la simpatia per la monarchia si intrecciò con la sua discussa conversione al cattolicesimo. Aveva trovato nell’universalismo del cattolicesimo l’unico collante che potesse ergersi a baluardo dei suoi valori, assumendo quello che era stato il ruolo unificante dell’impero: «la Chiesa romana in questo marcio mondo è l’unica ormai in grado di dare, di conservare una forma».
Un importante contributo all’approfondimento della personalità di Roth è arrivato grazie alla biografia Fuga e fine di Joseph Roth, che raccoglie la preziosa e affettuosa testimonianza di uno dei suoi migliori amici, Soma Morgenstern (galiziano anche lui, romanziere apprezzato da Musil, dopo la morte di Roth venne internato in un campo di concentramento francese e morì dimenticato da tutti a New York nel 1976). Ci lascia un ritratto completo di luci e ombre sulla vita dello scrittore, ci presenta un Roth insolente e ingrato, geniale e un po’ impostore, infantile e lucidissimo nei suoi giudizi sull’epoca e sui suoi contemporanei, ora aggressivo ora vulnerabile, decisamente affascinante: «vestiva con particolare eleganza, quasi da bellimbusto. I suoi capelli biondi avevano la scriminatura nel mezzo, e il suo monocolo suscitò stupore nel nostro gruppetto». «Se fosse stato francese», scrive Morgenstern, «e avesse vissuto qualche altro anno, sarebbe diventato una leggenda». E ne spiega i motivi: sapeva creare atmosfera attorno a sé, viveva, si ubriacava, lavorava, tutto in pubblico e «disseminava opinioni iconoclaste» che creavano regolarmente scandalo. Come scrive ancora Morgenstern, Roth parlava di Otto d’Asburgo, pretendente al trono austriaco, con sincera devozione, come si trattasse dell’imperatore, solo «per acquietare i suoi dubbi sulle probabilità di una realizzazione storica di quel sogno». In realtà non aveva fiducia nella politica e finì per ritenere lo stesso pretendente al trono «troppo poco legittimista» per i suoi gusti. Frequentava gli ambienti monarchici, ma più che altro perché divideva con gli altri esuli lo status di orfano di un mondo scomparso.
Dopo lo sfacelo dell’impero si rifugiò nell’alcool, perché così «la vita diventa più facile» e «talvolta libera l’animo umano». A chi gli rimproverava il suo vizio, rispondeva ironicamente che era divenuto alcolizzato «per incarico divino». «La salute! Puah!», si scherniva, mentre faceva di tutto per accellerare il suo incontro con la morte. «Ecco quel che veramente sono; cattivo, sbronzo, ma in gamba», si definì con autoironia. Continuò a scrivere altri libri, sempre lavorando nei tavoli dei caffè. Opere che possiedono, come ha scritto Gian Antonio Stella nella prefazione a Giobbe, romanzo di un uomo semplice (il libro del 1930 che il Corriere della Sera ha inserito nella sua “Biblioteca”), una particolare «forza immaginifica, così gonfia e possente da dare talora le vertigini». Il suo ultimo racconto, scritto negli ultimi giorni di vita e pubblicato solo postumo, è tra i più noti, anche grazie ad una recente trasposizione cinematografica. La leggenda del Santo bevitore può essere considerato un po’ come il suo testamento spirituale. Il protagonista è Andreas Kartak, un uomo smarrito, perso al mondo, un clochard. Uno sconosciuto gli offre un prestito chiedendo in cambio solo l’impegno a restituire la somma alla piccola Santa Teresa nella Chiesa di Santa Maria di Batignolles. Andreas non userà quel prestito per redimersi, per cambiare vita. Al contrario, come Roth, va incontro al suo destino, quasi incoraggiando la sua stessa rovina. Quando la morte sta per sopraggiungere ha un unico pensiero, quel prestito da rendere alla giovane Santa, dimostrando uno spiccato senso dell’onore, lo stesso che ha animato l’intera vita di quel fedele servitore dell’Imperatore che fu Joseph. «Conceda, conceda Dio a tutti noi, noi bevitori, una morte così facile e così bella», questo è l’ultimo auspicio di Andreas. E Roth morirà, come il suo ultimo personaggio, dopo l’ultima e fatale crisi di delirium tremens in un ospedale per i poveri.
00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autriche, empire, allemagne, lettres allemandes, littérature allemande, lettres, littérature |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 11 décembre 2009
Presseschau (Dez. 2)
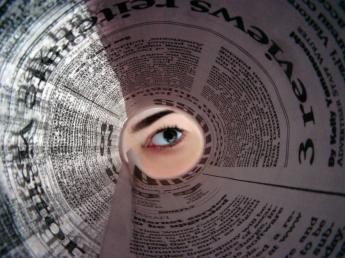 PRESSESCHAU (Dez. 2)
PRESSESCHAU (Dez. 2)
Einige Links. Bei Interesse anklicken...
###
Ohne Worte ...
Rüttgers bedauert Abzugspläne für britische Rheinarmee
http://jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M5c446e4389d.0.html
Afghanistan-Strategie
US-Präsident Obama setzt Deutschland unter Druck
„Dies ist nicht nur Amerikas Krieg.“ Mit diesen Worten richtete Barack Obama in seiner Rede zur Strategie in Afghanistan ein deutliches Signal an die Alliierten, gemeinsam den Krieg zu beenden. Deutschland steht unter Zugzwang, sein Kontingent um fast 50 Prozent aufzustocken und das Einsatzgebiet auszuweiten.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5400841/US-Praesident-Obama-setzt-Deutschland-unter-Druck.html
Tanklaster-Angriff
Guttenberg gerät in Erklärungsnot
Eilig läßt der Verteidigungsminister den Angriff auf zwei Tanklaster in Afghanistan neu prüfen. Die Zeit drängt, auch in den eigenen Reihen wächst die Kritik am Krisenmanagement Guttenbergs. Einem Zeitungsbericht zufolge bewertete das Kanzleramt den Einsatz bereits vor der Wahl [zivilistisch gesehen] als Debakel – und schwieg.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,664150,00.html
Bombardement in Afghanistan
Guttenberg korrigiert Einschätzung des Tanklasterangriffs
Verteidigungsminister Guttenberg vollzieht die Kehrtwende: Aus heutiger Sicht sei der Luftangriff auf zwei Tanklaster in Afghanistan „militärisch nicht angemessen“ gewesen, sagte er im Bundestag. Dennoch will er den für das Bombardement verantwortlichen Oberst Klein nicht fallenlassen.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,665075,00.html#ref=nldt
Kommentar zur Kundus-Affäre
Guttenberg hat seine Reifeprüfung bestanden
Von Thorsten Jungholt
Er hat eine lückenlose Aufklärung des Luftangriffs von Kundus angekündigt – und sein Versprechen gehalten: Verteidigungsminister Guttenberg. Im Bundestag revidierte der CSU-Politiker seine ursprüngliche Einschätzung des Bombardements und nahm gleichzeitig die Soldaten in Schutz.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5418479/Guttenberg-hat-seine-Reifepruefung-bestanden.html
Was denkt die Truppe? Schaut auf die T-Shirts ...
Wer wissen will, was die Truppe irgendwo im fremden Land wirklich denkt, sollte mal einen Blick unter die Uniform werfen. Wie bei gleichaltrigen Zivilisten sind T-Shirts mit Aufdruck oft genug ein Ausdruck dessen, was die Truppe denkt – oder manchmal auch nur fühlt. Da spielt es keine Rolle, ob diese Aufdrucke auf hohem intellektuellem Niveau sind oder vielleicht sogar geradewegs geschmacklos: Die Baumwollhemdchen treffen einfach einen Nerv.
Deshalb ist das T-Shirt, das nach Bundeswehrangaben in Camp Marmal in Nordafghanistan verkauft wurde, auch so ein Symbol: Unter dem biblischen Gebot „Thou shalt not steal“ (Du sollst nicht stehlen) waren zwei Tanklastzüge abgebildet. Kommandeur Jürgen Setzer hat natürlich den Verkauf sofort verboten. http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/2009/11/was-denkt-die-truppe-schaut-auf-die-tshirts-.html
Afghanistan
Was wir unseren Soldaten schuldig sind
Eine Demokratie hat die Menschen zu achten, die sie in ihren Krieg schickt, meint der Schriftsteller Michael Kleeberg. Dieser Staat müsse Verantwortung übernehmen – nicht nur gegenüber der Bevölkerung in Afghanistan und den Bündnispartnern, sondern auch gegenüber den eigenen Bürgern in Uniform.
http://www.welt.de/politik/article5369654/Was-wir-unseren-Soldaten-schuldig-sind.html
Und wieder spielt die Gewalt gegen Deutsche oder Mehrheitsbürger keine Rolle ...
„Hate Crimes“
Haß aufs Anderssein
Von Malte Steinhoff
Obdachlose, Schwule, Andersgläubige: Jedes Jahr werden in Deutschland mehr als 100.000 Angehörige von Minderheiten Opfer einer Gewalttat. Experten sehen in den „Hate Crimes“ eine Gefahr für die zivilisierte Gesellschaft. [HINWEIS: Im Artikel selbst bezieht sich die in der Einleitung genannte Zahl von 100.000 Taten (inklusive Dunkelziffer!) nicht nur auf Gewalttaten (deren es schätzungsweise 2.000 bis 3.000 pro Jahr geben soll, davon knapp ein Drittel mit „rechtsradikalem“ Hintergrund), sondern auch auf andere nicht körperliche Übergriffe in Form von Sachbeschädigungen, Beleidigungen und Drohungen!]
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,662836,00.html
Familienministerin ...
Kristina Köhler beim Christopher-Street-Day in Frankfurt
http://www.kristina-koehler.de/wiesbaden/unterwegs/2009/kristina-koehler-beim-christop/
Familie
Richter schützen ledige Väter vor deutschem Recht
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Deutschland wegen der Diskriminierung lediger Väter gerügt und damit deren Sorgerecht gestärkt. Die Straßburger Richter gaben einem 45jährigen Kläger aus Köln recht, der seit acht Jahren vergeblich um ein Sorgerecht für seine Tochter kämpft.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5411956/Richter-schuetzen-ledige-Vaeter-vor-deutschem-Recht.html
Krisengipfel im Kanzleramt
Ackermann warnt vor neuem Finanzmarkt-Crash
Beim Krisentreffen im Kanzleramt sprach der Chef der Deutschen Bank Josef Ackermann von tickenden „Zeitbomben“. Damit meint er vor allem kleinere Länder wie Griechenland, die über alle Maßen verschuldet sind. Aber auch die Immobilienkrise in den USA sei noch nicht gelöst, warnte Ackermann die Kanzlerin.
http://www.welt.de/politik/article5412179/Ackermann-warnt-vor-neuem-Finanzmarkt-Crash.html
Krisenvorsorge – Was Sie unbedingt über die globale Finanz- und Wirtschaftskrise wissen sollten ...
http://www.krisenvorsorge.com/
Im Bundestag notiert: Ehrenmal der Bundeswehr in Berlin
Verteidigung/Kleine Anfrage – 23.11.2009
Berlin: Die Fraktion Die Linke will von der Bundesregierung wissen, wie viele verstorbene Bundeswehrsoldaten, die am Ehrenmal der Bundeswehr in Berlin namentlich aufgeführt werden, früher in der Wehrmacht oder der Waffen-SS gedient haben. In ihrer Kleinen Anfrage (17/32) verlangt die Linksfraktion zudem Auskunft darüber, warum bei der Erstellung der Namensliste für das Ehrenmal darauf verzichtet wurde, das Militärgeschichtliche Forschungsamt zu konsultieren, um zu verhindern, daß möglicherweise ehemalige Kriegsverbrecher geehrt werden.
Brandenburg
Platzeck sitzt in der Stasi-Falle
Von Stefan Berg
Und wieder einer: In der neuen rot-roten Koalition in Brandenburg werden inzwischen fast täglich ehemalige Stasi-Mitarbeiter enttarnt. Ministerpräsident Platzeck scheut die Konsequenz – den Koalitionsbruch und Neuwahlen. Wie lange noch?
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,664802,00.html
Meine Ostalgie
Von Thorsten Hinz
Je länger die DDR zurückliegt, desto mehr verspüre ich, wenn von ihr in der Öffentlichkeit die Rede ist, eine merkwürdige Eifersucht auf sie. Und das sogar bei Meldungen wie die über die Stasi-Verstrickungen in der brandenburgischen Landtagsfraktion der Linken.
http://www.jungefreiheit.de/index.php?id=154&tx_ttnews%5Btt_news%5D=85111&tx_ttnews%5BbackPid%5D=154&cHash=d248694d53&MP=154-570
Brutaler Überfall auf pro-NRW-Ratsherrn Nico Ernst in Bonn
http://www.pro-nrw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1450:brutaler-ueberfall-auf-pro-nrw-ratsherrn-nico-ernst-in-bonn&catid=15&Itemid=20
Hier eine ein Jahr alte Verlautbarung der „Antifa“ über Nico Ernst ...
„ProBonn“ gegründet
Biedermänner lassen Tarnung fallen - Vorsitzender ist bekannter Bonner Neonazi
http://www.trend.infopartisan.net/trd1208/t401208.html
Steine, Farbbeutel, Molotowcocktails
Chaoten greifen Polizei, BKA und Zoll an
Brennende Polizei- und Zollautos in Hamburg, Farbbeutel und Molotowcocktails gegen das Bundeskriminalamt in Berlin – Unbekannte haben in der Nacht deutsche Ordnungs- und Sicherheitsorgane zur Zielscheibe gemacht. Linksextreme hatten zuvor im Internet den Dezember als „Aktionsmonat“ ausgerufen.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5421219/Chaoten-greifen-Polizei-BKA-und-Zoll-an.html
Was SPIEGEL-Schreiberlinge so alles für schlechtes Benehmen halten ...
Eklat im Funkhaus
Doherty singt erste Strophe von Deutschlandlied
Die lädierte Vita von Pete Doherty ist um einen Skandal reicher: Bei einem live im Radio übertragenen Konzert eines Bayerischen Jugendsenders benahm sich der Rüpelrocker mal wieder daneben – und stimmte die erste Strophe des Deutschlandliedes an. Man ließ ihn gewähren.
http://www.spiegel.de/panorama/leute/0,1518,664137,00.html
Skandalauftritt
Sender fordert Entschuldigung von Doherty
Pete Doherty sang die erste Strophe des Deutschlandlieds und sorgte so für einen Eklat: Nun verlangt der Bayerische Rundfunk eine Entschuldigung von dem britischen Rocksänger. Große Hoffnungen auf eine Reaktion macht sich jedoch nicht einmal der Sender selbst.
http://www.spiegel.de/panorama/leute/0,1518,664273,00.html#ref=nldt
Skandal-Auftritt
Doherty entschuldigt sich für Deutschlandlied
Der britische Rocksänger Pete Doherty hat sich für das Anstimmen des Deutschlandliedes in einer Live-Sendung des Bayerischen Rundfunks (BR) entschuldigt. Damit kam er einer Forderung des Senders nach. Er sei sich der Kontroverse um das Lied nicht bewußt gewesen. [Welche Kontroverse?]
http://www.welt.de/vermischtes/article5390686/Doherty-entschuldigt-sich-fuer-Deutschlandlied.html
1. Strophe Deutschlandlied
„Skandalauftritt beim Nachwuchsfestival: Pete Doherty provoziert für junge Bands“
http://www.stern.de/kultur/musik/skandalauftritt-beim-nachwuchsfestival-pete-doherty-provoziert-fuer-junge-bands-1525712.html
„Pete Doherty soll sich für Deutschlandlied entschuldigen“
http://www.zeit.de/newsticker/2009/11/30/iptc-bdt-20091130-264-23144922xml
„Auf dem rechten Weg
Doherty – Hymne an Hitler?
MÜNCHEN – Der Ex-Babyshambles-Frontmann schoß den Vogel ab – und sang das Deutschlandlied. Buh!“
http://www.blick.ch/unterhaltung/musik/doherty-hymne-an-hitler-134585
Schweizer stimmen für Minarett-Verbot
In der Schweiz dürfen in Zukunft keine Minarette mehr gebaut werden. Mit der Mehrheit von 57,5 Prozent nahmen die Schweizer bei einer Volksabstimmung eine entsprechende Initiative an. Das Ergebnis kam für die meisten Parteien sowie die Regierung völlig überraschend. Die Wahlbeteiligung war mit rund 54 Prozent unerwartet hoch.
http://www.tagesschau.de/ausland/schweiz144.html
Sorge vor militantem Islam
Schweizer wollen den Bau von Minaretten verbieten
In der Schweiz dürfen in Zukunft keine Minarette mehr gebaut werden. Das geht aus Hochrechnungen einer entsprechenden Volksabstimmung am Sonntag hervor. Danach stand bereits am Mittag fest, daß ein entsprechender Vorstoß einer Gruppe um die national-konservative Schweizerische Volkspartei (SVP) überraschend erfolgreich war.
http://www.welt.de/politik/ausland/article5367424/Schweizer-wollen-den-Bau-von-Minaretten-verbieten.html
Initiative
Schweizer stimmen gegen Minarett-Bau
Überraschendes Votum für ein Minarettverbot: Die Eidgenossen haben in einer Volksabstimmung gegen den Bau von Gebetstürmen auf Moscheen votiert. Zwei rechtspopulistische Parteien hatten die Initiative auf den Weg gebracht.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,664104,00.html
Initiative gegen Minarette
Die Schweiz wählt die Islam-Angst
Ein Kommentar von Mathieu von Rohr
Die Schweizer wollen keine Minarette, eine Mehrheit votierte für ein komplettes Bauverbot. Die Entscheidung ist keine Reaktion auf schwelende Probleme in der Eidgenossenschaft. Sie zeigt tiefsitzende Ängste vor dem Islam – die auch in anderen europäischen Staaten akut sind.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,664135,00.html
Keine Minarette
Von Karlheinz Weißmann
In der Schweiz sollen keine Minarette mehr gebaut werden, so die Entscheidung der Volksabstimmung vom vergangenen Sonntag. Wohlgemerkt, es geht nicht um ein Verbot von Moscheen oder der Ausübung islamischer Religionspraxis, sondern nur darum, daß die Errichtung jener Türme unterbleibt, die man als Triumphzeichen des Islam verstehen kann, die in der Vergangenheit auch an gewaltsam entweihten und für den moslemischen Gottesdienst umgewidmeten Kirchen gebaut wurden.
Was an dem Vorgang noch interessanter ist als die Sache selbst, sind die Kommentare aus der politisch-medialen Klasse. Der Unmut scheint flächendeckend, sieht man ab von den Initiatoren der Schweizerischen Volkspartei (SVP), die ihre Genugtuung kaum verbergen, ist alles von der Fatalität des Entscheids überzeugt. Die Schweizer Grünen erwägen den Gang zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, um den eigenen demos zu verklagen, die Sprecherin der Berner Regierung sieht diplomatische Schwierigkeiten voraus, die Wirtschaft fürchtet ökonomische Einbußen.
http://www.sezession.de/9480/keine-minarette.html#more-9480
Broder: Schweizer haben sich gegen die Islamisierung entschieden
Der Publizist Henryk M. Broder hat das Ergebnis der Volksabstimmung über ein Minarettverbot in der Schweiz als Votum gegen die „Appeaser“ in Politik und Medien bewertet. Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Armin Laschet nannte es dagegen ein Glück, daß es in Deutschland keine Volksabstimmungen gebe.
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M52e2b02fd68.0.html
Keine Demokraten
Von Martin Lichtmesz
Neulich war an dieser Stelle von einem Comic die Rede, in dem über „Extremismus“ und „Demokratie“ aufgeklärt werden soll. Meine Lieblingsszene im Band über „Rechtsextremismus“ ist die, in der die bauchnabelfreie blonde Magda mit dem Keltenkreuz um den Hals ihre Lehrerin provokant fragt: „Ist ja eine tolle Demokratie, in der niemand seine Meinung sagen darf. Was ist denn mit der Meinungsfreiheit in diesem System?“ Darauf antwortet die Lehrerin: „Wer verbietet denn jemandem eine Meinung hier? Man sollte aber die Meinungsfreiheit nicht dazu ausnutzen, die Grundprinzipien der Demokratie auszuhebeln.“
http://www.sezession.de/9486/keine-demokraten.html#more-9486
Schweizer U-17-Star schwärmt für Islamisten
Das Schweizer U-17-Stürmertalent sowie Weltmeister Nassim Ben Khalifa äußerte sich öffentlich darüber, daß er den umstrittenen Muslim-Führer Tariq Ramadan toll finde. Tariq Ramadan ist der Enkel des Gründers der radikalislamischen Muslimbruderschaft. Dieser wurde kürzlich sogar im muslimisch überbereicherten Rotterdam von seinem Posten als „Integrationsberater“ entlassen, weil ans Licht gekommen war, daß er im Programm eines staatlich-iranischen Fernsehsenders des Diktators mitgewirkt hatte.
http://www.pi-news.net/2009/11/schweizer-u-17-star-schwaermt-fuer-islamisten/
Erste Proteste gegen Schweiz
Islamische Welt entsetzt über Minarett-Verbot
Von Hasnain Kazim und Daniel Steinvorth
Demonstrationen in Pakistan, ein wütender türkischer Kulturminister: In der islamischen Welt wird der Schweizer Minarett-Stopp kritisiert. Politiker erwarten massive Proteste, ein Imam in Genf ruft zur Besonnenheit auf – und die Uno schaltet sich ein. Sie will das Verbot auf Rechtmäßigkeit prüfen.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,664337,00.html
Entscheidung in der Schweiz
Erdogan sieht Minarett-Votum als Zeichen von Faschismus
„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, „klar diskriminierend“: Das Schweizer Votum gegen den Neubau von Minaretten hat international einen Proteststurm entfacht. Der türkische Ministerpräsident wütet gegen eine „faschistische Haltung“ in Europa. Die Eidgenossen fürchten um ihre Sicherheit.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,664551,00.html#ref=nldt
Erdogan: Schweizer Entscheidung ist faschistisch
So spricht ausgerechnet jener, der folgendermaßen zitiert wird: „Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten.” Und da wundert sich der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan, daß die Schweizer das Spielchen nicht mitmachen wollen?
http://www.pi-news.net/2009/12/erdogan-schweizer-entscheidung-ist-faschistisch/
Türkischer Minister ruft zu Schweiz-Boykott auf
Wohlhabende Muslime auf der ganzen Welt sollen ihr Vermögen aus der Schweiz abziehen und in der Türkei anlegen. Das fordert der türkische Europaminister Egemen Bagis als Konsequenz aus dem Minarettverbot. Schließlich hätten türkische Banken der internationalen Finanzkrise widerstanden.
http://www.welt.de/politik/ausland/article5402343/Tuerkischer-Minister-ruft-zu-Schweiz-Boykott-auf.html
Bauverbot für Minarette
Türkei droht Schweiz
http://www.abendblatt.de/politik/ausland/article1293477/Tuerkei-droht-Schweiz.html
Schweiz wird Feindbild für die arabische Welt
http://nachrichten.rp-online.de/article/politik/Schweiz-wird-Feindbild-fuer-die-arabische-Welt/60389
Unverständnis über Minarett-Votum
Regisseur Fatih Akin boykottiert die Schweiz
http://www.rp-online.de/gesellschaft/leute/Regisseur-Fatih-Akin-boykottiert-die-Schweiz_aid_791067.html
Minarettverbot: Sarrazin kritisiert Medien
BERLIN. Bundesbankvorstand Thilo Sarrazin hat anläßlich der Schweizer Volksabstimmung über ein Bauverbot von Minaretten Politik und Medien kritisiert: Das Volksbegehren zeige, „daß in der Tiefe der Gesellschaft anders gedacht wird, als die politische Klasse und die Mehrheit der Medien glauben wollen“, sagte Sarrazin dem Handelsblatt.
http://www.jungefreiheit.de/index.php?id=154&tx_ttnews[tt_news]=85088&cHash=266d89b5e2
Online-Petition an den Deutschen Bundestag
Einsetzen einer Enquete-Kommission „Zuwanderung, Staatsbürgerschaft und Integration“
http://www.meideu.de/petition
Bundesbank
Sarrazins türkenfeindliche Tiraden lösen Entsetzen aus
Von Anne Seith, Frankfurt am Main
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,652571,00.html
„Aufstand der Anständigen“ ...
Proteste gegen den Anti-Minarett-Entscheid
Tausende demonstrieren in mehreren Städten der Westschweiz
http://www.nzz.ch/nachrichten/wissenschaft/protest_gegen_den_volksentscheid_gegen_minarette_1.4092368.html
Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland Stephan Kramer wettert gegen die Schweizer
http://www.pi-news.net/2009/12/kramer-wettert-gegen-die-schweizer/#more-102420
Armin Laschet (CDU) beleidigt Schweizer Verfassung
„Der Islam gehört zu uns“
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2009-11/minarett-streit-laschet
Cohn-Bendit
Muslime sollen Gelder aus Schweiz abziehen
http://www.20min.ch/news/schweiz/story/Muslime-sollen-Gelder-aus-Schweiz-abziehen-12731911
http://www.pi-news.net/2009/12/laschet-beleidigt-schweizer-verfassung/
Die Luft wird dünner für Oberlehrer
Wer einmal einen deutschen Oberlehrer in Hochform erleben wollte, der mußte heute „Das Duell bei n-tv“ einschalten. Dort wurde Sebastian Edathy installiert, der beim Publikum Heiterkeit erzeugte, dessen hohle Sprechblasen („die meisten Ängste vor dem Islam sind irrational“) Empörung auslösten und der uns zeigt, warum die SPD auf dem Weg zum Projekt 18 ist und ihr Image als Volkspartei schon lange verloren hat. In Alexander Gauland hat er einen würdigen Gegner gefunden. Schwätzer Edathy wird auch von Diskussionsleiter Heiner Bremer in seiner zügellosen volkspädagogischen Schulmeisterei gut gekontert.
http://www.pi-news.net/2009/12/die-luft-wird-duenner-fuer-oberlehrer/#more-102386
„Jungle World“ zur Ausländerdebatte in Frankreich
Republik der Schleimer
http://jungle-world.com/artikel/2009/48/39869.html
Larmoyanz und Verwesung
Von Martin Böcker
Riechen wir noch nichts von der nationalen Verwesung? Auch Nationen verwesen. Deutschland ist tot. Deutschland müßte tot sein. Und wir hätten es getötet, wenn es wirklich in dem Zustand wäre, den wir herbeizittern: harmlos, wehrlos, alt.
Wie trösten wir uns – wir, die wir totreden, was nur totzureden geht?
http://www.sezession.de/9471/larmoyanz-und-verwesung.html
Deutsche Täter, deutsche Opfer – eine Antwort auf Martin Böcker
Wenn mir auch der Grundtenor von Martin Böckers polemischem Debüt auf Sezession im Netz sympathisch ist, so ist mir doch unklar, wen genau er nun weswegen attackiert. Vor allem scheint mir die Perspektive, von der er aus seine Attacke reitet, korrekturbedürftig zu sein
http://www.sezession.de/9662/deutsche-taeter-deutsche-opfer-eine-antwort-auf-martin-boecker.html
In Europa wächst Skepsis gegenüber Migranten
Von Karen Merkel
Der German Marshall Fund hat untersucht, wie Europäer und Amerikaner ihre Einwanderer beurteilen. Ergebnis: Immer mehr Menschen stehen Migranten skeptisch gegenüber. Wenn es Probleme bei der Integration gibt, sehen viele die Einwanderer in der Pflicht. Diese Meinung ist vor allem in Deutschland verbreitet.
http://www.welt.de/politik/ausland/article5415523/In-Europa-waechst-Skepsis-gegenueber-Migranten.html
Klischee oder Kultur?
Integration: Multikulti in Soaps ist immer mehr im Kommen – Gratwanderung zwischen Realität und Überspitzung
http://www.main-netz.de/nachrichten/kultur/kultur/art4214,1013377
Verdacht auf Spendenbetrug
Bundesweite Razzia gegen Milli Görüs
Razzia bei der größten islamischen Organisation Deutschlands: Bundesweit sind Dutzende Büros von Milli Görüs gefilzt worden. Es bestehe der Verdacht auf Spendenbetrug, erklärte die Staatsanwaltschaft.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,664727,00.html
Berlin: Körting will Flüchtlinge nicht abschieben
Sie leben teilweise schon viele Jahre in der Bundesrepublik. Sie kamen seinerzeit, weil sie in Krisengebieten um ihr Leben fürchten mußten oder politisch verfolgt wurden. Für ca. 30.000 in Deutschland lebende Flüchtlinge heißt es Ende des Jahres Abschied nehmen. Insbesondere für die, die es auch nach vielen Jahren nicht geschafft haben, sich ohne Unterstützung des Steuer-Michel selbst zu ernähren. Genau das will der Berliner SPD-Innensenator Körting (Foto) jetzt verhindern.
http://www.pi-news.net/2009/11/berlin-koerting-will-fluechtlinge-nicht-abschieben/
Union erwägt Verlängerung des Bleiberechts
BREMEN. Die Union will offenbar die Bleiberechtsfrist für geduldete Ausländer um zwei Jahre verlängern. Nach einem Bericht des „Weser-Kuriers“ hätten die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sowie die unionsgeführten Bundesländer einen entsprechenden Vorschlag erarbeitet, der beim Treffen der Innenminister von Bund und Ländern in dieser Woche diskutiert werden solle.
http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display.154+M592278a243e.0.html
Offenbacher Ordnungsamt will notorischen Nichtzahlern das ungeahndete Falschparken erschweren
Bis zu 96 Knöllchen ignoriert
[Man sollte sich durch den Hinweis auf den Deutschen nicht von den eigentlichen Haupt-Tätergruppen ablenken lassen]
http://www.op-online.de/nachrichten/offenbach/knoellchen-ignoriert-547365.html
Offenbach
36jähriger verurteilt wegen Kreditbetrugs
Gehalt frisiert
[Dubiose Geschäfte von Balkan-Einwanderern]
http://www.op-online.de/nachrichten/offenbach/gehalt-frisiert-546837.html
Das Hobby eines grünen Fahnenpinklers
Der 24jährige Student Ario Ebrahimpour Mirzaie bringt alle nötigen Voraussetzungen mit, eines Tages mal ein richtig großer Politiker zu werden, solange wenigstens wie der Multikulturalismus noch als die vorherrschende bundesrepublikanische Staatsdoktrin gilt. Er hat mohammedanischen MiHiGru (Migrationshintergrund), studiert in Berlin Politikwissenschaft, haßt grundsätzlich alles was mit „deutsch“ zu tun haben könnte.
http://www.pi-news.net/2009/11/das-hobby-eines-gruenen-fahnenpinklers/
Ario Ebrahimpour Mirzaie – Rede auf der Europa-BDK in Dortmund zur Zukunft der EU
http://www.youtube.com/watch?v=tUL04A0Xk4Y
Wohnideen für „Weltbürger“ ...
Schiffscontainer
Der neue Wohn-Trend
http://www.faz.net/s/Rub8E0FC0CD826A4ACA80504FD9153A70F2/Doc~E85D3CD207382448A8F2399C47044CFA7
00:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journaux, allemagne, médias, actualités, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



