Alessandra COLLA - http://www.alessandracolla.net/
Archives: 1994
 Negli scritti di Nietzsche, è stato detto, si può trovare tutto e il contrario di tutto. Questa pretesa contraddizione interna del grande pensatore ha fornito materiale in quantità per molte opere — talvolta critiche talvolta denigratorie — che hanno accompagnato negli anni la fortuna del filosofo senza, peraltro, mai scalfirne il nòcciolo.
Negli scritti di Nietzsche, è stato detto, si può trovare tutto e il contrario di tutto. Questa pretesa contraddizione interna del grande pensatore ha fornito materiale in quantità per molte opere — talvolta critiche talvolta denigratorie — che hanno accompagnato negli anni la fortuna del filosofo senza, peraltro, mai scalfirne il nòcciolo.
In mezzo alla feconda complessità dei temi trattati, emergono però alcuni aspetti interessanti e solitamente poco noti ai più. Vogliamo qui accennarne qualcuno, almeno per suggerire nuove curiosità.
L’UOMO CHE VISSE DIETRO LA SIEPE
… questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
(G. Leopardi, L’infinito, 1819)
Il XVIII secolo sta per finire quando, nel 1798, nasce a Recanati Giacomo Taldegardo Francesco Leopardi, figlio del conte Monaldo e della marchesa Adelaide Antici. Autentico bambino prodigio, all’età di undici anni Giacomo si ritrova senza precettore: sa già tutto quello che c’è da sapere, e non c’è nessuno in grado di seguirlo negli studi. Con la beata incoscienza della sua età, il primogenito di casa Leopardi continua da solo. Da solo impara il greco, l’ebraico, il francese, l’inglese e lo spagnolo; padrone, a soli quindici anni, di tante lingue vive e morte, sviluppa a quest’età l’amore per gli studi filologici: le grammatiche e le sintassi non hanno più per lui alcun segreto, ed ora è finalmente libero di cogliere nella loro pienezza i tesori che si celano dietro l’aridità apparente delle forme verbali e delle declinazioni.
Il 1816 segna una svolta di importanza capitale nella vita e nel pensiero di Leopardi: è in quest’anno, infatti, che il giovane scopre le lettere e la poesia, sulle quali riversa la passione finora consacrata all’erudizione e alla disciplina filologica. Dello stesso anno è anche la prima, e non la più grave, delle molte crisi fisiche e nervose che travaglieranno la sua breve vita: con orrore e certo senza rassegnazione, Giacomo intuisce di aver definitivamente minato la sua già gracile costituzione con un’applicazione mentale eccessiva. Ad aggravare la situazione psicologica del giovane sopraggiunge, sul finire dell’anno, il breve soggiorno in casa Leopardi della bella cugina Gertrude Cassi sposata Lazzari: scoppia la prima infatuazione amorosa, tutta platonica e ovviamente unilaterale, di Giacomo, che recita qui per la prima volta il copione dell’amore illuso e deluso — lo ripeterà per tutta la vita.
Il suo stato d’animo non migliora affatto. In una celebre, drammatica lettera all’amico scrittore Pietro Giordani, datata 2 marzo 1818, Leopardi lascia sgorgare senza pudori tutta la sua amarezza profonda e inconsolabile: «[…] in somma io mi sono rovinato con sette anni di studio matto e disperatissimo in quel tempo che mi s’andava formando e mi si doveva assodare la complessione. E mi sono rovinato infelicemente e senza rimedio per tutta la vita, e rendutomi l’aspetto miserabile, e dispregevolissima tutta quella gran parte dell’uomo, che è la sola a cui guardino i più; e coi più bisogna conversare in questo mondo». Nel settembre dello stesso anno il Giordani, allarmato dalle parole del giovane, lo raggiunge a Recanati per condurlo con sé a Macerata: un viaggio di ben pochi chilometri — il primo in assoluto di Giacomo, allora ventenne. L’impatto con una dimensione estranea a quella del sonnolento “borgo natio” e la consapevolezza di un mondo vasto e sconosciuto destinato a restare fuori dalla sua portata non fanno che aumentare l’inquietudine di Leopardi, che si sente (e sa di essere davvero) profondamente diverso dagli altri, e anela alla gloria.
Nella primavera del 1819 la sua già malferma salute va peggiorando: un esaurimento fisico generale lo prostra, e si manifestano i primi disturbi agli occhi che gli impediscono di leggere per quasi un anno e che, d’ora in poi, lo accompagneranno per tutta la vita. Questo episodio rientra a pieno titolo fra i motivi scatenanti di quel pessimismo assoluto che diverrà cifra e referente del pensiero leopardiano (1).
Corollario inevitabile di questo crollo di ogni illusione è la perdita della fede religiosa; per compensare la quale il Leopardi si getta nell’elaborazione di un suo sistema filosofico — una sorta di materialismo pessimistico radicale sull’onda, paradossalmente, delle suggestioni illuministiche. Se infatti l’illuminismo tracciava il disegno grandioso di un progresso inarrestabile volto a condurre l’umanità intera verso luminosi e necessari destini, per il Leopardi le istanze deterministiche e la constatazione di uno “stato di natura” suggeriscono piuttosto l’idea di un decadimento dell’uomo dalle altezze dell’età antica alle bassure di quella moderna; e la civiltà, lungi dal rappresentare il punto d’arrivo dell’evoluzione umana, si configura invece come l’allontanamento dell’uomo dalla beata condizione naturale, unica e sola in grado di garantire la felicità — cioè l’assenza o la cessazione del dolore (secondo la scuola stoica prediletta dal poeta-filosofo). Il grande passo è compiuto: da qui in avanti il Leopardi alternerà meditazioni filosofiche a composizioni poetiche, per approdare, dopo un silenzio durato cinque anni (dal 1823 al 1828), alla sublime fusione di sostanza filosofica e forma poetica. Sempre più minato nel fisico, trascinerà un’esistenza sofferente, alleviata soltanto dalle cure assidue e affettuose di pochi amici, fino alla morte, sopravvenuta il 14 giugno 1837 a Napoli, in casa dell’amico Antonio Ranieri.
IL POETA E IL FILOSOFO: AFFINITÀ ELETTIVE
È un destino singolare, come si vede, quello che accomuna Giacomo Leopardi e Friedrich Nietzsche: entrambi sono stati mutilati dalla critica, contemporanea e successiva, in gran parte della loro opera — si sa che il Leopardi è noto, apprezzato e studiato come poeta, ma per lo più ignorato come filosofo, mentre Nietzsche è giudicato a buon diritto un gigante del pensiero ma poco più che un semplice dilettante nel campo delle arti. Eppure, come pochi ormai si azzardano a negare, la verità è molto diversa.
Ma le somiglianze non finiscono qui. Sia l’italiano inquieto che il riservato tedesco iniziano il loro percorso intellettuale sui testi di filologia, anche se per motivi dìversi: il piccolo Giacomo perché la pur nutrita biblioteca paterna non era in grado di offrire più niente a un bambino così sorprendentemente dotato; il giovane Federico perché la formazione ricevuta nel prestigioso istituto di Pforta gli aveva rivelato le immense possibilità speculative legate allo studio del mondo classico e delle sue lingue. Inoltre, entrambi furono costretti a viaggiare molto, ed entrambi per questioni di sopravvivenza, soggiornando addirittura negli stessi luoghi; entrambi furono di salute assai cagionevole, soffrendo persino degli stessi disturbi; entrambi trovarono l’ultimo conforto nella vicinanza di amici fedeli e disinteressati; e, per finire, il pensiero di entrambi è stato spesso snaturato e stravolto così da renderli invisi non soltanto a generazioni di studenti, ma anche a molti seri studiosi irrimediabilmente viziati nell’interpretazione dei loro testi.
La complementarità dei loro destini li rende simili al di là delle differenze oggettive, portandoli verso un unico sentire e un’identica visione della vita, tanto che sarà proprio Leopardi ad anticipare alcune delle più brillanti e rivoluzionarie intuizioni di Nietzsche.
Il pensatore di Röcken conosceva, almeno in parte, il Leopardi: sappiamo che nella biblioteca di Nietzsche figuravano due traduzioni tedesche di Leopardi, ad opera dello Hamerling e dello Heyse; sicuramente vi erano compresi i Canti, che il poeta italiano scrisse a partire dal 1818, lo Zibaldone e molto probabilmente le Operette morali. Ed è lo stesso Nietzsche a menzionare il Leopardi, anche se di passata e in modo non proprio lusinghiero: «Gli infelici raffinati, come Leopardi, che dalla loro sofferenza traggono orgogliosamente vendetta su tutta l’esistenza, non si accorgono come il divino mezzano dell’esistenza rida di loro: proprio così essi ora berranno di nuovo dalla sua coppa; infatti la loro vendetta, il loro orgoglio, la loro inclinazione a pensare tutto quanto soffrono, la loro arte nel dirlo: tutto questo non è di nuovo — dolce miele?» (2).
Alla luce di un’attenta lettura del poeta italiano e del filosofo tedesco, è innegabile che le influenze del primo sul secondo esistano, e siano ben documentabili. Confrontiamo, ad esempio, Il sabato del villaggio e La sera del dì di festa (composte entrambe nel settembre 1829) con un frammento di Nietzsche. Il Leopardi scrive:
«[…] intanto riede alla sua parca mensa,
fischiando, il zappatore,
e seco pensa al dì del suo riposo.
Poi, quando intorno è spenta ogni altra face,
e tutto l’altro tace,
odi il martel picchiare, odi la sega
del legnaiuol, che veglia
nella chiusa bottega alla lucerna,
e s’affretta, e s’adopra
di fornir l’opra anzi il chiarir dell’alba.
Questo di sette è il più gradito giorno,
pien di speme e di gioia:
diman tristezza e noia
recheran l’ore, ed al travaglio usato
ciascuno in suo pensier farà ritorno» (3).
E ancora:
«[…] Ahi, per la via
odo non lunge il solitario canto
dell’artigian che riede a tarda notte,
dopo i sollazzi, al suo povero ostello;
e fieramente mi si stringe il core,
a pensar come tutto al mondo passa,
e quasi orma non lascia. Ecco è fuggito
il dì festivo, ed al festivo il giorno
volgar succede, e se ne porta il tempo
ogni umano accidente. […]» (4).
Quello che segue, invece, è il testo nietzscheano:
«Il pomeriggio del sabato si deve passare per un villaggio, se si vuol vedere sui volti dei contadini la vera quiete del dì di festa: allora essi hanno ancora indelibata davanti a sé la giornata di riposo e si industriano a far ordine e pulizia in suo onore con una specie di piacere anticipato, quale non sarà raggiunta dal piacere stesso. La domenica è già quasi lunedì» (5).
Oppure si paragonino questi due brani:
«Ogni grande amore porta con sé il crudele pensiero di uccidere l’oggetto dell’amore, perché sia sottratto una volta per tutte al sacrilego giuoco del mutamento: giacché di fronte al mutamento l’amore inorridisce più che di fronte alla distruzione»;
«Il veder morire una persona amata, è molto meno lacerante che il vederla deperire e trasformarsi nel corpo e nell’animo da malattia (o anche da altra cagione)».
Il primo è di Nietzsche (6), mentre il secondo è di Leopardi (7).
Con un minimo di attenzione, è facilissimo trovare, sparsi qua e là nello Zibaldone senza un ordine fisso, ma sull’onda di meditazioni e concatenamenti apparentemente confusi che fanno delle elaborazioni leopardiane un autentico “pensiero in movimento” destinato ad arrestarsi soltanto con la morte, intuizioni e abbozzi di teorie poi ripresi e sviluppati compiutamente da Nietzsche nell’arco di pochi decenni, e che nella prosa densa del Leopardi spiccano in tutta la loro grandezza.
Così alcuni notevoli passi che anticipano la Genealogia della morale sono del 4-5 settembre 1821: «La legge naturale varia secondo le nature. Un cavallo che non è carnivoro giudicherà forse ingiusto un lupo che assalga e uccida una pecora, l’odierà come sanguinario, e proverà un senso di ribrezzo e d’indignazione abbattendosi a vedere qualche sua carnificina. Non così un lione. Il bene e il male morale non ha dunque nulla di assoluto. Non v’è altra azione malvagia, se non quelle che ripugnano alle inclinazioni di ciascun genere di esseri operanti: né sono malvage quelle che nocciono ad altri esseri, mentre non ripugnino alla natura di chi le eseguisce» (8); «Si suol dire che tutte le cose, tutte le verità hanno due facce, diverse o contrarie, anzi infinite. Non c’è verità che prendendo l’argomento più o meno da lungi, e camminando per una strada più o meno nuova, non si possa dimostrar falsa con evidenza ec. ec. ec. Quest’osservazione (che puoi molto specificare ed estendere) non prova ella che nessuna verità né falsità è assoluta, neppure in ordine al nostro modo di vedere e di ragionare, neppur dentro i limiti della concezione e ragione umana?» (9); «Da ciò che si è detto della legge pretesa naturale, risulta che ne vi è bene né male assoluto di azioni; ci queste non sono buone o cattive fuorché secondo le convenienze, le quali son stabilite, cioè determinate dal solo Dio ossia, come diciamo, dalla natura; che variando le circostanze, e quindi le convenienze, varia ancora la morale, né v’è legge alcuna scolpita primordialmente ne’ nostri cuori; che molto meno v’è una morale eterna e preesistente alla natura delle cose, ma ch’ella dipende e consiste del tutto nella volontà e nell’arbitrio di Dio padrone sì di stabilire quelle determinate convenienze che voleva […]. Da tutto ciò resta spiegata la differenza fra la legge che corse prima di Mosè, quella di Mosè, e quella di Cristo. […] L’antica legge Ebraica permetteva il concubinato, fuorché colle donne forestiere ec. L’odio del nemico costituiva lo spirito delle antiche nazioni. Ecco le leggi di Mosè tutte patriottiche, ecco santificate le invasioni, le guerre contro i forestieri, proibite le nozze con loro, permesso anche l’odio del nemico privato. E Gesù comandando l’amor del nemico, dice formalmente che dà un precetto nuovo. Come ciò, se la morale è eterna e necessaria? Come è male oggi, quel ch’era forse bene ieri? Ma la morale non è altro che convenienza, e i tempi avevano portato nuove convenienze. Questo discorso potrebbe infinitamente estendersi generalizzando sullo stato del mondo antico e moderno, e sulla differente morale adattata a questi diversi stati. L’uomo isolato non aveva bisogno di morale, e nessuna ne ebbe infatti, essendo un sogno la legge naturale. Egli ebbe solo dei doveri d’inclinazione verso se stesso, i soli doveri utili e convenienti nel suo stato. Stretta la società, la morale fu convenienza, e Dio la diede all’uomo appoco appoco, o piuttosto ora una ora un’altra, secondo i successivi stati della società: e ciascuna di queste morali era ugualmente perfetta, perché conveniente; e perfetto è l’uomo isolato, senza morale» (10).
Un rilievo del 1823 sembra attagliarsi perfettamente a certe considerazioni contenute nell’Anticristo: «Persone imperfette, difettose, mostruose di corpo, tra quelle che non arrivano a nascere e […] tra quelle che son tali dalla nascita […]; quelle che così nate vivono e […] quelle finalmente che tali son divenute dopo la nascita […]; sommando dico e raccogliendo tutti questi individui insieme, si vedrà a colpo d’occhio e senza molta riflessione che il loro numero nel solo genere umano, anzi nella sola parte civile di esso, avanza di gran lunga non solamente quello che trovasi in qualsivoglia altro intero genere d’animali, non solamente eziandio quello che veggiamo in ciascheduna specie degli animali domestici, che pur sono corrotti e mutati dalla naturale condizione e vita, e da noi in mille guise travagliati e malmenati; ma tutto insieme il numero degl’individui difettosi e mostruosi che noi veggiamo in tutte le specie di animali che ci si offrono giornalmente alla vista, prese e considerate insieme. La qual verità è così manifesta, che niuno, io credo, purché vi pensi un solo momento e raccolga le sue reminiscenze, la potrà contrastare. Simile differenza si troverà in questo particolare fra le nazioni civile e le selvagge, e proporzionatamente fra le più civili e le meno, secondo un’esatta scala» (11). Di questa lunga citazione merita, a nostro avviso, sottolineare anche l’accenno agli animali, che è una costante del Leopardi: la sua attenzione nei confronti della natura e degli esseri viventi è continua e delicata, comprendendo ogni forma di vita nel mistero del dolore universale e del pessimismo cosmico. Anche questo è un tratto (e non dei minori) che lo accomuna a Nietzsche.
Sempre nell’Anticristo, troviamo invece una frase illuminante del filosofo tedesco: «Se si avesse nel petto una qualche misura, anche esigua, di religiosità, un Dio che cura al momento giusto il raffreddore o che ci fa salire in carrozza nel preciso istante in cui si scatena un acquazzone dovrebbe essere per noi tanto assurdo, che occorrerebbe eliminarlo anche nel caso in cui esistesse. Un Dio come domestico, come portalettere, come venditore d’almanacchi — una sola parola, in fondo, per indicare la specie più stupida tra tutte le circostanze fortuite…» (12). Il riferimento alla celebre operetta morale che il Leopardi scrisse nel 1832, e intitolata appunto Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, ci sembra assolutamente fuor di dubbio: nel Dialogo, il poeta immagina l’incontro fra un “passeggere” e un venditore di calendari che propone al passante l’acquisto di un calendario per l’anno nuovo. Il passante si informa se l’anno nuovo sarà o no migliore del precedente, e il venditore risponde di sì; ma il passante incalza, e vuole sapere a quale degli ultimi vent’anni potrebbe essere paragonato l’anno nuovo in quanto a bontà; il venditore annaspa, travolto dalla stupidità dei luoghi comuni che il passante gli sciorina uno dietro l’altro, e il dialogo si conclude col timido “speriamo…” del venditore che non può fare altro che rifilare al passante un calendario qualsiasi, nell’illusione che il futuro sarà comunque migliore del passato. Eccolo qua, il Dio schernito da Nietzsche: un Dio buono per tutte le stagioni, che porterà il sole al villeggiante e la pioggia al contadino, la pace a chi combatte e la guerra al mercante d’armi — proprio un Dio che, se davvero esistesse, andrebbe eliminato.
Non sono — ovviamente — tutti qui i paralleli fra il poeta-filosofo e il filosofo-poeta. L’argomento meriterebbe ben più di qualche cenno frettoloso, ma sappiamo che l’insofferenza di troppi per la poesia leopardiana non è certo né il minore né l’ultimo dei guasti fatti dalla scuola italiana. Per chiudere in bellezza, scegliamo l’insegnamento supremo di Zarathustra il Distruttore: «Uomini superiori, imparatemi - a ridere!» (13), adombrato in uno degli ultimi appunti dello Zibaldone: «Terribile e awful è la potenza del riso; chi ha il coraggio di ridere, è padrone degli altri, come chi ha il coraggio di morire» (14).
(testo apparso originariamente sulla rivista “Origini”,
numero monografico su Friedrich Nietzsche, 1994)
NOTE
(1) Lui stesso descriverà così l’avvenuto mutamento, in un’annotazione datata 1 luglio 1820: «Sono stato sempre sventurato, ma le mie sventure d’allora erano piene di vita, e mi disperavano perché mi pareva […] che m’impedissero la felicità, della quale gli altri credea che godessero. […] La mutazione totale in me […] seguì […] nel 1819 dove privato dell’uso della vista, e della continua distrazione della lettura, cominciai […] a divenir filosofo di professione (di poeta ch’io era), a sentire l’infelicità certa del mondo» (Giacomo Leopardi, Zibaldone, Oscar Mondadori, Milano 1972, vol. 1, p. 118).
(2) Friedrich Nietzsche, Umano, troppo umano (e scelta di frammenti postumi), Oscar Mondadori, Milano 1976, vol. II, fr. 38 [2], p. 273.
(3) G. Leopardi, Il sabato del villaggio, vv. 28-42.
(4) Idem, La sera del dì di festa, vv. 24-33.
(5) F. Nietzsche, Umano…, cit., fr. 45 [3], p. 286.
(6) Ivi, fr. 280. p. 95.
(7) G. Leopardi, Zibaldone, cit., p. 290 (8 gennaio 1821).
(8) Idem, Zibaldone, cit., vol. II, p. 582 (4 settembre 1821).
(9) Ivi, p. 585 (5 settembre 1821).
(10) Ivi, pp. 587-589 (5 settembre 1821).
(11) Ivi, p. 844 (28 luglio 1823).
(12) F. Nietzsche, L’Anticristo. Maledizione del cristianesimo, Adelphi, Milano 1977, par. 52, p. 75.
(13) F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano 1973, p. 359 (“Dell’uomo superiore” - 20, 25).
(14) G. Leopardi, Zibaldone, cit., vol. II, p. 1160 (23 settembre 1828).
(© Alessandra Colla, Prima che Nietzsche venisse, 1994, in “Origini - Nietzsche”, 2006)





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg Chiunque abbia a cuore il superamento del presente sistema liberaldemocratico, imperniato sul tradimento dei popoli a vantaggio del potere finanziario mondiale, e chiunque voglia agire nel nome di valori di socialità condivisa, di solidarismo anti-utilitario e di eredità bio-storica, non può seriamente prendere in considerazione l’opzione costituita dalle varie Destre oggi all’opera. Esse sono, senza eccezioni, colonne portanti del liberismo e dello sgretolamento identitario.
Chiunque abbia a cuore il superamento del presente sistema liberaldemocratico, imperniato sul tradimento dei popoli a vantaggio del potere finanziario mondiale, e chiunque voglia agire nel nome di valori di socialità condivisa, di solidarismo anti-utilitario e di eredità bio-storica, non può seriamente prendere in considerazione l’opzione costituita dalle varie Destre oggi all’opera. Esse sono, senza eccezioni, colonne portanti del liberismo e dello sgretolamento identitario.  Le idee politiche sono paragonabili a quei fiumi “carsici” che nei loro tortuosi e rapidi percorsi sprofondano nelle viscere delle montagne per riaffiorare, poi e a distanza di molti chilometri, improvvisamente e più impetuosi di prima.
Le idee politiche sono paragonabili a quei fiumi “carsici” che nei loro tortuosi e rapidi percorsi sprofondano nelle viscere delle montagne per riaffiorare, poi e a distanza di molti chilometri, improvvisamente e più impetuosi di prima. 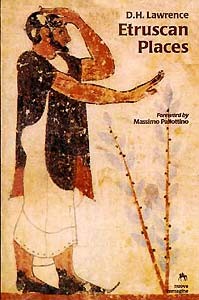 C’est à la fin du VIIe siècle avant la naissance du Christ qu’apparaît en Toscane une population que les Latins appelleront Tusci ou Etrusci, dont les origines continuent de rester énigmatiques. On suggère aujourd’hui que la culture étrusque est née d’un ancien substrat local qui s’est lentement modifié au cours des différentes vagues de population s’installant en Italie, tandis que l’hypothèse qui prévalait au début du siècle passé rejoignait le récit d’Hérodote, d’après lequel ce peuple serait venu par la mer de Lydie.
C’est à la fin du VIIe siècle avant la naissance du Christ qu’apparaît en Toscane une population que les Latins appelleront Tusci ou Etrusci, dont les origines continuent de rester énigmatiques. On suggère aujourd’hui que la culture étrusque est née d’un ancien substrat local qui s’est lentement modifié au cours des différentes vagues de population s’installant en Italie, tandis que l’hypothèse qui prévalait au début du siècle passé rejoignait le récit d’Hérodote, d’après lequel ce peuple serait venu par la mer de Lydie.  Lawrence, suivant en cela la leçon d’un nombre incalculable d’auteurs mais sans toutefois tomber dans le délire de certains qui, comme Keyserling, fonda à Darmstadt en 1920 une École de la Sagesse dénonçant les limites de la culture occidentale et puisant son enseignement de pacotille dans une Inde fantasmée, confère au monde ancien une vertu éminente : au contraire de ce que nous pouvons constater à notre époque de spécialistes qui poussent de grands cris dès qu’un esprit un peu audacieux essaie de créer des passerelles entre plusieurs domaines de savoir, le monde ancien ne craignait pas d’établir des parentés symboliques, donc réelles, entre les êtres vivants et les choses, reliés par un flux souterrain de sang (5). «Merveilleux monde, écrit ainsi Lawrence, qu’était sans doute ce monde ancien où toutes choses semblaient vivantes, luisantes dans l’ombre crépusculaire du contact qui les faisait se toucher, un monde où chaque chose n’était pas seulement une individualité isolée prise au piège de la lumière diurne; où chaque chose apparaissait en son clair contour, visuellement, mais qui du sein de sa clarté même était reliée par des affinités émotionnelles ou vitales à d’autres choses étranges, une chose surgissant d’une autre, mentalement contradictoires qui fusionnaient dans l’émotion, si bien qu’un lion pouvait au même instant être aussi une chèvre, et ne pas être une chèvre [Lawrence a évoqué précédemment la chimère en bronze d’Arezzo, conservée au musée de Florence et qui fut en partie restaurée par Benvenuto Cellini)» (p. 142).
Lawrence, suivant en cela la leçon d’un nombre incalculable d’auteurs mais sans toutefois tomber dans le délire de certains qui, comme Keyserling, fonda à Darmstadt en 1920 une École de la Sagesse dénonçant les limites de la culture occidentale et puisant son enseignement de pacotille dans une Inde fantasmée, confère au monde ancien une vertu éminente : au contraire de ce que nous pouvons constater à notre époque de spécialistes qui poussent de grands cris dès qu’un esprit un peu audacieux essaie de créer des passerelles entre plusieurs domaines de savoir, le monde ancien ne craignait pas d’établir des parentés symboliques, donc réelles, entre les êtres vivants et les choses, reliés par un flux souterrain de sang (5). «Merveilleux monde, écrit ainsi Lawrence, qu’était sans doute ce monde ancien où toutes choses semblaient vivantes, luisantes dans l’ombre crépusculaire du contact qui les faisait se toucher, un monde où chaque chose n’était pas seulement une individualité isolée prise au piège de la lumière diurne; où chaque chose apparaissait en son clair contour, visuellement, mais qui du sein de sa clarté même était reliée par des affinités émotionnelles ou vitales à d’autres choses étranges, une chose surgissant d’une autre, mentalement contradictoires qui fusionnaient dans l’émotion, si bien qu’un lion pouvait au même instant être aussi une chèvre, et ne pas être une chèvre [Lawrence a évoqué précédemment la chimère en bronze d’Arezzo, conservée au musée de Florence et qui fut en partie restaurée par Benvenuto Cellini)» (p. 142).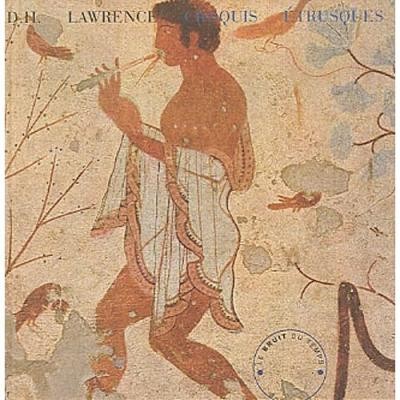 C’est dans un chapitre inachevé, resté à l’état de manuscrit et qui, peut-être, eût pu servir à Lawrence de conclusion pour ses Croquis étrusques, intitulé Le musée de Florence, que l’auteur va systématiser ses intuitions sur le thème d’une déperdition, au travers des siècles, d’une force rayonnante qui s’échappe désormais inéluctablement des œuvres des hommes. Ainsi, selon Lawrence, nous devons bien comprendre que les religions elles-mêmes de nos ancêtres les plus magnifiques, comme le sont, à ses yeux, les Étrusques, ne sont que des bribes d’un savoir immémorial ayant précédé les plus anciennes civilisations : «Ce qu’il nous faut saisir lorsque nous contemplons des œuvres étrusques, c’est que celles-ci nous révèlent les derniers feux d’une conscience cosmique humaine – disons, la tentative d’hommes aspirant à la conscience cosmique – différente de la nôtre. L’idée qui veut que notre histoire soit issue des cavernes ou de précaires habitats lacustres est puérile. Notre histoire prend corps à l’achèvement d’une phase précédente de l’histoire humaine, une phase prodigieuse et comparable à la nôtre. Il est bien plus vraisemblable que le singe descende de nous que nous du singe» (p. 225). Renversement de perspective qui a dû faire bondir les esprits scientistes ou chagrins, c’est tout un, qui lurent les Croquis étrusques lorsqu’ils furent publiés ! On se demande même comment l’auteur n’a semble-t-il pas été traité de réactionnaire. Il l’a peut-être été, à la réflexion, tout comme on n’a pas manqué de lui reprocher son manque de sérieux scientifique (cf. la réception du livre, pp. 272-278). Citons donc longuement ce très beau passage, toujours extrait du même texte qui ne fut pas recueilli en livre par Lawrence, où il semble sérieusement douter de la théorie de l’évolution, l’homme ayant toujours été un homme, l’homme ne provenant pas du singe comme nous l’avons vu mais l’homme, pourtant, depuis qu’il s’est coupé de ses plus profondes racines de savoir symbolique, paraissant en revanche devoir dégénérer, dévoluer : «Les civilisations apparaissent comme des vagues, et comme des vagues elles s’évanouissent. Tant que la science, ou l’art, n’aura pu saisir le sens dernier de ces symboles flottant sur l’ultime vague de la période préhistorique, c’est-à-dire cette période qui précède la nôtre, nous ne serons pas en mesure d’instituer la juste relation avec l’homme en ce qu’il est, en ce qu’il fut, en ce que toujours il sera.
C’est dans un chapitre inachevé, resté à l’état de manuscrit et qui, peut-être, eût pu servir à Lawrence de conclusion pour ses Croquis étrusques, intitulé Le musée de Florence, que l’auteur va systématiser ses intuitions sur le thème d’une déperdition, au travers des siècles, d’une force rayonnante qui s’échappe désormais inéluctablement des œuvres des hommes. Ainsi, selon Lawrence, nous devons bien comprendre que les religions elles-mêmes de nos ancêtres les plus magnifiques, comme le sont, à ses yeux, les Étrusques, ne sont que des bribes d’un savoir immémorial ayant précédé les plus anciennes civilisations : «Ce qu’il nous faut saisir lorsque nous contemplons des œuvres étrusques, c’est que celles-ci nous révèlent les derniers feux d’une conscience cosmique humaine – disons, la tentative d’hommes aspirant à la conscience cosmique – différente de la nôtre. L’idée qui veut que notre histoire soit issue des cavernes ou de précaires habitats lacustres est puérile. Notre histoire prend corps à l’achèvement d’une phase précédente de l’histoire humaine, une phase prodigieuse et comparable à la nôtre. Il est bien plus vraisemblable que le singe descende de nous que nous du singe» (p. 225). Renversement de perspective qui a dû faire bondir les esprits scientistes ou chagrins, c’est tout un, qui lurent les Croquis étrusques lorsqu’ils furent publiés ! On se demande même comment l’auteur n’a semble-t-il pas été traité de réactionnaire. Il l’a peut-être été, à la réflexion, tout comme on n’a pas manqué de lui reprocher son manque de sérieux scientifique (cf. la réception du livre, pp. 272-278). Citons donc longuement ce très beau passage, toujours extrait du même texte qui ne fut pas recueilli en livre par Lawrence, où il semble sérieusement douter de la théorie de l’évolution, l’homme ayant toujours été un homme, l’homme ne provenant pas du singe comme nous l’avons vu mais l’homme, pourtant, depuis qu’il s’est coupé de ses plus profondes racines de savoir symbolique, paraissant en revanche devoir dégénérer, dévoluer : «Les civilisations apparaissent comme des vagues, et comme des vagues elles s’évanouissent. Tant que la science, ou l’art, n’aura pu saisir le sens dernier de ces symboles flottant sur l’ultime vague de la période préhistorique, c’est-à-dire cette période qui précède la nôtre, nous ne serons pas en mesure d’instituer la juste relation avec l’homme en ce qu’il est, en ce qu’il fut, en ce que toujours il sera. GIANFRANCO MIGLIO
GIANFRANCO MIGLIO «Je hais ce livre. Je le hais de tout mon coeur. Il m’a donné la gloire, cette pauvre chose qu’on appelle la gloire, mais il est en même temps à l’origine de toutes mes misères. Pour ce livre, j’ai connu de longs mois de prison, (...) de persécutions policières aussi mesquines que cruelles. Pour ce livre, j’ai connu la trahison des amis, la mauvaise foi des ennemis, l’égoïsme et la méchanceté des hommes. C’est de ce livre qu’a pris naissance la stupide légende qui fait de moi un être cynique et cruel, cette espèce de Machiavel déguisé en cardinal de Retz que l’on aime voir en moi». Ces quelques lignes, écrites par Curzio Malaparte en introduction à son célèbre essai Technique du coup d’Etat, l’auteur de La désintégration du système, Giorgio Freda, aurait pu les faire siennes. Car, pour avoir rédigé cette modeste brochure qui, en une soixantaine de pages très denses, sape à la base le système bourgeois, ce jeune éditeur a subi des années de persécutions judiciaires et mediatiques.
«Je hais ce livre. Je le hais de tout mon coeur. Il m’a donné la gloire, cette pauvre chose qu’on appelle la gloire, mais il est en même temps à l’origine de toutes mes misères. Pour ce livre, j’ai connu de longs mois de prison, (...) de persécutions policières aussi mesquines que cruelles. Pour ce livre, j’ai connu la trahison des amis, la mauvaise foi des ennemis, l’égoïsme et la méchanceté des hommes. C’est de ce livre qu’a pris naissance la stupide légende qui fait de moi un être cynique et cruel, cette espèce de Machiavel déguisé en cardinal de Retz que l’on aime voir en moi». Ces quelques lignes, écrites par Curzio Malaparte en introduction à son célèbre essai Technique du coup d’Etat, l’auteur de La désintégration du système, Giorgio Freda, aurait pu les faire siennes. Car, pour avoir rédigé cette modeste brochure qui, en une soixantaine de pages très denses, sape à la base le système bourgeois, ce jeune éditeur a subi des années de persécutions judiciaires et mediatiques. Mais Giorgio Freda est avant tout l’homme d’un texte. Et quel texte ! Il s’agit de La désintégration du système, qui voit le jour en 1969, en pleine contestation étudiante. L’Italie subit alors, non une explosion soudaine et aussi vite retombée comme en France, mais un «mai rampant». Convaincu de l’impérieuse nécessité d’une subversion radicale du monde bourgeois, Freda estime que tout doit être tenté, au moment où beaucoup de jeunes cherchent à donner un contenu véritablement révolutionnaire à la révolte étudiante, pour éviter que celle-ci ne soit récupérée par les tenants de l’orthodoxie marxiste ou du réformisme social-démocrate. C’est à ces jeunes que s’adresse La désintégration du système, qui loin d’être le programme personnel du seul Freda, synthétise des exigences communes à tout un milieu national-révolutionnaire, de Giovane Europa à Lotta di Popolo.
Mais Giorgio Freda est avant tout l’homme d’un texte. Et quel texte ! Il s’agit de La désintégration du système, qui voit le jour en 1969, en pleine contestation étudiante. L’Italie subit alors, non une explosion soudaine et aussi vite retombée comme en France, mais un «mai rampant». Convaincu de l’impérieuse nécessité d’une subversion radicale du monde bourgeois, Freda estime que tout doit être tenté, au moment où beaucoup de jeunes cherchent à donner un contenu véritablement révolutionnaire à la révolte étudiante, pour éviter que celle-ci ne soit récupérée par les tenants de l’orthodoxie marxiste ou du réformisme social-démocrate. C’est à ces jeunes que s’adresse La désintégration du système, qui loin d’être le programme personnel du seul Freda, synthétise des exigences communes à tout un milieu national-révolutionnaire, de Giovane Europa à Lotta di Popolo.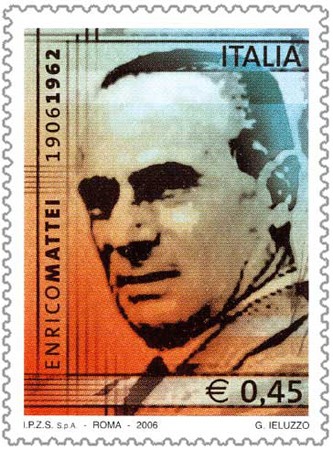
 La politique autonome de l’ENI s’est adressée surtout aux pays du Proche et du Moyen Orient et d’Afrique du Nord. L’Iran fut évidemment l’exemple le plus prestigieux dans le palmarès du groupe italien, qui était parvenu à s’insinuer dans un pays considéré comme chasse gardée et exclusive de la « British Petroleum ». Mais il y eut aussi l’Egypte de Nasser : elle fut le premier pays avec lequel Mattei amorça des rapports stables et durables, dès 1956. Il faut aussi évoquer l’appui financier qu’accorda Mattei au Front de Libération National algérien, ce qui irrita bien entendu la France, dont la classe dirigeante s’était faite à l’idée de perdre ses territoires d’Outremer. Les rapports entre l’ENI et le FNL étaient de fait assez étroits : le chef politique du mouvement indépendantiste algérien, Mohammed Ben Bella, avait un appartement à sa disposition à Rome.
La politique autonome de l’ENI s’est adressée surtout aux pays du Proche et du Moyen Orient et d’Afrique du Nord. L’Iran fut évidemment l’exemple le plus prestigieux dans le palmarès du groupe italien, qui était parvenu à s’insinuer dans un pays considéré comme chasse gardée et exclusive de la « British Petroleum ». Mais il y eut aussi l’Egypte de Nasser : elle fut le premier pays avec lequel Mattei amorça des rapports stables et durables, dès 1956. Il faut aussi évoquer l’appui financier qu’accorda Mattei au Front de Libération National algérien, ce qui irrita bien entendu la France, dont la classe dirigeante s’était faite à l’idée de perdre ses territoires d’Outremer. Les rapports entre l’ENI et le FNL étaient de fait assez étroits : le chef politique du mouvement indépendantiste algérien, Mohammed Ben Bella, avait un appartement à sa disposition à Rome.





 The Futurists were contemptuous of all tradition, of all that is past:
The Futurists were contemptuous of all tradition, of all that is past:





 N.S.
N.S.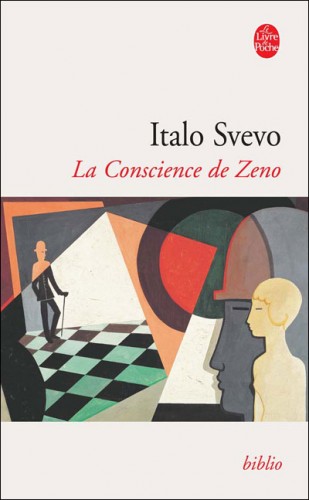 Così, nel sembrare un pessimista di natura, cerca nei suoi personaggi la chiave per descrivere l’uomo che cade in piedi. Che non è semplice, perché se cadi il segno di un livido ti rimane, cadendo e rimanendo in piedi il dolore lo senti solo dentro. Non è fisico, è solo mentale. Alfonso Nitti, bancario che lascia la mamma e si ritrova in una città che non sembra appartenergli, a cui non vuole appartenere, il personaggio di Una vita ricalca l’archetipo del debole, di colui che si arrende all’amore perché non è amato dalla donna che vorrebbe, che si arrende alla perfezione e alla cura estetica del collega che lo snerva nel suo essere borghese e arrivista, si arrende alla distanza inevitabile del suo capo, il Maller. Solo la morte per quanto crudele e distante, riuscirà ad avvicinarlo alla perfezione della vita, ma questo nemmeno servirà ad sentire più vicini quelli che lui considerava mal volentieri “colleghi”."La Banca Maller, in puro stile burocratico, annuncia un funerale che avviene con l’intervento dei colleghi e della direzione" (Una vita). Alfonso, che si dà colpe non sue, scriverà alla mamma: “Non credere, mamma, che qui si stia tanto male; sono io che ci sto male”. Non faceva nulla e quel nulla lo portava ad avere un’inerzia totale dinnanzi alle cose. Non era stanco, era solo annoiato. Tutti i giorni lì su quella sedia, tutti i giorni a subire e non capire, tutti i giorni un pezzo di vita che si vedeva portar via, ma la cosa assurda è che mentre gli altri “sembravano” contenti di vivere così, Alfonso era contento di non vivere. Avrà ragione Joyce a dire che nella penna di un uomo c’è un solo romanzo e che quando se ne scrivono diversi si tratta sempre del medesimo più o meno trasformato. Così da Una Vita si passa alla Coscienza di Zeno, che nel 1924 Svevo spedisce al suo ormai amico Joyce, trasferitosi a Trieste e suo professore di inglese che Livia Veneziani Svevo descriverà così: “Fra il maestro, oltremodo irregolare, ma d’altissimo ingegno e lo scolaro d’eccezione le lezioni si svolgevano con un andamento fuori dal comune”. Joyce, entusiasta del suo “allievo”, fa conoscere il manoscritto in Francia dove verrà pubblicato. In Italia sarà per merito di Eugenio Montale, sulle pagine della rivista L’Esame, che Svevo riuscirà ad avere la prima notorietà. Zeno Cosini che cerca di guarire da una malattia non ancora ben definita ed inizia il percorso psicoanalitico presso il Dottor S. Dottore che, per quanto poco si sforzi di capire il problema, non riuscirà a farlo e nel momento dell’abbandono della terapia da parte di Zeno si vendicherà pubblicando le memorie del suo paziente con la speranza che questo gli procuri dolore. Ma Zeno, che è più impegnato ad amare la sua sigaretta non farà altro che ridere e deridere il suo analista.
Così, nel sembrare un pessimista di natura, cerca nei suoi personaggi la chiave per descrivere l’uomo che cade in piedi. Che non è semplice, perché se cadi il segno di un livido ti rimane, cadendo e rimanendo in piedi il dolore lo senti solo dentro. Non è fisico, è solo mentale. Alfonso Nitti, bancario che lascia la mamma e si ritrova in una città che non sembra appartenergli, a cui non vuole appartenere, il personaggio di Una vita ricalca l’archetipo del debole, di colui che si arrende all’amore perché non è amato dalla donna che vorrebbe, che si arrende alla perfezione e alla cura estetica del collega che lo snerva nel suo essere borghese e arrivista, si arrende alla distanza inevitabile del suo capo, il Maller. Solo la morte per quanto crudele e distante, riuscirà ad avvicinarlo alla perfezione della vita, ma questo nemmeno servirà ad sentire più vicini quelli che lui considerava mal volentieri “colleghi”."La Banca Maller, in puro stile burocratico, annuncia un funerale che avviene con l’intervento dei colleghi e della direzione" (Una vita). Alfonso, che si dà colpe non sue, scriverà alla mamma: “Non credere, mamma, che qui si stia tanto male; sono io che ci sto male”. Non faceva nulla e quel nulla lo portava ad avere un’inerzia totale dinnanzi alle cose. Non era stanco, era solo annoiato. Tutti i giorni lì su quella sedia, tutti i giorni a subire e non capire, tutti i giorni un pezzo di vita che si vedeva portar via, ma la cosa assurda è che mentre gli altri “sembravano” contenti di vivere così, Alfonso era contento di non vivere. Avrà ragione Joyce a dire che nella penna di un uomo c’è un solo romanzo e che quando se ne scrivono diversi si tratta sempre del medesimo più o meno trasformato. Così da Una Vita si passa alla Coscienza di Zeno, che nel 1924 Svevo spedisce al suo ormai amico Joyce, trasferitosi a Trieste e suo professore di inglese che Livia Veneziani Svevo descriverà così: “Fra il maestro, oltremodo irregolare, ma d’altissimo ingegno e lo scolaro d’eccezione le lezioni si svolgevano con un andamento fuori dal comune”. Joyce, entusiasta del suo “allievo”, fa conoscere il manoscritto in Francia dove verrà pubblicato. In Italia sarà per merito di Eugenio Montale, sulle pagine della rivista L’Esame, che Svevo riuscirà ad avere la prima notorietà. Zeno Cosini che cerca di guarire da una malattia non ancora ben definita ed inizia il percorso psicoanalitico presso il Dottor S. Dottore che, per quanto poco si sforzi di capire il problema, non riuscirà a farlo e nel momento dell’abbandono della terapia da parte di Zeno si vendicherà pubblicando le memorie del suo paziente con la speranza che questo gli procuri dolore. Ma Zeno, che è più impegnato ad amare la sua sigaretta non farà altro che ridere e deridere il suo analista. Stupida come cosa, ma immediatamente riuscii a capire il veleno che ti attraversa le vene, riuscii a capire quanto sia debole un uomo dinnanzi ad un vizio, che non ti serve, che non è utile, che è dannoso, ma diventa vitale. E più di tutto mi impressionò in Zeno il tentativo di voler smettere e la volontà certa di non farlo mai. Il medico della casa di cura dove venne “rinchiuso” per smettere di fumare gli dice:"Non capisco perché lei, invece di cessare di fumare, non si sia piuttosto risolto di diminuire il numero delle sigarette che fuma". Il non averci mai pensato di Zeno risulta l’immagine migliore del romanzo, il dolore che vivi dallo stacco brutale da un qualcosa a cui sei morbosamente legato ti ripaga dell’amore per cui morbosamente sei legato a quella cosa. Così o si rinuncia in maniera totale o non si rinuncia. Così Zeno passerà ogni sera ad annotare una U.S, un’ultima sigaretta mai spenta.
Stupida come cosa, ma immediatamente riuscii a capire il veleno che ti attraversa le vene, riuscii a capire quanto sia debole un uomo dinnanzi ad un vizio, che non ti serve, che non è utile, che è dannoso, ma diventa vitale. E più di tutto mi impressionò in Zeno il tentativo di voler smettere e la volontà certa di non farlo mai. Il medico della casa di cura dove venne “rinchiuso” per smettere di fumare gli dice:"Non capisco perché lei, invece di cessare di fumare, non si sia piuttosto risolto di diminuire il numero delle sigarette che fuma". Il non averci mai pensato di Zeno risulta l’immagine migliore del romanzo, il dolore che vivi dallo stacco brutale da un qualcosa a cui sei morbosamente legato ti ripaga dell’amore per cui morbosamente sei legato a quella cosa. Così o si rinuncia in maniera totale o non si rinuncia. Così Zeno passerà ogni sera ad annotare una U.S, un’ultima sigaretta mai spenta. Nel 1997 Gualtiero Ciola pubblicava un’opera, poi ristampata, che costituiva un originale punto di riferimento per un’adeguata considerazione delle origini etniche dei popoli italiani. Nel suo corposo studio Noi, Celti e Longobardi, Ciola analizza le testimonianze archeologiche e linguistiche che hanno segnato il territorio della penisola italica, fornendo utili indicazioni per seguire nuovi percorsi di ricerca.
Nel 1997 Gualtiero Ciola pubblicava un’opera, poi ristampata, che costituiva un originale punto di riferimento per un’adeguata considerazione delle origini etniche dei popoli italiani. Nel suo corposo studio Noi, Celti e Longobardi, Ciola analizza le testimonianze archeologiche e linguistiche che hanno segnato il territorio della penisola italica, fornendo utili indicazioni per seguire nuovi percorsi di ricerca. Das 20. Jahrhundert bot geistigen Abenteurern Entfaltungsmöglichkeiten, von denen wir Heutige angesichts einer »verwalteten Welt« nur träumen können. Eine dieser abenteuerlichen Biographien des letzten Jahrhunderts hatte der italienische Dichter, Krieger und Nationalist Gabriele D’Annunzio (1863–1938). Beeinflußt von der Lebensphilosophie Friedrich Nietzsches, eroberte er nach Ende des Ersten Weltkriegs handstreichartig die Adriastadt Fiume und errichtete eine nationalistische Herrschaft des totalen Lebens.
Das 20. Jahrhundert bot geistigen Abenteurern Entfaltungsmöglichkeiten, von denen wir Heutige angesichts einer »verwalteten Welt« nur träumen können. Eine dieser abenteuerlichen Biographien des letzten Jahrhunderts hatte der italienische Dichter, Krieger und Nationalist Gabriele D’Annunzio (1863–1938). Beeinflußt von der Lebensphilosophie Friedrich Nietzsches, eroberte er nach Ende des Ersten Weltkriegs handstreichartig die Adriastadt Fiume und errichtete eine nationalistische Herrschaft des totalen Lebens.
 The pages devoted to Spengler in The Path of Cinnabar are thus quite critical; Evola even concludes that the influence of Spengler on his thought was null. Such is not the opinion of an analyst of Spengler and Evola, Attilio Cucchi (in “Evola, Tradizione e Spengler,” Orion no. 89, 1992). For Cucchi, Spengler influenced Evola, particularly in his criticism of the concept of the “West”: by affirming that Western civilization is not the civilization, the only civilization there is, Spengler relativizes it, as Guénon charges. Evola, an attentive reader of Spengler and Guénon, would combine elements of the the Spenglerian and Guénonian critiques. Spengler affirms that Faustian Western culture, which began in the tenth century, has declined and fallen into Zivilisation, which has frozen, drained, and killed its inner energy. America is already at this final stage of de-ruralized and technological Zivilisation.
The pages devoted to Spengler in The Path of Cinnabar are thus quite critical; Evola even concludes that the influence of Spengler on his thought was null. Such is not the opinion of an analyst of Spengler and Evola, Attilio Cucchi (in “Evola, Tradizione e Spengler,” Orion no. 89, 1992). For Cucchi, Spengler influenced Evola, particularly in his criticism of the concept of the “West”: by affirming that Western civilization is not the civilization, the only civilization there is, Spengler relativizes it, as Guénon charges. Evola, an attentive reader of Spengler and Guénon, would combine elements of the the Spenglerian and Guénonian critiques. Spengler affirms that Faustian Western culture, which began in the tenth century, has declined and fallen into Zivilisation, which has frozen, drained, and killed its inner energy. America is already at this final stage of de-ruralized and technological Zivilisation.
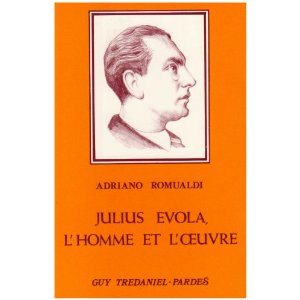
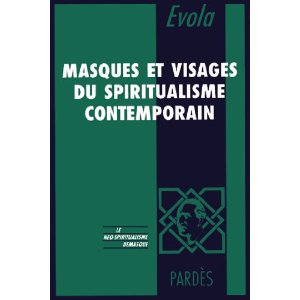
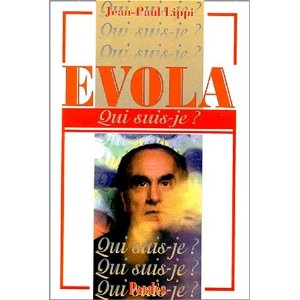
 A young Italian nationalist leads his followers on a march through Rome, seizing power from corrupt elites to establish a palingenetic regime. Declaring himself Tribune, his ultimate aim is to recreate the power and glory of Ancient Rome. However, a conspiracy of his enemies topples him from power, and he is imprisoned. Eventually, the most powerful man in the West frees him and restores him to power — albeit as leader of a puppet regime. His second attempt at Italian rebirth is cut short; he is captured, killed, and his body desecrated by the howling mob. A man who had attempted to drive his degenerate countrymen to fulfill a higher destiny is cut down by the unthinking masses — a cowardly herd who lacked the ability to comprehend, much less work towards, this leader’s dreams of glory.
A young Italian nationalist leads his followers on a march through Rome, seizing power from corrupt elites to establish a palingenetic regime. Declaring himself Tribune, his ultimate aim is to recreate the power and glory of Ancient Rome. However, a conspiracy of his enemies topples him from power, and he is imprisoned. Eventually, the most powerful man in the West frees him and restores him to power — albeit as leader of a puppet regime. His second attempt at Italian rebirth is cut short; he is captured, killed, and his body desecrated by the howling mob. A man who had attempted to drive his degenerate countrymen to fulfill a higher destiny is cut down by the unthinking masses — a cowardly herd who lacked the ability to comprehend, much less work towards, this leader’s dreams of glory.




